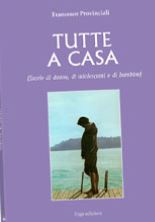
Il Roggione*
Era stato il vento dell’Est a portare Maruska sulle nostre strade ed era una storia uguale a molte altre: il miraggio di una vita migliore, il gusto dell’avventura, l’ottimismo sul destino che l’attendeva, così estraneo ai sentimenti che finora aveva provato nel suo paese dove l’unica certezza era la miseria e l’unica speranza consisteva nell’andare via.
Non aveva voluto neanche sentirle, quelle voci che arrivavano da lontano e che parlavano di cose andate male, di botte, di sfortuna, di ragazze tornate sconfitte e di quelle di cui non si era più saputo niente e che forse non sarebbero tornate più.
Lei era convinta che tutto quello che l’avrebbe riguardata sarebbe stato diverso: un lavoro onesto, i soldi da mandare con orgoglio a casa, magari l’incontro con un uomo per bene, una famiglia, l’altra faccia di quella vita grigia e perdente che finora l’aveva resa infelice e dimenticata.
Queste cose pensava Maruska salendo su quella rovente corriera, insieme ad altre compagne di viaggio e di sventure, su uno di quegli autobus alti e polverosi, grigi e anonimi, con le targhe tutte uguali, che portano persone e scarrozzano speranze.
Dopo pochi giorni dall’arrivo a Milano molti di quei pensieri erano già svaniti, sostituiti da una realtà fatta di salite e discese su altri mezzi di trasporto, su treni, autobus e metrò che avevano destinazioni impreviste e scomode, da nascondigli furtivi e senza un perchè, dagli odori della promiscuità, dai giacigli di quelle stanze strette dove si doveva far posto ad altre persone, sempre nuove e diverse.
Erano gli uomini a comandare, in quei posti maledetti, insieme a poche donne più anziane di lei, a dire quando si doveva entrare e quando si poteva uscire.
Maruska pensava che poi sarebbe stata meglio, capiva anche lei che in un paese straniero ci potevano essere delle difficoltà: era stata abituata ad ubbidire e anche adesso, in mezzo a quel via vai non aveva altra scelta che eseguire quello che le veniva in malo modo ordinato.
Una cosa l’aveva capita bene: non importava che si chiamasse Maruska, il suo nome serviva solo per essere chiamata ma non doveva dirlo a nessuno: per ogni cosa, per ogni necessità doveva rivolgersi a quei due o tre tipi che andavano e venivano da quelle case a tutte le ore, gli unici che potevano farlo liberamente, che avevano in tasca le chiavi della porta di ingresso.
La compagnia delle amiche con cui aveva condiviso il viaggio si era assottigliata, alcune avevano preso altre destinazioni, dov’era lei erano rimaste in poche.
Poi un giorno era venuto Ivan a prenderla e a portarla via, solo lei: le aveva detto di salire su un’auto e di non fare domande, l’avrebbe condotta in una casa sua e poi a lavorare.
Doveva fidarsi, Maruska, non aveva altra scelta: sarebbe stata sola d’ora in poi ma forse avrebbe realizzato qualcuno dei suoi desideri.
Era a quel punto impaziente di arrivare, anche se non sapeva nulla di quelle strade che scorrevano veloci dal finestrino, di quelle vie tutte uguali e larghe, dagli incroci squadrati, di quei palazzi alti e anonimi, di quelle luci e di quelle insegne che lei scorgeva rannicchiata e incredula: notava solo quanto tutto intorno a lei fosse così grande e diverso dal suo piccolo paese, dove tutti si conoscevano e si chiamavano per nome.
L’appartamento dov’era stata condotta era freddo e squallido, al quinto piano di un condominio fatto a scatola, con tanti minuscoli balconi e molti panni stesi.
Stanze piccole, disadorne, logore che mostravano i segni di un’usura dovuta più al consumo e agli innumerevoli passaggi che al tempo.
Maruska aveva sistemato le sue poche cose nella cameretta che le era stata indicata: un letto, un armadio, un comodino, pareti disadorne e consunte.
Ivan non l’aveva importunata, quella sera, come lei temeva: era uscito in malo modo lasciando una puzza insopportabile di fumo in casa e lei si era addormentata prima che lui rincasasse a notte fonda.
Nonostante fosse stanchissima aveva faticato a prender sonno, divisa tra i pensieri su quello che aveva lasciato – il suo paese, la sua famiglia, gli incontri più recenti – e quello che l’aspettava e di cui fantasticava ad occhi aperti, seguendo le luci e le ombre delle auto di passaggio rifratte sul soffitto.
Si era assopita così, nel dormiveglia del rimuginare pensieroso e nei chiaroscuri di quei bagliori, più veloci di un battere di ciglia.
Ivan l’aspettava in cucina, il mattino dopo: in casa non c’era nulla di commestibile, il frigo vuoto.
Erano andati a far colazione, impiastricciati degli odori della notte, al bar sottocasa e poi via, a fare acquisti al supermercato.
Maruska si domandava perché non si intavolasse il discorso sul lavoro, perché Ivan non l’accompagnasse in un ufficio, da una famiglia, in un negozio ma non osava chiedere niente: lui era un tipo scorbutico, spiccio, di poche manfrine.
Il fatto che l’avesse fatta vestire tutta di nuovo, da capo a piedi, in un centro commerciale l’aveva messa di buon umore: di certo – pensava – devo rendermi presentabile.
Solo verso sera lui le aveva accennato qualcosa, dicendo che l’avrebbe condotta lui di lì a poco sul posto di lavoro.
Poi le aveva raccomandato di non fornire e non chiedere troppe spiegazioni, di non dare confidenze, di limitarsi a fare quello che le sarebbe stato chiesto, ricordandosi di farsi pagare la cifra che lui aveva stabilito.
Ivan sarebbe stato in auto lì, nei paraggi, per assisterla e vigilarla: si poteva andare a notte fonda, ci avrebbe pensato lui a riportarla a casa.
Qualcosa Maruska aveva intuito ma si sarebbe di lì a breve accorta di non aver immaginato abbastanza.
A vederla così, vestita di nuovo e impaziente come una giovane ragazza innamorata che va al suo appuntamento del cuore, era proprio un fiore da cogliere ma solo il destino quella sera poteva stabilire chi avrebbe strappato il primo petalo.
A quella volta ne seguirono molte altre, nella corolla non restavano altri petali e anche il fiore era stato reciso.
Maruska aveva imparato tutto: i luoghi, le movenze, le attese, gli incontri, gli accordi, i ritorni.
Ivan la scrutava come un felino acquattato, come una faina che vede lontano, anche nel buio della notte e la guidava con la sapiente regia di chi sa maneggiare il telecomando di un modellino di aeroplano: sempre appostato e vigile, possessivo, attento, spietato.
Faceva parte anche lui delle presenze effimere di quelle notti in pianura, dove tutto svanisce e si materializza improvvisamente nella nebbia, dove tu vedi solo ciò che ti circonda ma avverti respiri lontani e inquietanti.
Ben prima che arrivasse l’alba veniva il momento di smettere, era Ivan che dava il segnale.
All’afrore di quei minuscoli fuochi che si spegnavano lentamente subentravano gli odori della campagna: di fieno, di stalla, di bestie, di erba, mischiati ai rumori della natura che lentamente si stava svegliando, avvolta come sempre nella coltre impalpabile e pungente delle mattine in Lomellina.
Con fatica era riuscita ad abituarsi a rovesciare la sua vita, Maruska: dormire di giorno e lavorare di notte.
Possedeva infatti la vitalità esuberante di una ragazza di ventidue anni che finora aveva dedicato le giornate ai mestieri di casa e le notti ai sogni.
Cercava di rimuovere l’umiliazione di quel lavoro che consumava la sua persona: chi sta in compagnia della sofferenza trova d’istinto un motivo per sopravvivere.
Accettava di usare il proprio corpo per aiutare la famiglia, soprattutto la madre e i numerosi fratelli, visto che suo padre si era dimostrato proprio con lei più un animale che un uomo.
Poi, un giorno, si era accorta di essere rimasta incinta.
Aveva attribuito un certo malessere alla stanchezza per quelle notti così movimentate e dense di incontri sempre diversi: una ragazza bella e giovane come lei, di ‘carne fresca’ come si dice per i maiali, faceva certamente gola ai maiali veri che si aggirano di notte per liberarsi della loro voglia e, a volte, cercano in quell’abbraccio un conforto, affidano a quel gesto l’abbandono della loro disperazione.
Era accaduto poco tempo dopo quella prima sera, forse per dimenticanza o per inesperienza.
Ivan le aveva fatto fare il test ed era risultato positivo ma l’aveva viscidamente rassicurata: “c’è rimedio”, le aveva detto.
Così, l’aveva portata ben presto in ospedale per abortire: pochi giorni per levare quell’ingombro e poi riprendere l’attività.
Forse era già successo con altre ragazze e lui metteva in conto una possibile reazione emotiva di Maruska, per questo si mostrava così stranamente premuroso con lei, voleva concludere in fretta.
Anche la sera del suo ricovero, a Maruska, mentre aspettava ansiosamente di incontrare una notte diversa da quelle a cui era stata abituata, era capitato di fissare intensamente il soffitto di quella stanza: più bianco, più alto, come uno schermo dove proiettare il film della sua vita.
Velocemente aveva passato in rassegna tutti i fotogrammi di ciò che ricordava: la sua vecchia e povera casa, gli affetti, le speranze, l’inganno, la desolazione fino a quella sorpresa finale che l’aveva resa improvvisamente donna e futura madre.
Un istintivo senso di protezione verso quella vita inattesa l’aveva più sicura, cercava di respirare profondamente per contenere i battiti del suo cuore.
Poi aveva deciso.
Era scappata dall’ospedale approfittando di un momento di distrazione degli infermieri ma ben presto Ivan, che la braccava come un segugio, l’aveva rintracciata per strada e l’aveva fatta salire in auto.
Aveva provato a ribellarsi, a dire e ripetere che quella cosa non la voleva più fare, a chiedere di essere rimandata a casa, a supplicare una pietà che il suo protettore non conosceva.
Urlava che avrebbe detto tutto, che sarebbe andata dalla polizia e questo aveva mandato letteralmente in bestia Ivan, che l’aveva schiaffeggiata ed era ripartito a tutto gas sbattendola sul sedile posteriore
Era stata poi trovata con la testa fracassata nel roggio di un fiumiciattolo, uno di quei tanti corsi d’acqua che rendono umida e ricca quella terra.
Uccisa a colpi di spranga, come aveva stabilito l’autopsia e quella notizia era stata riportata dai giornali locali.
“Giovane donna trovata morta sul greto di un corso d’acqua: delitto passionale o racket della prostituzione?”, aveva frettolosamente titolato il cronista.
Domanda destinata a rimanere insoluta ai più, una delle tante brutte faccende che succedono quando la gente per bene è a dormire, e risposta riservata agli addetti ai lavori, fascicolata nei polverosi scaffali di un commissariato di periferia.
Leggendola come altri, quella notizia, ero rimasto incuriosito da una particolare e fortuita coincidenza.
Qualche anno prima ero passato da quelle parti per un impegno di lavoro.
La persona che gentilmente mi stava accompagnando aveva accostato l’auto ai margini della strada per raccontarmi un aneddoto che riguardava il luogo in cui ci eravamo fermati.
All’epoca dell’impero austroungarico, in pieno Risorgimento, quando quelle terre e l’intera Lombardia ne facevano parte e gli austriaci erano considerati degli invasori, transitò proprio di lì un reggimento dei loro soldati.
Era sera e per non farsi scorgere dalle vedette appostate nelle nicchie dei campanili – collocazione strategica per avvistare i movimenti nemici – il capitano diede ordine di far accovacciare tutti i militari nel greto del fiume, in quel momento asciutto per via dell’azionamento della chiusa: avrebbero passato la notte lì, ben occultati dalle pareti di quell’avvallamento e dalle piante che ne circondavano il margine più alto.
Ma qualcuno, dal paese, era passato quatto quatto e aveva visto.
Allora era stato dato un ordine preciso al guardiano della chiusa: attendere la notte fonda e poi realizzare l’imboscata.
Così avvenne: con abituale destrezza il guardiano del “ruson” – il roggione – in piena notte azionò il movimento di levata della chiusa e un fiume d’acqua inondò in pochi minuti quel greto asciutto uccidendo i soldati dell’intero reggimento, più di cento uomini annegati senza scampo.
Il mio cortese accompagnatore mi spiegò che quel fatto ebbe vasta eco nel circondario e che l’autore dell’impresa fu celebrato e ricordato per lungo tempo come un eroe.
Questo tizio, il guardiano della chiusa, era un avo di chi mi avrebbe poi raccontato quella storia.
Pare che avesse trascorso il resto della sua vita roso e consumato dal rimorso di quel gesto: “i’ho masà tuch”- li ho ammazzati tutti – ripeteva a chi voleva convincerlo di aver compiuto un’impresa militare straordinaria, pentito com’era invece di aver agito contro persone inermi, che non potevano difendersi.
La coincidenza del luogo e la notizia di quel delitto dei giorni nostri mi avevano portato ad associare le due vicende.
Avevo pensato che i due personaggi, autori di quelle azioni così lontane nel tempo, erano proprio diversi in tutto: nelle motivazioni e nei sentimenti, nel prima e nel dopo.
Uno si era pentito, l’altro sicuramente no, il primo aveva metabolizzato quel gesto come una colpa da espiare almeno con la sofferenza interiore, il secondo se n’era fatta una ragione di lurido interesse: via una l’altra, qui o altrove poco importava.
Il vento dell’Est avrebbe condotto a lui altre disgraziate.
Un giorno qualunque ero poi tornato, per conto mio, in quel punto e mi ero soffermato a lungo a osservare ciò che vedevo intorno a me: i prati verdi, le piante alte e ondeggianti, l’acqua del roggione, calma nel suo lento passaggio, quasi immobile e stagnante.
Cercando di immaginare quegli episodi così diversi e lontani nel tempo, avevo d’istinto pensato che – a guardarci intorno – ogni cosa ci parla dei misteri della vita e della morte ma che tutto alla fine si ricompone in una imperscrutabile dignità.
*( un roggione è un corso d’acqua di pianura, spesso creato dall’uomo per irrigare i campi)…


