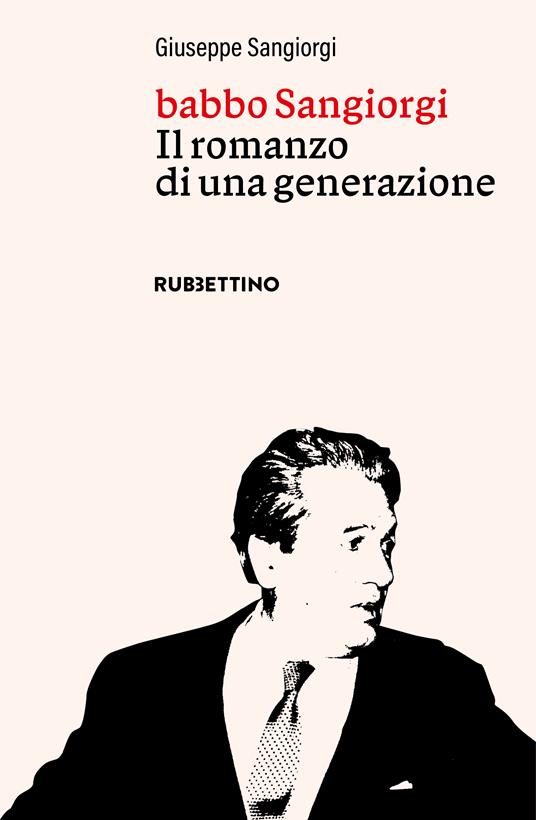È un autentico viaggio nel tempo il volume di Giuseppe Sangiorgi, Babbo Sangiorgi. Il romanzo di una generazione (Rubbettino, Roma 2024, pp. 182, € 15).
L’autore, Giuseppe Sangiorgi (Roma 1947), giornalista, è stato presidente dell’Istituto Luce, per il quale, fra le altre sue iniziative, ha curato la realizzazione de La Storia d’Italia del XX secolo, insieme a Valerio Castronovo, Renzo De Felice, Pietro Scoppola, per la regia di Folco Quilici, e de Il Vento del Concilio, con Luigi Accattoli, Vittorio Citterich, mons. Lorenzo Chiarinelli, per la regia di Leandro Castellani. Ma Sangiorgi ha fatto ed è stato anche molto altro: direttore del quotidiano “Il Popolo”, commissario dell’Autorità per lo garanzie nelle comunicazioni, segretario generale dell’Istituto Sturzo, ha pubblicato, fra gli altri suoi libri, Il romanzo del Popolo (Gangemi 2003), Piazza del Gesù, un diario politico (Monda-dori 2005); Rivoluzione Quirinale (Gaffi 2010); De Gasperi. Uno studio (Rubbettino 2014); Dossetti, la politica oltre (II Settimo Libro 2015).
Inoltre, venne designato come “portavoce” da Ciriaco De Mita quando quest’ultimo, nel 1982, divenne segretario della Dc. Giuseppe Sangiorgi, dunque, ha una conoscenza di prima mano della politica, dei meccanismi che la regolano e dei suoi protagonisti, che ha conosciuto da vicino.
Gli anni della guerra e di Azione Cattolica
Ma Babbo Sangiorgi è qualcosa di più, e di diverso: attraverso la figura del padre, Giovanni Sangiorgi, l’autore ci racconta la storia dell’Italia del Novecento, e di alcuni fra i suoi maggiori protagonisti.
In queste pagine, pertanto, troviamo in azione Alcide De Gasperi, papa Montini, Giulio Andreotti: tutti personaggi che Giovanni San-giorgi conobbe bene, data la sua attività pluridecennale. Egli, lungo l’arco della sua vita (1901-1988), fu militante cattolico dai tempi della Fuci del primo Novecento e dell’Azione Cattolica, giornalista dell'”Osservatore Romano”, antifascista e per questo spiato dalla polizia segreta di Mussolini, partigiano, artefice del “Popolo” clandestino nella Roma del 1943-44, e poi, nel Dopoguerra, dirigente nazionale delle attività artistiche della Dc, fondatore e segretario generale di un ente, i “Premi Roma”, con sede a Palazzo Barberini, che promosse per quarant’anni molte fra le maggiori iniziative culturali della Capitale ed ebbe a che fare con alcuni fra i più grandi artisti della seconda metà del Novecento.
Una vita pienissima, quella di Giovanni Sangiorgi, ricca di incontri con figure che hanno lasciato un segno nella Storia, e che comincia proprio con l’impegno nella Fuci e nell’Azione Cattolica: una fucina sia per la classe dirigente che sarebbe emersa dopo il Secondo conflitto mondiale, sia per una forma di antifascismo che fosse radicata nel senso dell’adesione ai valori del cristianesimo e dell’uomo. Per questo, i membri in vista dell’Azione Cattolica (la sola associazione che nel Ventennio fosse rimasta estranea a quelle emanazioni del Pnf, raggruppate nell’Opera Nazionale Balilla) erano oggetto di controllo da parte dell’Ovra, la polizia fascista.
Vita privata e impegno politico
Come annota Sangiorgi (p. 29), la Fuci, i Laureati Cattolici, l’Azione Cattolica sono movimenti che ancora esistono, certo, ma che hanno perso, per tanti motivi, quella presenza politica e quel ruolo educativo e formativo sui giovani svolto nella prima parte del Novecento, quando la loro presenza era davvero una spina nel fianco del regime fascista. In effetti, anche dopo il Concordato del 1929, l’Azione Cattolica restò terreno di scontro fra il regime e una Chiesa che non voleva né poteva rinunciare alla sua presenza nel campo dell’educazione giovanile; e per rivendicare questa attività apostolica, con il riservare ai vescovi la nomina dei dirigenti diocesani (da sottrarre quindi all’ingerenza fascista), Pio XI non aveva esitato a scrivere una lettera enciclica, Non abbiamo bisogno (1931).
C’è nel volume un episodio significativo, che dice la commistione di vita privata e impegno politico e insieme morale che ha sempre caratterizzato la vita di Giovanni Sangiorgi: nella primavera del 1944 morì di tosse convulsa – patologia gravissima per i neonati – una sorellina dell’autore, Agnese, di poche settimane. La bambina fu sepolta dentro il Vaticano. Il mesto corteo che dalla vicina casa dei Sangiorgi varcò l’ingresso di Sant’Anna fu anche l’occasione per il trasferimento di documenti compromettenti, per evitare il rischio di una perquisizione.
Già in precedenza, annota Sangiorgi, le bozze di pubblicazioni vietate venivano scambiate sotto gli occhi delle sentinelle tedesche, grazie per esempio a Luciana Segreto Amadei, austera nobildonna romana che conosceva bene il tedesco e, potendo rispondere adeguatamente ai soldati nella loro lingua, veniva lasciata passare Iei e le bozze nascoste nella sua borsa, insieme all’elenco ai redattori del “Popolo” clandestino. La storia della morte di Agnese Sangiorgi fa riflettere il fratello, decenni dopo, inducendolo a scrivere come, a causa delle crudeli necessità imposte dai tempi, «neppure la sofferenza cosi privata della morte di una figlia si poté rispettare, trasformando in altro il corteo funebre di una bambina» (p. 52).
La figura della madre
Il volume di Giuseppe Sangiorgi non si concentra solo sull’attività del padre, ma anche su quella della madre, ugualmente impegnata: così, a p. 164 troviamo il capitolo significativamente intitolato “1954, mamma in battaglia”. Sono passati quasi dieci anni dalla fine della guerra, e ormai, «superata la fase iniziale legata alla sopravvivenza, la politica prende la piega della lotta per il potere» (ibid.), specialmente in quel momento, in cui la stella di De Gasperi – lungo la cui linea i genitori di Sangiorgi si sono sempre mossi – si è offuscata.
Il nuovo segretario della sezione, approfittando di un periodo di malattia della madre di Sangiorgi, cerca dunque di estrometterla dall’incarico di delegata femminile; ma ella risponde con energia, indirizzando al collegio dei probiviri del partito una dettagliata ricostruzione delle sue attività, raccontate con impeto e tenacia. E l’impegno della madre dell’autore è sempre alto, a difesa della famiglia, non tanto di una idea di moralità da santino, ma quella forte della persona, che ne rispettasse l’integrità e la dignità. In questo senso, Sangiorgi ricorda l’attività della madre che si collega a quella di Luigi Gedda, già a capo dei Comitati Civici alle elezioni del 1948 e che sfocerà, insieme a tante altre sollecitazioni, nella istituzione, nel dicembre 1972, di una commissione d’inchiesta «sui mezzi finanziari e i profitti degli editori e divulgatori della stampa pornografica e periodica» (qui pp. 172-173). Come sottolinea Sangiorgi, «impressiona come le denunce degli anni Settanta di mamma proiettino la loro attualità tanti decenni dopo, in una società della comunicazione che dilata a dismisura strumenti, modalità, piattaforme trasmissive varie, attraverso cui diffondere ogni genere di messaggi che inducono alla violenza».
Libertà, dignità, cultura e fede
In un certo senso, è consolante comprendere come i propri genitori fossero nel giusto, anche se è desolante vedere che i tempi sembrano andare in tutt’altra direzione.
In una intervista rilasciata da Giuseppe Sangiorgi ad Antonio Monda per “Studi Cattolici” nel 2005, Sangiorgi, rievocando gli anni della “corazzata DC”, affermava:
All’epoca c’era ancora politica. Ricordo le assemblee, i congressi… non erano come quelli di oggi, rivolti per lo più ai quadri dei partiti, ma erano aperti alla base, competizioni “vere” il cui esito era spesso incerto fino all’ultimo. Quegli anni segnarono un momento “alto” della storia della Dc, una storia, come tutte quelle umane, ricca di luce e di ombre. Però devo dire che la Dc dei momenti migliori è stato un grande partito (…) Fu un partito popolare che si diede da fare concretamente per i bisogni della gente con un senso vero della democrazia che era, secondo la lezione di Aldo Moro, “il tempo della decisione”.
Quelli rievocati sembravano tempi lontanissimi nel 2005, immaginiamoci ora. Però, alla luce del clima intellettuale, politico e morale delineato, piace chiudere queste note di lettura con le parole stesse con cui Sangiorgi chiude il suo libro, ovvero con le parole che il padre scrisse su di sé per una campagna elettorale negli anni Cinquanta: «Sangiorgi ha lavorato sempre per la libertà, la dignità, la cultura, la fede cristiana in cui è nato e in cui vive da militante».
Per leggere il testo originale