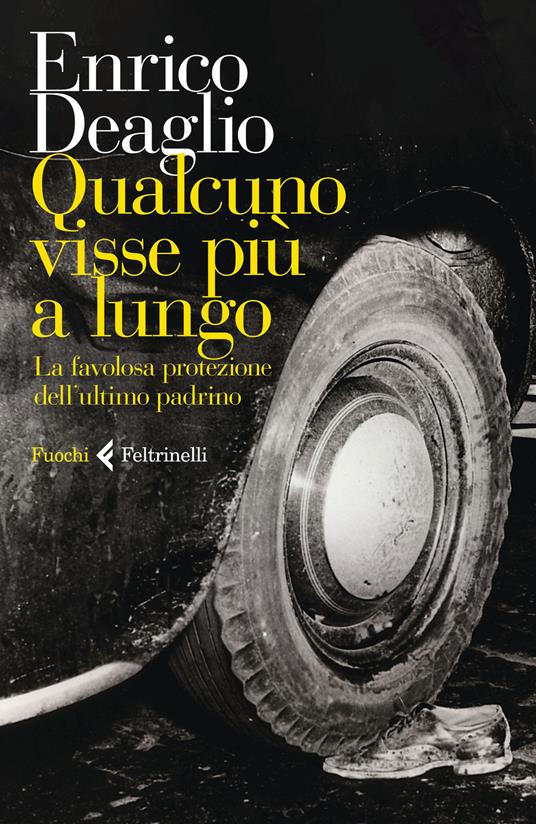La seconda di copertina del libro di Enrico Deaglio, “C’era una volta in Italia. Gli Anni Sessanta” riporta questa frase che, al di là degli accenti di parte propri della formazione politica dell’autore, è una vera e propria promessa di un’esperienza coinvolgente.
È un’opera che raccoglie un decennio di trasformazioni radicali, sia in Italia che nel mondo. Attraverso uno stile narrativo scorrevole, anche se dai contenuti spesso caratterizzati ideologicamente, Deaglio percorre i cambiamenti sociali, culturali e politici che caratterizzarono quel decennio: i personaggi della politica e dell’economia nazionale ed internazionale, l’ascesa dei movimenti di protesta, la rivoluzione sessuale, il boom economico italiano, le contraddizioni di una società in rapida evoluzione, la Chiesa del Concilio, ma anche la musica, la cinematografia, il costume, la cronaca nera, lo sport. Un concentrato di novità, di discontinuità con la società del dopoguerra, di tentativi di uscire dai due “blocchi contrapposti” di Yalta e una generazione che immaginò un cambiamento contraddistinto eccessivamente dall’utopia. Un diario di episodi e personaggi noti, ma anche di quotidianità e di storie di gente comune all’interno di una società in trasformazione, dei contrasti tra nord e sud del nostro Paese e delle inquietudini che scossero trasversalmente la comunità internazionale. Inoltre, l’autore si dimostra attento nel contestualizzare il ruolo dell’Italia all’interno di uno scenario più ampio, sottolineando l’influenza del panorama internazionale – dalla Guerra Fredda ai movimenti per i diritti civili negli Stati Uniti – sulla nostra comunità nazionale. Il suo approccio critico permette anche di riflettere sulle contraddizioni di quel periodo: il contrasto tra modernità e tradizione, l’emancipazione e le resistenze culturali.
Nel descrivere sul piano politico gli scenari tumultuosi di quegli anni, si riscontrano però dei limiti oggettivi di analisi da parte dell’autore, troppo condizionati dalla provenienza dai movimenti di estrema sinistra e spesso orientati al pregiudizio nei confronti dei governi democristiani e centristi, rendendo merito soltanto parzialmente ad alcune figure del cattolicesimo politico (Aldo Moro, Enrico Mattei, La Pira, Fiorentino Sullo, l’allora Sindaco di Napoli Vincenzo Palmieri). La stabilità assicurata alle Istituzioni e al funzionamento democratico dello Stato in quegli anni di grandi sommovimenti e di reazioni eversive, dalla saggezza e dalla determinazione del gruppo dirigente democristiano e degli altri partiti di governo del centrosinistra (PSI, PRI, PSDI e PLI), esperienza nata proprio nei primi anni Sessanta, non ha riscontro nella descrizione di un decennio affascinante e nello stesso tempo critico sul piano della vita democratica. Gruppi dirigenti, comunque, con un forte senso delle Istituzioni, garanti delle libertà fondamentali e in grado di mantenere equilibri fondamentali per le società democratiche e la necessaria autonomia in politica estera, pur nella lealtà alle alleanze internazionali.
Anche il commento sulla Chiesa cattolica risulta subordinato alle “appartenenze” o alle “categorie ecclesiali”: dal sottolineare l’indubbio merito di alcune figure uniche e carismatiche della Chiesa italiana (Don Milani, Don Albanesi, Padre Turoldo, etc…) o dall’esaltare alcune esperienze estreme come quelle di Don Mazzi, Dom Franzoni o Don Gallo, si tende poi ad un commento molto parziale sul pontificato di Paolo VI, che invece ebbe la capacità di assicurare il progressivo affermarsi del rinnovamento liturgico e dottrinale, evitando eccessi e dolorose spaccature nella comunità ecclesiale.
Se il fattore politico è il “fil rouge” del libro, l’episodio che lo apre risale al 2 gennaio 1960, la morte di Fausto Coppi, indimenticabile e indimenticato protagonista del ciclismo italiano, personaggio che riuscì, anche nel suo duello sportivo con Gino Bartali, ad inviare uno dei segnali positivi di orgoglio nazionale (non nazionalista) di un Paese in uscita dall’isolamento postbellico.
Da quel tragico evento, il testo poi ripercorre i fatti salienti del decennio sia in Italia che nel contesto internazionale: Adriano Olivetti e un diverso modo di concepire il capitalismo, la sfida per la conquista dello spazio, l’ “italiana” molecola della plastica, la crisi cubana e il rischio di una nuova guerra mondiale, il Concilio Vaticano Secondo e Papa Giovanni XXIII, Enrico Mattei e la sua misteriosa scomparsa, la visita di John Kennedy in Europa e il suo assassinio, i Beatles, la sconfitta dell’Italia ai mondiali di calcio con la Corea del Nord, l’alluvione di Firenze e gli “angeli del fango”, il mito di Che Guevara, la Popolorum Progressio e l’Humanae Vitae di Paolo VI, la guerra in Vietnam, il movimento studentesco internazionale e il ’68 nel mondo, l’invasione della Cecoslovacchia, l’autunno caldo e l’unità sindacale, la bomba di Piazza Fontana. Da condividere infine il ruolo attribuito dall’autore a quest’ultimo episodio nella caratterizzazione degli accadimenti nei venti anni successivi, sino alla caduta del Muro di Berlino del 1989; fu effettivamente un messaggio drammaticamente introduttivo di una strategia pericolosa, che tentò di cambiare le sorti del Paese, ma la democrazia seppe opporsi senza mai restringere le libertà costituzionali.
Insomma, un lungo viaggio descrittivo di un periodo forse irripetibile, che conserva un fascino ancora molto significativo e che offre spunti di dibattito anche alle nuove generazioni per l’analisi della storia contemporanea.