‘Uno splendido libro’ l’ha definito Sabino Cassese, mentre Michele Salvati ritiene che si tratti di un volume che qualsiasi italiano preoccupato per il destino del suo Paese dovrebbe avere nella propria biblioteca.
Leggendo le 400 pagine di questa lunga e articolata riflessione sulle alterne vicende che hanno storicamente caratterizzato le fasi di ascesa e di declino dell’economia italiana, si coglie uno sforzo descrittivo e interpretativo legato a doppio filo alle evidenze: non solo nell’indagine retrospettiva e lungamente prodromica ed esplicativa che porta al presente ma anche nella visione lungimirante, scaltrita e prospetticamente aperta delle dinamiche in divenire.
Un’indagine tra storia e attualità
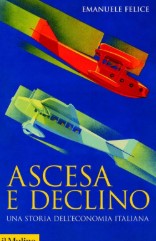 Il Prof. Emanuele Felice – docente allo IULM di Milano – consegna all’editrice Il Mulino un’esplorazione aggiornata che non si riduce ad un compendio per ‘addetti ai lavori’ cucito con i panni della monografia universitaria ma offre una rivisitazione documentata e connotativa delle criticità e delle potenzialità delle condizioni economiche del nostro Paese, legate a dinamiche socio-politiche interne – come vettori di sviluppo e di ritrazione – ma inquadrate in un contesto multipolare e globale sempre più incisivo e condizionante.
Il Prof. Emanuele Felice – docente allo IULM di Milano – consegna all’editrice Il Mulino un’esplorazione aggiornata che non si riduce ad un compendio per ‘addetti ai lavori’ cucito con i panni della monografia universitaria ma offre una rivisitazione documentata e connotativa delle criticità e delle potenzialità delle condizioni economiche del nostro Paese, legate a dinamiche socio-politiche interne – come vettori di sviluppo e di ritrazione – ma inquadrate in un contesto multipolare e globale sempre più incisivo e condizionante.
Quando quella romana era l’espressione della ‘più prospera fra tutte le economie preindustriali che si siano viste nella storia’ (Willem Jongman), l’Italia era il faro di un mondo civilizzato che non esisteva altrove: oggi siamo attori e comparse di una coreografia polifonica planetaria dove la rivoluzione industriale e quella tecnologica hanno impresso accelerazioni dirompenti, con equilibri e disequilibri incerti e cangianti.
L’economia come fattore strategico
Questo interessante e argomentato volume è innanzitutto un invito alla rivisitazione della Storia di cui la dimensione economica è vettore di emancipazione e progresso: nelle pieghe dei corsi e ricorsi, nei flussi di andata e ritorno essa è a un tempo causa ed effetto dei tempi di pace e di guerra (come oggi drammaticamente e ciclicamente riscontriamo), di ribaltamenti e consolidamenti sociali, elemento strategico per regimi e democrazie, distribuzione delle ricchezze e marginalizzazione delle povertà, emergenza e spiegazione delle stesse relazioni interpersonali nei sodalizi umani, fattore strategico sempre determinante ad ogni inquadramento spazio-temporale.
L’economia non è mai stata una scienza esatta e incontrovertibile ma neppure la spiegazione dietrologica dei ‘se’ e dei ‘ma’: conserva per statuto una certa fedeltà alle regole che la spingono verso espansione e progresso ma non è premessa della crescita illimitata, per questo l’autore la indaga – con un inquadramento rigoroso e denotativo – nella logica delle intersezioni e dei condizionamenti dove tra azzardi e ricerca di stabilità il quadro politico nazionale e internazionale in continua evoluzione gioca – lo ha sempre fatto – un condizionamento ed un indirizzo caratterizzante e dirimente.
Politiche, imprese e crisi
Non per niente sono prevalentemente in uso dizioni come politiche monetarie, politiche fiscali, politiche tributarie, politiche di piano, debito pubblico, capitalismo, welfare, assistenzialismo, nazionalizzazioni, libero mercato, distribuzione dei redditi, controllo pubblico (interessante l’approfondimento sulle nazionalizzazioni e i settori trainanti, dall’energia, alla chimica, all’industria automobilistica) fenomeno imprenditoriale delle PMI – base espansiva del Paese poi messa in crisi da burocrazia paralizzante e calo dei consumi interni. Così come nell’attuale contingenza epocale la vicenda dei dazi imposta da Trump sta condizionando non poco alleanze, ostracismi, mediazioni diplomatiche e relazioni internazionali.
Dal miracolo italiano alla stagnazione
In un libro aggiornato rispetto alla precedente edizione del 2015 non possono mancare riflessioni più approfondite sul presente ma anche ripensamenti sui pregressi storici ed economici: a partire da una rivisitazione delle conseguenze delle due guerre mondiali, alla globalizzazione (e ai suoi limiti), alle problematiche relative alla sostenibilità (un mix ambientale e antropologico), alle emergenze demografiche, alle migrazioni, alla concentrazione delle ricchezze, al riemergere dei nazionalismi, alla crescita dei populismi, all’incidenza delle tecnologie, alle peculiarità e ai chiaroscuri della politica italiana, mentre un intero capitolo viene dedicato all’esperienza riferita alla leadership berlusconiana.
L’autore non indulge a retorica e si sofferma con dovizia descrittiva su un fenomeno che sta caratterizzando l’economia italiana degli ultimi decenni: l’arresto della crescita e dello sviluppo, il timore della recessione, il miracolo italiano relegato al ricordo di anni forse irripetibili, una spesa pubblica crescente e improduttiva, l’assenza di una strategia centrata su ricerca e sviluppo, l’inefficienza del sistema formativo fanalino di coda delle valutazioni dell’OCSE.
Metafore e prospettive
Il Prof. Felice, analizzando l’insieme dei fattori che ci hanno portato dall’ascesa al declino, usa la metafora del passaggio dall’età dell’oro a quella dell’argento e a quella del bronzo. Viene spontaneamente da chiedersi dove – almeno in Europa e nel mondo occidentale – si colgano segnali più positivi dei nostri. L’impressione è che il mercato del lavoro per le professioni medio-alte offra più opportunità all’estero, il brain drain supera il brain gain.
Le secche della stagnazione economica in cui l’Italia è andata impantanandosi hanno radici storiche e spiegazioni culturali, si deve prender atto di un calo di motivazione sociale che spinge all’appiattimento e alla rendita di posizione.
Una questione di classe dirigente
Forse – per il legame secolare che qui e altrove lega l’economia e la politica in un rapporto duale di incomprensione dei bisogni, difetto di rappresentanza e scelta del male minore – la strada della ripresa è anche legata ad un radicale rinnovamento della classe dirigente di cui non si intravvede una luce in fondo al tunnel. Il gap tra paese legale e paese reale esiste e si divarica ma il dramma forse più intrinseco ma incompreso consiste nella reciproca intercambiabilità dei ruoli, senza alternative risolutive e senza i necessari salti di qualità.
Emanuele Felice, Ascesa e declino. Una storia dell’economia italiana, Edizioni il Mulino.


