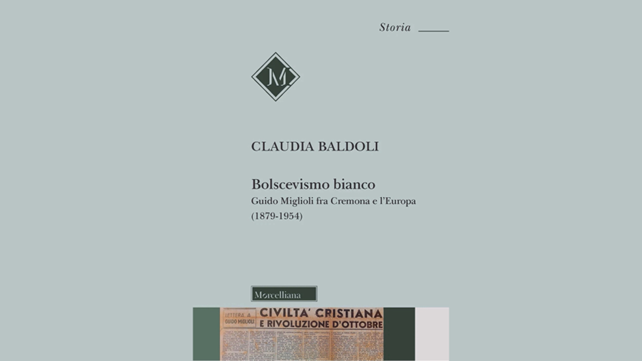Proviamo a porre in risonanza due anniversari: la morte, il 24 ottobre 1954, di Guido Miglioli e la rivoluzione bolscevica del 7 novembre 1917.
Le radici nel movimento cattolico sociale
Poniamoci subito in ascolto di Giovanni Sabbatucci e di Vittorio Vidotto, autori di uno dei migliori manuali di Storia contemporanea: «La condanna di Murri e della democrazia cristiana non impedì peraltro al movimento sindacale cattolico di continuare a svilupparsi.
Nel 1910 esistevano in Italia 375 leghe bianche, con oltre 100.000 iscritti, concentrati in buona parte in Lombardia e in Veneto e reclutati soprattutto fra gli operai tessili, che diedero vita, nel 1909, al primo sindacato nazionale cattolico di categoria. Le organizzazioni bianche riscossero un certo successo anche tra i lavoratori agricoli, in particolare fra i piccoli proprietari e i mezzadri. Nelle campagne del Cremonese un organizzatore di notevoli capacità, Guido Miglioli, riuscì a creare una serie di leghe non meno forti e combattive delle analoghe organizzazioni ‘rosse’».
La rivoluzione russa e la promessa tradita
Volgiamo ora lo sguardo alla Russia, tra la fine del 1917 e l’inizio del 1918. A poche settimane dalla rivoluzione bolscevica, venne eletta un’Assemblea costituente, di cui nessuno parla mai. Poco dopo le speranze si infransero. Come ebbi modo di dire a Salvatore Veca, a mio giudizio l’atto di morte della rivoluzione dei soviet coincide con lo scioglimento armato, nel gennaio 1918, di quell’Assemblea, eletta a fine novembre, con maggioranza schiacciante dei socialrivoluzionari sostenuti dai contadini, mentre i bolscevichi erano fermi a 175 seggi su 707. Il sogno dei soviet non riusciva a coniugarsi con i meccanismi della democrazia parlamentare. Considerarla mero strumento borghese fu errore fatale.
Il secondo fallimento fu ancora più evidente: il venir meno della promessa di coinvolgere anche i contadini. La falce affiancata al martello restò simbolo più che realtà. Le requisizioni forzose e l’economia di guerra fecero crollare il consenso nelle campagne.
L’abbaglio e il destino di Miglioli
Ecco dunque il paradosso di Miglioli: mentre la maggior parte dei dirigenti del movimento comunista internazionale vedeva nell’agricoltura il vero tallone d’Achille del “Paese dei Soviet”, il sindacalista cattolico se ne fece sedurre, negli anni Venti, abbracciando l’idea della collettivizzazione della terra. Un anelito di giustizia evangelica che lo condusse a sostenere una pratica disastrosa, che avrebbe contribuito, decenni dopo, alla stagnazione e al crollo finale dell’impero sovietico.
Una grande amicizia e una memoria dimenticata
E proprio Miglioli – anche per lui, come per Giuseppe Saragat, potremmo evocare “un destino cinico e baro” – nel secondo dopoguerra non venne compreso né da Alcide De Gasperi né dalle sinistre. Nel 1948, candidato come espressione del “Movimento Cristiano per la Pace” dal Fronte democratico popolare, non fu eletto. Ma non era uomo solo: fu sostenuto da una delle amicizie più profonde e straordinarie della nostra storia civile, quella con don Primo Mazzolari. Un legame sul quale meriterebbe soffermarsi ancora.
Da segnalare, infine, la grande monografia pubblicata nel 2021 da Claudia Baldoli, Bolscevismo bianco. Guido Miglioli fra Cremona e l’Europa (1879-1954). Un contributo prezioso per restituire a Miglioli la sua complessità, la sua visione, i suoi errori e la sua eredità mancata.