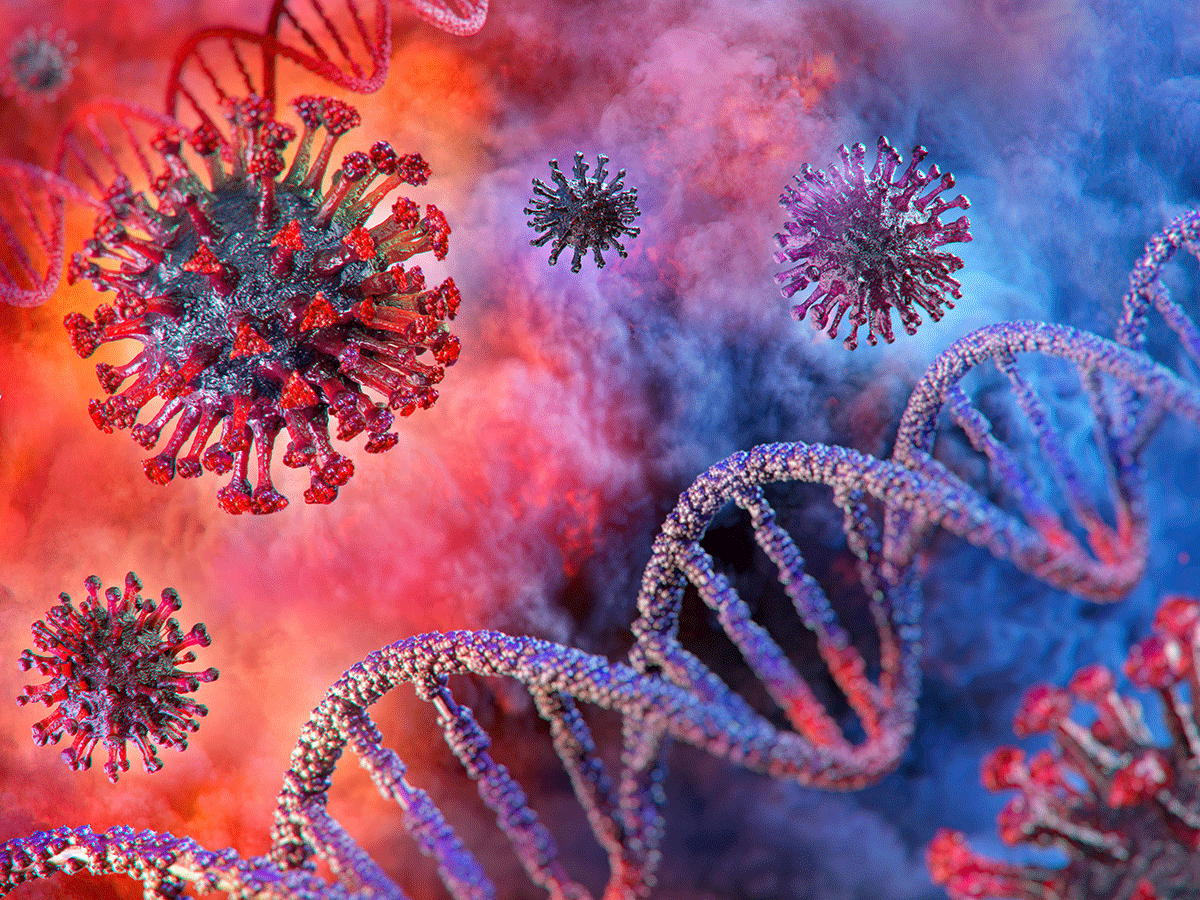Articolo pubblicato sulle pagine delle rivista Atlante di Treccani a firma di Giorgio Scichilone
La democrazia ai tempi del virus, l’espressione su cui si eserciteranno gli storici, è la questione che sta sollecitando con insistenza sociologi, filosofi politici, giuristi e opinionisti di svariata natura e competenze. Non sono riflessioni oziose, riguardano le nostre vite in modo quasi altrettanto importante come quelle più dirette che attengono alla nostra salute. Il quasi è decisivo per le successive argomentazioni. Questo breve discorso potrebbe essere un modesto prolegomeno al ruolo della cultura – o degli intellettuali se si vuole – nella società. Ma di questo un’altra volta.
Ai margini, si direbbe dunque, delle questioni prioritarie e urgenti che riguardano gli effetti dell’epidemia sulla vita, c’è quello legato sulle ricadute sulle libertà, le restrizioni imposte dai governi agli individui per evitare la diffusione del contagio. Sono limitazioni talmente radicali che sembra di essere stati catapultati in un romanzo distopico. In Italia solo le generazioni passate hanno conosciuto la guerra e ciò che significa un bombardamento, un coprifuoco, un’occupazione militare, la lotta partigiana per le strade della città. I più, per fortuna, lo hanno letto nei libri di storia e nella percezione sbadata dei nostri mondi virtuali sembra assumere la stessa distanza empatica delle vicende di Cesare che varca il Rubicone. Lo stile di vita odierno di una porzione privilegiata del pianeta, nella quale abbiamo la buona sorte di vivere, con elevata mobilità e indipedenza, le straordinarie possibilità che economia e tecnologia consentono per raggiungere obiettivi personali e sociali inimmaginabili solo poco tempo fa, sono state improvvisamente compresse da un virus che ha spiazzato gli Stati, precipitandoli in una corsa verso soluzioni politiche e amministrative per contrastare la virulenza della pandemia che sembrano cancellare in un colpo gli standard antropologici abituali. Rimanere chiusi in casa, come prescrivono le norme emergenziali, appare assurdo e inaccettabile. Risulta ormai incompatibile con la nostra visione del mondo, con il nostro essere nel mondo. La riflessione finale a cui ormai risulta polarizzarsi l’attenzione accademica, ed uso questo termine con un’involontaria autoironia, è la relazione delicata che sussiste in uno Stato liberale tra gli inviolabili diritti fondamentali e le prerogative del governo. Fino a dove può spingersi il potere politico, nell’ambito dello Stato di diritto, per assicurare la salute degli individui?
In sostanza l’attuale situazione è stata descritta da molti in termini preoccupati come “stato d’eccezione”. Carl Schmitt, il giusfilosofo tedesco di simpatie naziste, coniò questa formula per descrivere l’essenza della sovranità. Mentre in una dittatura abbiamo uno stato d’eccezione permanente, in cui le libertà costituzionali sono nella disponibilità dell’autorità politica, la democrazia trova la sua legittimazione dal consenso individuale e volontario finalizzato a garantire la libertà naturale dell’uomo. In casi eccezionali, come già l’antica repubblica romana prevedeva, l’ordine costituzionale può sospendersi per tutelare la “salus rei publicae”. La salvezza dello Stato è una delle possibili traduzioni, ma letteralmente si tratta della salute della cosa pubblica, cioè dei cittadini. Una sedizione interna o una guerra che minacciavano la dissoluzione dello Stato e le vite delle persone giustificavano il ricorso a mezzi inusitati, che avevano però il carattere della temporaneità e responsabilità, per contrastare nel modo più efficace e tempestivo possibile il rischio fatale che incombeva sulla società. Era uno stato d’eccezione in cui a qualcuno, in deroga alle procedure ordinarie, veniva affidata la summa potestas, i pieni poteri, per difendere e tutelare lo Stato. I repubblicani dell’età umanistica videro in Giulio Cesare il guastatore della repubblica perché aveva fatto saltare il limite temporale della dittatura, differendo sine die il momento in cui occorreva riferire al Senato sull’uso del potere assoluto. Se la straordinarietà temporanea che consente i mezzi speciali non si incontra poi con la responsabilità, allora la salute pubblica non è più garantita dalla legge ma dalla discrezionalità arbitraria di chi è – o si è posto – al di sopra della legge. Del resto, il primo documento di ‘filosofia politica’ della tradizionale occidentale, la dotta discussione tra ‘barbari’ (i Persiani) riportata da Erodoto, poneva un discrimine tra quelli che potremmo definire regimi autoritari e liberali. Nei secondi chi detiene il potere deve rendere conto del proprio operato. Dove c’è invece arbitrarietà, la libertà dei sudditi è in pericolo.
Schmitt era un ammiratore di Hobbes, il filosofo inglese del Seicento che ha fatto derivare la legittimità dello Stato dal patto tra individui liberi e uguali. Ne è risultato il mostruoso Leviatano, che ha costantemente i pieni poteri per garantire la vita dei cittadini. Hobbes scriveva il suo trattato durante una guerra civile. In quel momento l’unica preoccupazione era salvare la vita, e ogni individuo aveva paura della morte violenta. Il pensiero elementare del filosofo era di risolvere quella sfida capitale. La sua idea era di fondare un potere talmente forte – onnipotente – che potesse ergersi, di fronte alle fazioni armate che avevano disfatto l’ordinamento giuridico e insanguinato il Paese, per imporre una legge comune evitando le faide private. Un compito epocale che richiedeva il consenso di ciascuno. Lo scambio era seducente e ha generato una retorica che non smette di mostrare la sua vitalità: la sicurezza al posto dei diritti. Hobbes è stato naturalmente molto criticato, e i successivi pensatori liberali hanno ritenuto che uno Stato non può fondarsi sulla sola difesa della vita per potere essere considerato legittimo. Alla vita John Locke ha aggiunto in modo imperituro la libertà e la proprietà, e nella Dichiarazione d’indipendenza americana campeggia, come un tempo la parola libertas sui torrioni delle città medievali italiane, la felicità, l’ulteriore fine che lo Stato è chiamato a garantire.