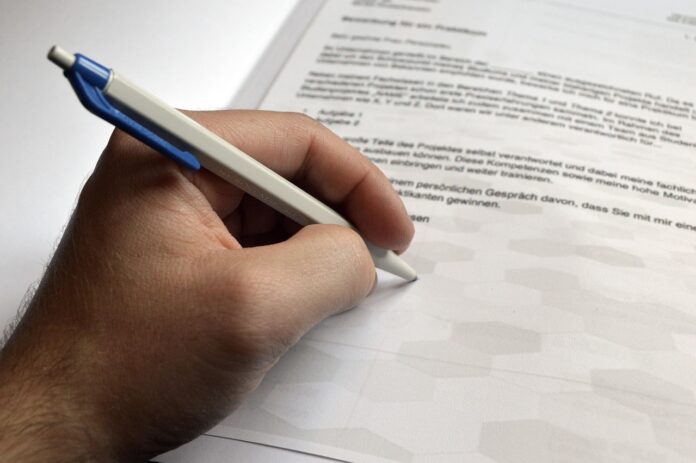In natura ci sono moduli che si ripetono negli esseri viventi più diversi lungo una linea evolutiva di milioni d’anni. La noce è un esempio impressionante. La noce e il suo involucro sono la fedelissima versione in miniatura del cervello e del cranio dei vertebrati e dell’uomo: due emisferi apparentemente identici, uniti da una struttura mediana, in un involucro rigido e altamente protettivo. Il genoma dei vertebrati e quello della noce hanno qualcosa in comune. Il cervello degli esseri umani consiste di due emisferi, solo apparentemente identici. Essi regolano motilità e sensibilità della metà opposta del corpo. Nel midollo spinale e nel tronco encefalico i tramiti nervosi dal cervello al corpo e
dagli organi di senso agli emisferi cerebrali sono incrociati. Il medico greco Ippocrate di Kos (460-377 a.C.) oltre a separare la medicina dalla religione smettendo di considerare le malattie punizioni divine, sostenne che “col cervello pensiamo, comprendiamo, vediamo, conosciamo il male e il bene, il brutto e il bello”.
Precocissima e straordinaria intuizione della realtà del cervello, ignorata fino al XVIII secolo. Finché prevalse l’opinione di Aristotele, ripresa da Claudio Galeno, medico di corte dell’imperatore Marco Aurelio e dall’ortodossia scolastica, che pensiero e sentimenti erano opera del cuore e che il cervello raffreddava il sangue, non ci si chiese il senso della duplicità degli emisferi. Nel 1861 il chirurgo e patologo francese Paul Broca trovò nel cervello di un epilettico morto a 51 anni, che aveva perduto la parola da 21 anni e la forza e la sensibilità della parte destra del corpo 11 anni prima, un “rammollimento cronico e progressivo” nella base del lobo frontale sinistro. Scoprì una differenza funzionale fra le metà del cervello.
Il centro principale del linguaggio è nell’emisfero sinistro, che elabora anche motilità e sensibilità della parte destra del corpo, e quindi della mano destra. Si dice che esso è l’emisfero “dominante” nel 90% degli esseri umani. Si pensò che linguaggio e prevalenza della mano destra avessero avuto un’evoluzione comune, fin quando si constatò che anche nel 70% di uomini con pre-valenza della mano sinistra, cioè nei mancini, i centri del linguaggio sono a sinistra. La causa della prevalenza della mano destra non è nota. Fino a 50 anni fa si pensava che l’a-simmetria fosse limitata agli esseri umani. Non si sospettava la duplicità cerebrale per funzioni apparentemente semplici come quelle degli animali. Una delle prime prove dell’asimmetria del cervello degli animali fu che gli uccelli canterini non cantano se è anestetizzato il nervo ipoglosso sinistro dell’organo vocale. Se il nervo sinistro è tagliato prima che comincino a cantare, il canto si sviluppa normalmente grazie all’ipoglosso destro. Se il taglio a sinistra è fatto entro quattro settimane dopo la covata, il nervo rigenera e innerva l’organo vocale assieme col destro. Già da qui si vide quanto complessa e diffusa sia la duplicità funzionale degli emisferi cerebrali.
Neuroetologia
L’asimmetria dei sistemi nervosi è evidente nel comportamento. La neuroetologia studia l’asimmetria anatomica e funzionale dei sistemi nervosi indagando il comportamento d’uomini, primati, mammiferi, lucertole, pesci, tartarughe, uccelli, topi, ratti, api, formiche, calamari, pulcini, lumache e d’altri animali. Negli esseri umani e in quasi tutte le scimmie la mano destra prevale. L’area motoria nell’emisfero sinistro ha un numero più elevato di neuroni. Per molte attività topi e ratti usano di regola la zampa anteriore destra. Il pulcino esce dal guscio rompen-dolo con la zampina destra. La linea mentale dei numeri (1…2…3) va da sinistra a destra. Pulcini neonati furono allenati a beccare semi nel quarto e nel sesto buco (contando dal basso) di un’asta verticale. L’asticella fu poi posta orizzontalmente. La maggior parte dei pulcini cercava i semi nel quarto e nel sesto buco contando da sinistra. La linea dei numeri da sinistra a destra è un meccanismo cerebrale congenito dell’emisfero destro che orienta l’attenzione verso sinistra. Il camaleonte americano è molto duttile: ha un colore amabile nella parte del corpo rivolta verso la femmina ed uno minaccioso verso il rivale.
Funzioni dell’emisfero cerebrale sinistro
La parte sinistra del sistema nervoso regola il comporta-mento distinguendo gli stimoli secondo regole congenite o acquisite. I passeri percepiscono il cinguettio dei compagni più con l’orecchio destro, cioè con l’area uditiva della metà sinistra del loro minuscolo cervello. Uccelli, pesci, mammiferi cercano cibo con l’occhio destro, e si guardano dai pericoli col sinistro. Piccioni, polli e altri uccelli utilizzano l’occhio destro per distinguere semi da sassolini. I cani reagiscono a stimoli gradevoli (una carezza, del cibo) muovendo la coda verso destra per azione dell’emisfero sinistro. Se lo stimolo è sgradevole (un cane ostile, un gatto) la coda è mossa verso sinistra, per azione dell’emisfero destro. L’area del linguaggio del lobo frontale sinistro umano è densa di connessioni nervose.
Oltre al linguaggio e alla motilità della mano destra dominante, l’emisfero sinistro umano regola il comportamento che dipende da convinzioni, conoscenze e riflessioni. Impara, formula regole, valuta passato e presente e pianifica il futuro. È l’emisfero dell’autocoscienza, cioè della riflessione su sé stessi, di cui il linguaggio interiore è lo strumento, e di cui solo il cervello umano è capace. L’uomo è l’unico essere vivente che, raramente, pratica il suicidio, perché è l’unico a giudicare il senso della propria esistenza.
Funzioni dell’emisfero cerebrale destro
L’emisfero destro elabora nuovi impulsi e distingue le varie emozioni. La sua reazione è particolarmente intensa nel caso d’emozioni negative. Il cane allarmato scodinzola ver-so sinistra. Nell’uomo l’emisfero destro è sensibile a stimoli inattesi, pericolosi e associati a forti emozioni. Ad essi la mano sinistra reagisce più in fretta della destra dominante. Negli uomini e in altri vertebrati l’emisfero destro elabora le informazioni spaziali più del sinistro, perché a destra il lobo parietale è più sviluppato. Nei taxisti di Londra, alle prese con un traffico faticoso, le aree cerebrali dell’ippocampo e del lobo parietale, particolarmente impegnati nella memoria e nell’informazione spaziale, sono più voluminosi a destra. Scoiattoli e topi che nascondono il cibo per il futuro hanno un senso e un orientamento spaziale molto sviluppati. In loro, sin dalla nascita, l’ippocampo destro è più grande di specie affini che non nascondono il cibo. Lo stimolo ad urinare è regolato prevalentemente dall’emisfero destro. Da ciò l’urgenza di urinare ripetutamente in caso di tensione e di forti emozioni. La lesione del lobo temporale destro può portare a non distinguere una barzelletta da una minaccia o il russare dal suono di una campana.
L’amusia è l’incapacità congenita di percepire la musica, che è sentita come un rumore fastidioso. È dovuta al mancato sviluppo o a una lesione nel lobo temporale destro, del centro della percezione musicale. Nei ritratti, specie femminili, in primo piano c’è di regola la parte sinistra del volto. Se il ritratto è di fronte, è in evidenza la metà sinistra. Nella maggioranza di ritratti femminili e nella metà dei ritratti maschili dell’immensa raccolta della National Portrait Gallery di Londra è in evidenza la parte sinistra. Essa è tanto frequente da non poter essere casuale. Potrebbe essere dovuta alla maggior espressività, perché la metà sinistra della faccia è innervata dall’emisfero destro. Il pianoforte si suona, di regola, con due mani e la destra prevale. A partire dal XVII secolo sono comparsi circa 1100 studi e trascrizioni e 50 concerti per la mano sinistra non dominante. Le composizioni per la sola mano destra sono una decina.
Paul Wittgenstein, fratello del filosofo Ludwig, all’inizio della carriera di pianista perdette il braccio destro sul fronte russo nella prima guerra mondiale. Già nell’ospedale militare decise di continuare a suonare. Wittgenstein chiese musica solo per la mano sinistra ai maggiori compositori del tempo. Famoso è il Concert pour la main gauche che Maurice Ravel compose per lui. La mano sinistra, scrisse Wittgenstein, è più adatta della destra per suonare con una sola mano perché ad essa riescono il salto dal grave all’acuto e viceversa e la rapidità del suono meglio che alla destra. L’emisfero destro è sensibile a stimoli inattesi e a forti emozioni e quindi la mano sinistra reagisce più in fretta della destra. Il lobo parietale e l’ippocampo dell’emisfero cerebrale destro sono gli organi principali della coordinazione e dell’orientamento spaziotemporale. Essi regolano la mano sinistra più rapidamente della destra, perché i loro impulsi la raggiungono senza dover attraversare la struttura interemisferica del corpo calloso, che comporta perdita di tempo. È quindi comprensibile l’agilità della mano sinistra per movimenti rapidi, precisi e fini in condizione di emotività come la musica.
Anche il piede sinistro approfitta delle funzioni del loro parietale destro. Per le manovre del dribbling, giocatori di calcio si servono principalmente del piede sinistro: Mario Corso, leggendario attaccante dell’Inter, famoso, e temuto dagli avversari, per il suo dribbling, era chiamato “Il piede sinistro di Dio”. Nel cervello dei violinisti l’area motoria della mano sinistra nell’emisfero destro è più sviluppata della media per i finissimi movimenti sulle corde. Come quello sinistro, l’emisfero cerebrale destro è fondamentale per l’esistenza. Le sue funzioni, importantissime, ci rendono un po’ mancini.
Arnaldo Benini è professore emerito di neurochirurgia e neurologia dell’Università di Zurigo. È stato primario di neurochirurgia alla Schulthess Klinik di Zurigo. Tra le sue pubblicazioni in italiano, ricordiamo, per Garzanti, Che cosa sono io. Il cervello alla ricerca di Sé stesso (2009) e La coscienza imperfetta. Le neuroscienze e il significato della vita (2012); per Raffaello Cortina Neurobiologia del tempo (2017) e La mente fragile. L’enigma dell’Alzheimer (2018). Collabora alle pagine di Scienza e filosofia dell’edizione domenicale del Sole24Ore e alla pagina culturale del Corriere del Ticino.