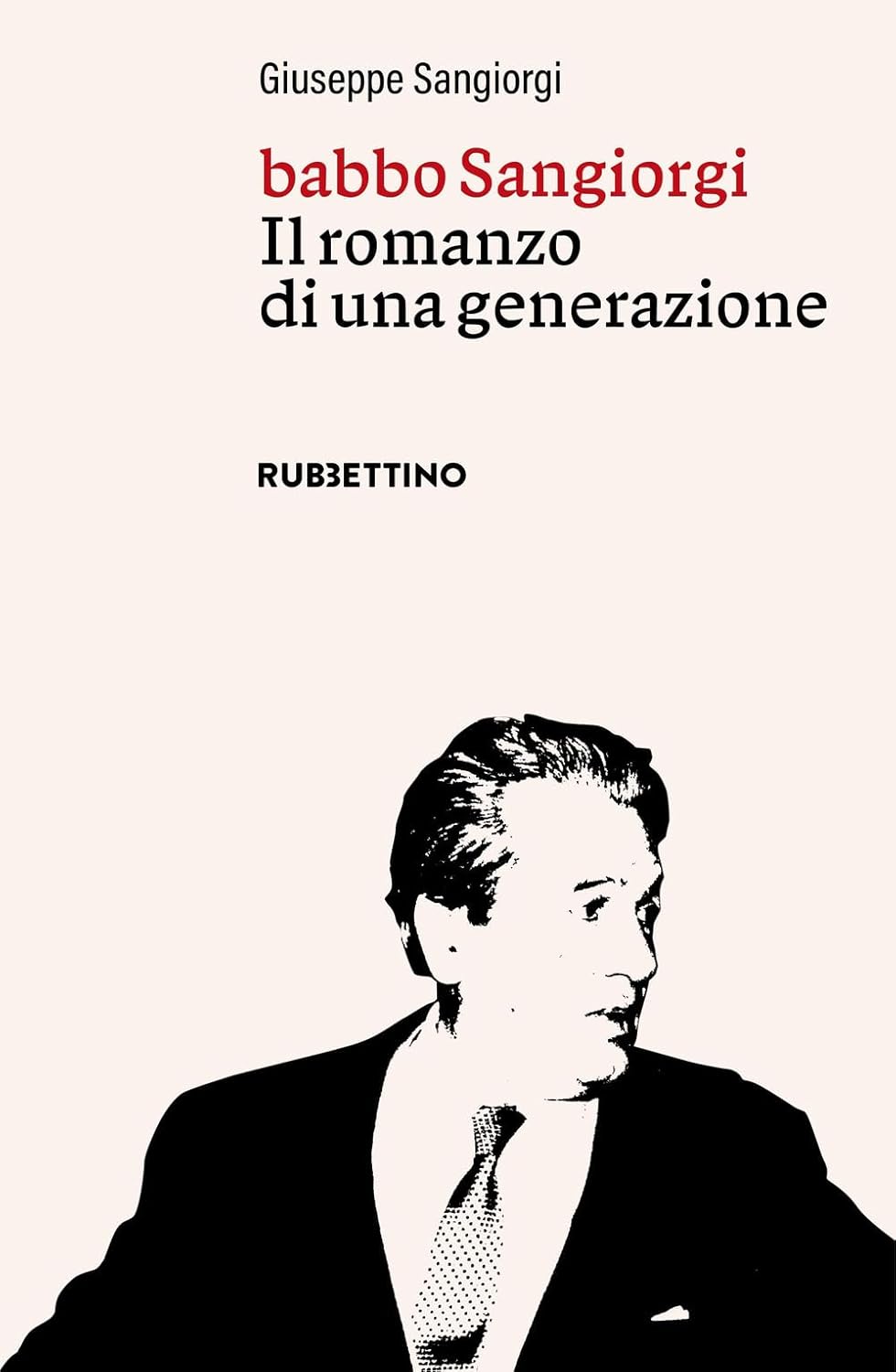È un piacere e un onore per me parlare di questo libro, non solo perché sono amico dell’autore, ma anche perché la lettura di queste pagine mi ha arricchito di informazioni, suggestioni e riflessioni. Ringrazio perciò Beppe per l’invito e per questo prezioso dono rappresentato da Babbo Sangiorgi.
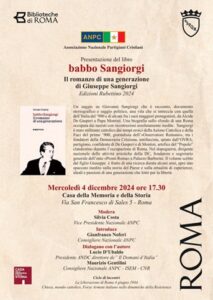
Iniziamo con un dato di fatto: Sangiorgi è uno dei due “cultori della materia” che meglio sanno raccontare la storia della Democrazia Cristiana nella sua complessità, con tutte le luci e le ombre. L’altro è Marco Follini. Entrambi, di professione giornalisti, condividono una passione: tessere i fili della memoria storica di un’epoca che rischierebbe, senza un lavoro d’indagine e recupero, di passare inosservata sotto gli occhi delle nuove generazioni.
Follini e Sangiorgi hanno stili differenti. Follini scrive in modo avvolgente, con un gusto per i dettagli che ricorda lo stile narrativo di Gabriel García Márquez in Cent’anni di solitudine. Si avverte la sapienza dell’armonia stilistica. Sangiorgi, invece, è un cronista alto e raffinato, direi un Montanelli di matrice cristiana – e più precisamente democristiana – che trascrive su carta considerazioni limpide e belle, senza il veleno del disincanto totale, fors’anche del cinismo, che animava la prosa di Montanelli. Lo vediamo in Babbo Sangiorgi: va dritto al cuore delle questioni, sviluppando il racconto in maniera lineare, anno per anno, episodio per episodio, con una struttura che accompagna il lettore dall’inizio alla fine, senza inciampare nello smarrimento di un filo narrativo.
Questo libro – bisogna dirlo con forza – è una miniera di informazioni. Ogni pagina apre una finestra su momenti cruciali della nostra storia, riescendo a fornire preziosi dettagli o nuove piste di analisi, anche quando non sembra volerlo esplicitamente.
Un esempio significativo riguarda il ruolo della famiglia Sangiorgi durante l’occupazione di Roma.
È la fase del massimo sconforto, per le condizioni dell’Italia – e di Roma in particolare, con un bilancio finale di 51 incursioni aeree e 7.000 vittime – ma anche della speranza cui si orientano le coscienze più fervide e coraggiose. Dopo l’8 settembre si apre la fase della riorganizzazione delle forze politiche democratiche. Ora, noi siamo abituati a pensare che la preparazione del nuovo “partito cattolico”, la Democrazia Cristiana, abbia trovato svolgimento essenzialmente nello studio di Giuseppe Spataro, in via Cola di Rienzo. Beppe ci mostra invece come una febbrile attività politica si svolgesse anche nella casa della famiglia Sangiorgi, un luogo che divenne punto di incontro per i dirigenti più legati a De Gasperi.
Qui si ponevano le basi di un partito a larga base popolare, capace di corrispondere alle sofferenze e insieme alle attese che il tragico epilogo della guerra metteva allo scoperto. Prendeva forma un soggetto politico capace di parlare anche oltre i confini dell’appartenenza al mondo cattolico. Lo studio Spataro fungeva da ufficio di rappresentanza, per dirla in maniera simpatica, mentre casa Sangiorgi era l’officina in cui si componevano i pezzi della nuova iniziativa politica, con gesti di militanza coraggiosa (si pensi a come veniva preparato e diffuso Il Popolo clandestino).