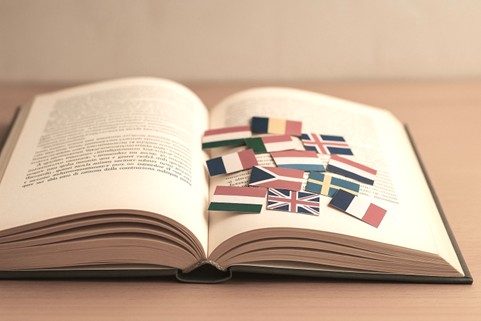L’ascesa dei populismi riflette un profondo cambiamento nel panorama politico, influenzato da fattori economici, sociali e culturali. Come sappiamo, i leader populisti riescono a capitalizzare la rabbia e il malcontento degli elettori, promettendo di difendere gli interessi nazionali contro le influenze esterne. La loro crescita impetuosa rappresenta una sfida significativa per le democrazie occidentali, richiedendo una riflessione critica sulle cause (remote e prossime) e sulle possibili risposte a questo fenomeno.
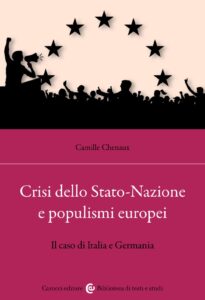
Il populismo come sintomo della crisi dello Stato-nazione
Un’occasione è offerta dal volume della giovane politologa Camille Chenaux (“Crisi dello Stato-nazione e populismi europei”, Carocci editore), che illustra come il populismo abbia ridisegnato, in pochi anni, la grammatica e la sintassi politica del continente europeo.
Il partito o movimento di stampo populista è presente nello scenario politico europeo almeno dalla metà del Novecento: basti pensare al Fronte dell’Uomo Qualunque in Italia (fondato da Guglielmo Giannini nel 1946) o alla Unione Democratica di Centro, tuttora attiva in Svizzera.
Il volume di Chenaux delinea l’ascesa dei populismi in Europa partendo da quattro fratture — politica, culturale, economica e sociale — sulle quali si reggono oggi i sistemi politici, dimostrando come alla base del populismo vi sia, anzitutto, una crisi dello Stato-nazione.
I casi emblematici di Italia e Germania
I movimenti e i partiti populisti, infatti, contraddicono i principi dello Stato-nazione: accusano le istituzioni democratiche di “usurpare” il potere, ignorano le garanzie costituzionali e i check and balances, ossia i meccanismi politico-istituzionali che limitano reciprocamente i poteri dello Stato.
In Italia, le elezioni politiche del 2018 hanno rappresentato un vero “laboratorio populista”, con la formazione del governo “giallo-verde” guidato da Giuseppe Conte, poi trasformatosi in “giallo-rosso”.
In Germania, invece, la lunga stagione di Angela Merkel (2005–2021) ha consolidato il modello economico nazionale ma anche acuito fratture tra Est e Ovest, alimentando il risentimento che ha favorito l’ascesa di Alternative für Deutschland (AfD), oggi primo partito nei sondaggi davanti a SPD e CDU-CSU del cancelliere Friedrich Merz.
Come uscire dalla morsa populista
Un possibile antidoto per ridurre l’influenza dei movimenti populisti è il rafforzamento delle istituzioni, la promozione della trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini al voto.
Considerando che circa il 50% degli aventi diritto non si reca più alle urne, chiunque venga eletto è ormai espressione di una minoranza.
Per saperne di più
Camille Chenaux, politologa italo-svizzera, ha conseguito il dottorato di ricerca in Relazioni internazionali all’Università di Roma Tre (2022) e insegna Contemporary Italian Politics e Italy and EU presso lo IES Abroad di Roma.
Sul profilo Instagram dell’autrice (@thesportymind) sono disponibili le video-interviste con Paolo Mieli dedicate ai temi del volume.