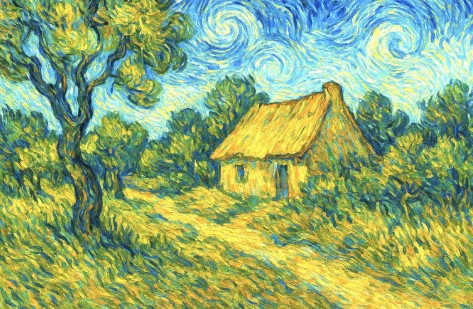Un divorzio che nasce dal sistema politico
L’attuale dibattito sulla finanziaria ha fornito l’occasione per capire a quale punto sia giunto il livello di incomprensione della politica rispetto alla condizione dei ceti sociali intermedi. Un divorzio alimentato da diversi fattori concomitanti.
Il deficit di rappresentanza, che il bipolarismo forzoso creato dal sistema maggioritario ha reso ormai strutturale, ha prodotto negli anni un circolo vizioso. Con il disfacimento dei partiti di massa e con la contestuale adozione della prassi della nomina dei parlamentari da parte dei “cerchi magici” dei partiti, togliendo agli elettori il potere di scelta espressamente previsto dalla Costituzione, il personale politico risulta in gran parte selezionato dall’alto e non più espressione dei corpi sociali più rappresentativi.
Nel contempo, questo processo ha concorso ad accrescere la disaffezione verso la politica e verso le elezioni da parte di una buona metà dell’elettorato. A questo proposito va osservato, con pura constatazione dei fatti, che la tanto decantata elezione diretta, che continua ad avere estimatori tanto a destra quanto a sinistra, ha ammazzato la partecipazione dei cittadini alle elezioni per gli enti locali, oltre che alle legislative.
Una politica che non conosce più il ceto medio
Non stupisce, dunque, che in occasione della discussione della manovra finanziaria siano emerse proposte che denotano una non familiarità con la condizione del ceto medio. Come la proposta della Cgil di una patrimoniale sopra i due milioni. Pomposamente annunciata come la tassa sui “super-ricchi”, in pratica costituirebbe una nuova stangata sui comuni patrimoni familiari. Annunciata come la tassa sui paperoni, finirebbe per gravare per lo più sulla classica casalinga di Voghera.
Non è un caso che questa proposta sia stata sostenuta da Verdi e Sinistra Italiana: ulteriore conferma di una alleanza di interessi nei fatti fra sinistra estrema e veri super-ricchi, plurimilionari e miliardari, soggetti alle per loro allettanti regole dei paradisi fiscali.
Ma anche il centro, che dovrebbe essere il naturale interlocutore politico del ceto medio, denota una certa fatica a rappresentarlo. Spesso dà l’impressione di considerarlo solo come ceto benestante. Ma con la fine della politica economica, della programmazione e dell’economia mista pubblico-privata — sostanzialmente con la fine della Prima Repubblica — il ceto medio arranca.
L’allarme dell’Eurispes
Ce lo ricorda bene un commento dell’Istituto Eurispes alla legge di bilancio in discussione, per il quale occorre salvare il ceto medio, i cui componenti sono considerati “ricchi per legge, ricchi per ideologia, ma, in realtà, spina dorsale del Paese in profonda difficoltà economica e identitaria”.
Credo che una classe politica — specie se ama definirsi di centro — che voglia proporsi di superare l’attuale divorzio fra ceto medio e politica, debba interrogarsi sul rapporto che intercorre fra sistema politico-istituzionale, democrazia e ceto medio.
È un fatto che nella Prima Repubblica, nella quale era la politica a comandare, vi è stata una costante crescita del ceto medio. Nei sistemi in cui è il denaro a comandare, come nella Seconda Repubblica — almeno fino al governo Draghi, che molti considerano il governo della svolta — il ceto medio perde ruolo politico e vede peggiorare il proprio livello di vita.
Come osserva l’Eurispes:
“Non solo gli appartenenti all’attuale ceto medio non sono ricchi, ma devono anche pagare, ed hanno fino ad oggi pagato, per chi probabilmente è anche più ricco di loro.”
Servono politiche nazionali, comunitarie e globali per contrastare la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochissimi soggetti.
La ricchezza si concentra, la classe media arretra
Secondo i dati della Banca d’Italia sulla distribuzione della ricchezza delle famiglie italiane, nel 2010 il 10% più ricco deteneva il 51,8% della ricchezza totale; nel 2024 è passato a detenerne il 60%.
La classe media, nello stesso periodo, passa dal 39% al 32,7% della ricchezza totale.
Perché l’Italia può essere un laboratorio di rinascita
Non si vede perché non possa essere proprio l’Italia il laboratorio per un cambio di strategia verso il ceto medio. Il modello italiano di sviluppo, che portò il Paese al boom economico, è stato molto studiato e in parte adattato in molti contesti di nuova industrializzazione.
Come dice Jannik Sinner “c’è tanta Italia a Torino”, così si potrebbe dire che c’è tanta Italia a Pechino, dietro il grande sviluppo del Dragone degli ultimi decenni.
La rinascita del ceto medio passa dal recupero e dall’attualizzazione di politiche che tanti benefici diedero al nostro Paese e che dimostrano di funzionare tuttora nei contesti dove non sia il denaro a comandare.