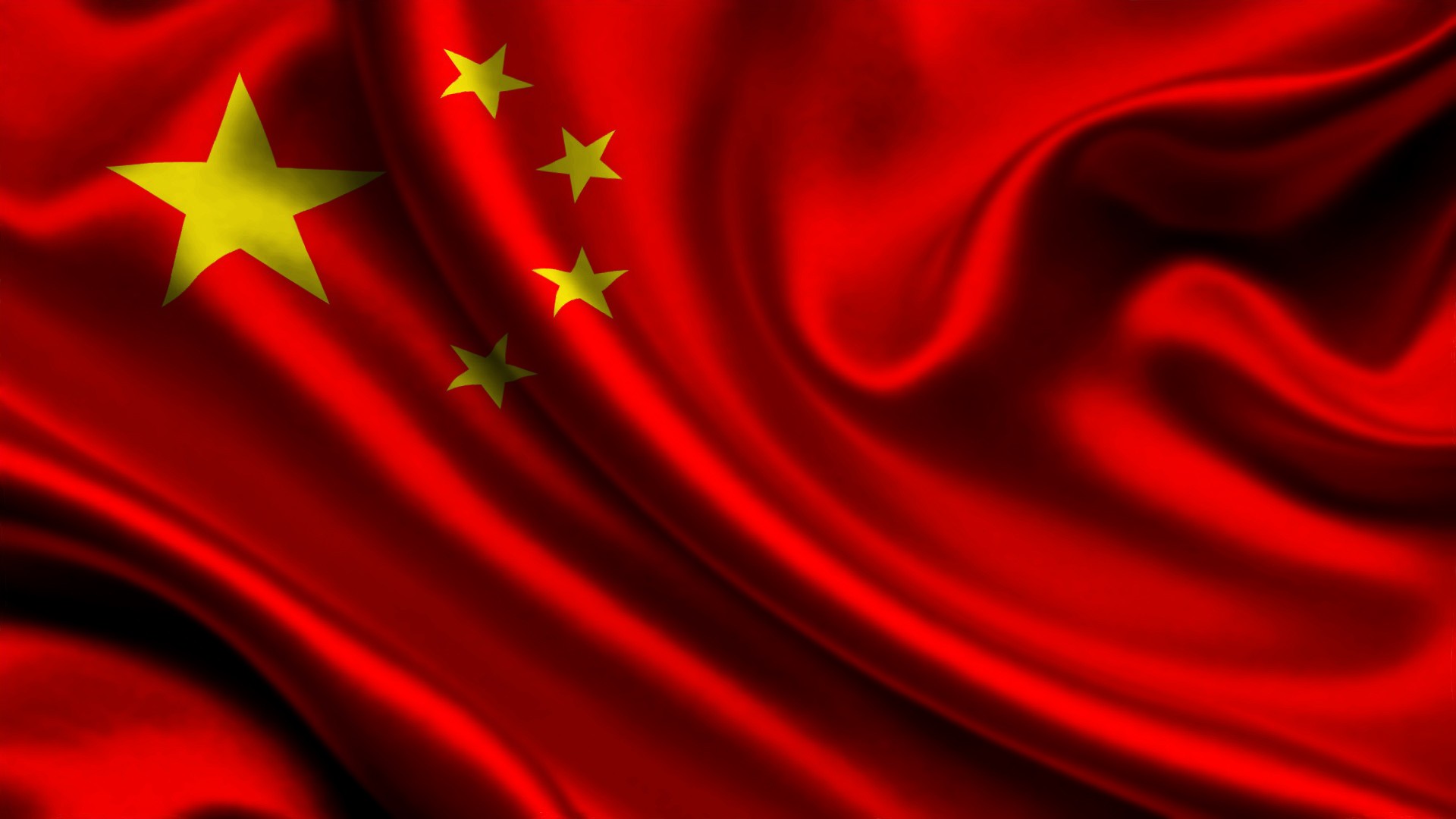Secondo il “padre della democrazia” in Cina le dimostrazioni di questi giorni sono spontanee, non hanno appoggi all’interno del Partito comunista, come 33 anni fa. Quello attuale è un movimento più di massa di quello del 1989. Xi Jinping ha paura di schierare l’esercito, userà la tecnologia per una repressione mirata.
Emanuele Scimia
“Ci sono alcune differenze” tra le proteste in Cina di questi giorni e i fatti di Tiananmen del giugno 1989, quando le Forze di sicurezza cinesi hanno massacrato migliaia di studenti e cittadini che dall’iconica piazza della capitale chiedevano libertà e democrazia nel Paese. È il commento rilasciato a caldo ad AsiaNews da Wei Jingsheng, “padre della democrazia” nel gigante asiatico, ora esule negli Stati Uniti.
Con la massiccia presenza delle Forze dell’ordine nelle strade, e ripetuti arresti e controlli di manifestanti, le proteste popolari in Cina contro le restrizioni anti-Covid scoppiate nel weekend sembrano affievolirsi. Migliaia di cinesi hanno dimostrato in diverse città del Paese chiedendo la fine dei continui lockdown, arrivando a prendere di mira la leadership del Partito comunista cinese (Pcc).
Estese dimostrazioni si sono avute soprattutto a Pechino, Nanchino, Shanghai, Chengdu, Wuhan e Guangzhou. L’ondata di rabbia segue le manifestazioni dei giorni scorsi a Urumqui, capitale della regione autonoma dello Xinjiang, in cui la popolazione chiedeva la fine della politica “zero-Covid” di Xi. Molti residenti hanno incolpato le autorità per la morte il 25 novembre di 10 persone a causa di un incendio in una palazzina: le draconiane misure anti-pandemia avrebbero ostacolato la loro fuga.
Mentre i media governativi censurano gli eventi di questi giorni, le frange più nazionaliste iniziano a incolpare “forze straniere” per lo scoppio dei tumulti. Quella di trovare un “colpevole esterno” a problemi domestici è una tattica consolidata del regime cinese, impiegata non da ultimo per le proteste pro-democrazia del 2019 a Hong Kong.
Le autorità si trovano di fronte a un movimento senza leadership, che si muove tra la piazza fisica e quella virtuale del web. “Il movimento del 1989 – osserva Wei – era sostenuto da alcune forze interne al Pcc, quindi era in grado di riunire per lungo tempo un gran numero di dimostranti a Pechino”. Al contrario, sottolinea lo storico attivista, “ora non vi è alcun chiaro appoggio dentro al Partito, ed è evidente la natura spontanea delle manifestazioni”.
Wei sottolinea che nel 1989 la gente chiedeva la riforma del regime comunista e il bersaglio ufficiale delle proteste era la corruzione dei leader. I manifestanti non avevano dunque il sostegno di lavoratori, contadini ed esercito. Le politiche di prevenzione della pandemia “danneggiano [invece] tutto il popolo cinese, e le proteste sono vissute con partecipazione dalla maggior parte dei cinesi”.
Il dissidente spiega che “il movimento del 1989 riponeva le proprie speranze nel Partito e aveva pubblicamente affermato il proprio appoggio al suo Comitato centrale”. I moti di questi giorni invocano le dimissioni di Xi e domandano al Pcc di farsi da parte, segno che l’opinione pubblica non ha fiducia nel Partito.
Wei ricorda che 33 anni fa l’esercito aveva represso le proteste con il pugno duro: “Per paura che le Forze armate non obbediscano agli ordini, ora il Pcc non ha il coraggio di impiegarle. Il Partito ha però sistemi di sorveglianza tecnologica molto sofisticati con cui può condurre una repressione mirata, nel tentativo di prevenire una reazione negativa della comunità internazionale”.