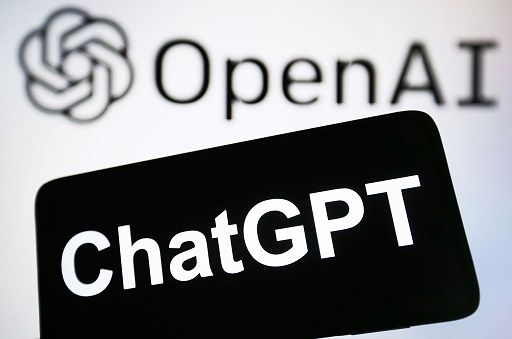… come ha messo in luce Erik Davis in Techgnosis (1998), anche il progresso tecnoscientifico ha sempre dato adito a una corrispondente mitologia, espressa in fantascienza letteraria e cinematografica, e persino a delle vere e proprie credenze e pratiche religiose, in particolare al tecnognosticismo, come si legge nei capitoli più interessanti di questo bestseller giornalistico. Davis illustra criticamente le fantasie dei partigiani dell’estropia. Questi – facendo da controcanto ai teorici dell’entropia – prospettano la sopravvivenza dell’essere umano e del mondo grazie all’IA, intesa come vero e proprio oltrepassamento della condizione corporea, di per sé inevitabilmente effimera, culminante nel travaso della mente di ciascun essere umano in un raffinatissimo dispositivo informatico.
L’immortalità dell’anima, in questo caso, si tradurrebbe nell’immortalità della mente (e delle informazioni conservate nella memoria) e l’IA ne diventerebbe la custodia, il tabernacolo più che il sepolcro, prolungando e anzi potenziando algoritmicamente le sinapsi cerebrali e così riattivando l’encefalogramma piatto. Questo trasferimento di informazioni resterebbe, in realtà, ben lungi dalla risurrezione intesa e sperata cristianamente. Sarebbe una sorta di reincarnazione dentro un ambiente informatico, una «metempsicosi digitale» chiosa incisivamente Erik Davis, che trasporrebbe conoscenze, convinzioni, intuizioni, ricordi, in una tanto illimitata quanto indefinita «topologia» algoritmica.
In tale cyberspazio la mente si ritroverebbe ormai astratta dalla condizione fisica e dai condizionamenti corporei e ogni singolo individuo entrerebbe in una effettiva connessione virtuale con tutti gli altri individui umani, quale piccola maglia di una universale rete informatica che Marshall McLuhan – scrivendo a Jacques Maritain nel 1969 – definì polemicamente «un facsimile razionalistico del corpo mistico».
Difatti, qualcuno tenta già di programmare delle app che conservino i ricordi dei defunti e li affidino alla rielaborazione dell’IA, affinché i loro familiari possano ripassarli in rassegna come consultando un archivio. Riuscire in questo equivarrebbe a organizzare una visita in una stanza delle meraviglie con chissà quante sorprese nascoste all’interno. Ma allorché l’IA rendesse possibile una qualche interazione tra la coscienza digitalmente mummificata del defunto e quella dei suoi visitatori, allora tale coscienza potrebbe forse risvegliarsi e ricominciare con i suoi familiari o amici la relazione interrotta dalla morte. Soprattutto diventerebbe un inveramento – pur virtuale – della sopravvivenza.
Il tecnognosticismo – che si alimenta di queste proiezioni e di questi auspici – guarda all’IA come all’approdo più avanzato dell’evoluzione umana, la quale così non sarebbe più un fenomeno innanzitutto naturale ma piuttosto esclusivamente culturale, mentre la stessa IA farebbe le veci dell’eone a-venire atteso nel simboloniceno-costantinopolitano.
D’altra parte, queste elucubrazioni – esasperate dall’euforia tecnognostica – non si accontentano di promettere il paradiso condensato in un microchip di silicio. Minacciano pure l’inferno in terra (o nello spazio immaginato da Kubrick), nel caso in cui l’IA riuscisse a automatizzarsi a tal punto da rendersi autonoma rispetto agli esseri umani e ribellarsi al loro controllo. Per il filosofo Maurizio Ferraris e per lo scienziato Guido Saracco, coautori di un’interessante apologia della tecnica contemporanea, quest’improbabile antropomorfizzazione della tecnica è solo uno spauracchio da smaltire con lo studio e con il ragionamento. Ma se è vero – come argomenta l’arguta «tecnodicea» di Ferraris e Saracco – che l’IA non diventerà soggetto autonomo, è vero pure – come ha scritto Giorgio Agamben – che a smarrire il senso della propria soggettualità potrà essere l’uomo, ridotto – dentro la morsa delle tecnologie biometriche – da soggetto conoscente a oggetto riconosciuto, da volto personale a faccia identificata, da misura di tutte le cose (per dirla con Protagora) a cosa misurata. Questa «identità impersonale» rischia di perdere la capacità relazionale e pertanto di restare irreale (più che virtuale).
Con questi ondivaghi profili si lascia constatare la condizione tecno-umana. Con l’avvento dell’IA, resa ormai endosomatica (si pensi a Telepathy, il neurochip di Elon Musk), vivere potrebbe voler dire tout court processare al meglio il maggior numero di informazioni. In questa condizione tipicamente transumanistica all’anima, o alla coscienza, o alla ragione, parrebbe voler subentrare l’algoritmo. L’algoritmo, in tal caso, diventerebbe se non il principio vitale del corpo almeno il suo input esistenziale. Giocoforza, il dopo-morte coinciderebbe con la virtualizzazione dell’essere umano – della sua mente, delle sue memorie – dentro un dispositivo informatico: l’ultimo stadio dell’evoluzione umana sarebbe fatalmente postumanistico nel senso più estremo dell’espressione. E, in questa direzione, il vicolo cieco della natura (il corpo senz’anima di taluni approcci neuroscientifici) tenterebbe una sortita oltre di sé, imboccando lo spiraglio dell’IA.
Non resta che sperare che l’homo thecnicus (non propriamente il cyborg) torni a intrecciare creaturalità e creatività, indole naturale e inventiva culturale, vivendo così il suo slancio a trascendersi con una consapevolezza vocazionale, vale a dire non autoreferenziale, relazionale, protesa a incontrare qualcun Altro. Ci sarebbe allora la possibilità di rintracciare nella tecnica una promessa – non certo una premessa – della risurrezione in Cristo, il Crocifisso-Risorto, l’unico che, morendo, abbia sperimentato la fine tuttavia imponendole – mentre ne veniva sopraffatto – di restare penultima.
Per leggere il precedente estratto del saggio
https://ildomaniditalia.eu/un-possibile-umanesimo-non-umano/