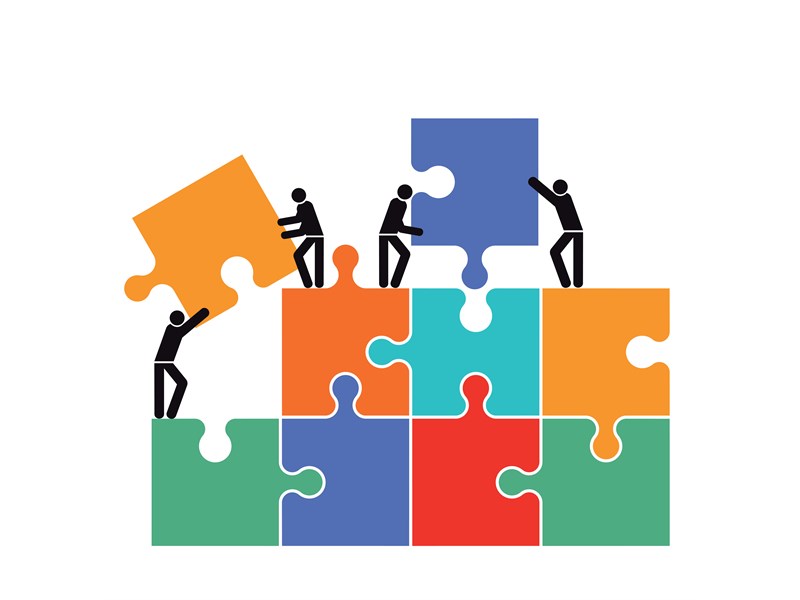Giuseppe Righio
«Continuano a dire che sono una minaccia per la democrazia. Ma io dico: che cosa diavolo ho fatto per la democrazia? La scorsa settimana ho preso una pallottola per la democrazia». Pronunciate nel corso di un comizio, le parole di Donald Trump rievocano l’attentato subito il 13 luglio scorso a Butler, in Pennsylvania, dandogli un’interpretazione particolare. Il tentativo di ucciderlo, fallito per un’inezia, diviene un argomento per smentire chi lo descrive come un pericolo per la tenuta democratica degli Stati Uniti. La frase utilizzata da Trump è suggestiva e fa leva sulle emozioni, ma è ambigua e rischia di essere fuorviante. Che cosa rivela, in effetti, «prendere una pallottola per la democrazia» quando si è candidati alle elezioni presidenziali e al centro di vari procedimenti giudiziari, tra cui quello per l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2020? Che cosa si può dedurre, quando a sparare è un ventenne incensurato, apparentemente sano di mente e senza una ragione politica? Più in generale, quale significato riveste la violenza rivolta contro le istituzioni politiche?
Un’onda di crescente violenza
Quanto accaduto a Trump non è un episodio isolato nella storia degli Stati Uniti, visto che quattro Presidenti sono stati uccisi durante il loro mandato: Lincoln (1865), Garfield (1881), McKinley (1901) e Kennedy (1963). In anni più recenti, sette degli ultimi nove Presidenti sono stati vittime di attentati. Le aggressioni e le minacce non riguardano solo i vertici. Un recente articolo del New York Times descrive la «nuova normalità» in cui politici, giudici e pubblici funzionari si trovano a svolgere le proprie attività (Hakim D. – Bensinger K. – Sullivan E., «‘We’ll See You at Your House’: How Fear and Menace Are Transforming Politics», 19 maggio 2024). Nel 2023, le minacce ai membri del Congresso sono state oltre 8mila (il 50% in più rispetto al 2018) e più di 450 giudici federali hanno subito intimidazioni (circa il 150% in più rispetto al 2019). Il fenomeno riguarda anche i funzionari locali, come emerge da un’inchiesta del 2021 della National League of Cities. I giornalisti osservano preoccupati che «la raffica di minacce, spesso mascherata dall’anonimato online e spinta da opinioni politiche estreme, ha cambiato il modo in cui i funzionari pubblici svolgono il loro lavoro, terrorizzando le loro famiglie e allontanando alcuni dalla vita pubblica».
Non si tratta di un fenomeno solo statunitense, dovuto a una storia segnata fin dalle origini dalla violenza o dalle scelte politiche sul possesso di armi da fuoco. Anchel’Europa non è esente. Ricordiamo l’aggressione contro Silvio Berlusconi a Milano nel 2009 o l’uccisione della parlamentare inglese Jo Cox nel 2016. Il caso più recente è il ferimento del primo ministro slovacco Robert Fico del 15 maggio scorso. Gli episodi di violenza contro i rappresentanti dello Stato sono in aumento, come testimoniano i dati recenti di due grandi Stati europei. In Germania, secondo la polizia, nel 2023 sono stati commessi 2.790 reati contro i politici: i casi di violenza fisica o verbale sono in aumento rispetto al 2022 e quasi raddoppiati negli ultimi cinque anni. Anche in Francia vi è una crescita continua di denunce e segnalazioni, oramai stabilmente oltre la soglia dei duemila casi all’anno.
Una democrazia violenta?
Come ogni sistema politico, anche le democrazie occidentali hanno dovuto fare i conti con la violenza presente nella società, a cui hanno cercato di dare risposte proprie e originali, partendo da una lettura delle cause che possono scatenarla. Tra le soluzioni emerse ne ricordiamo alcune. Innanzi tutto, l’elaborazione del concetto di Stato di diritto come criterio fondamentale nell’azione politica, quale presidio a difesa dei diritti civili, politici e sociali dei cittadini secondo una visione garantista dello Stato. Poi la scelta del meccanismo della rappresentanza parlamentare, ampliatasi progressivamente attraverso l’estensione del diritto di voto a fasce sempre più ampie della popolazione, e il riconoscimento e il sostegno da parte dello Stato ai corpi intermedi, a quelle espressioni organizzate della società civile, che rendono possibile la partecipazione dei cittadini alla vita politica al di là del circuito del voto in occasione delle elezioni.
In filigrana, riconosciamo il bando della violenza, che non può essere una dimensione ordinaria della vita insieme. Questo vale per i membri della collettività, che non possono farvi ricorso per rivendicare i propri diritti o cercare giustizia, e anche per l’esercizio del potere da parte dello Stato democratico, a cui è riconosciuto il monopolio dell’uso legittimo della forza per evitare, secondo la lezione di Hobbes, il tutti contro tutti, senza però che sia arbitrario e violento e a patto che sottostia a regole e limitazioni.
Il modo in cui è stata intesa la violenza nella democrazia, in particolare quella che si manifesta in politica, si può equiparare a una febbre che scuote il corpo sociale. Non è la malattia, ma la manifestazione di un malessere con una radice più profonda: l’esclusione o l’irrilevanza, oggettive o percepite, in cui alcune fasce della società si sentono confinate quando si tratta di affrontare le questioni che riguardano la vita pubblica. Se in politica la dimensione conflittuale è intrinseca, occorre individuare gli strumenti opportuni affinché non deflagri in violenza. La scelta delle democrazie è stata di dotarsi di strumenti che favoriscono un’ampia partecipazione individuale (ad esempio il riconoscimento e la tutela dell’eguaglianza tra i cittadini, dei diritti civili e politici) e collettiva (la libertà di associarsi, di costituire partiti, di informare). La costruzione progressiva delle istituzioni democratiche non è avvenuta ignorando la violenza, come attesta la riflessione filosofica dall’esperienza ateniese fino all’Europa sconvolta dalle guerre nei secoli scorsi, ma cercando di comprenderla per dare una risposta all’altezza, che non fosse a sua volta violenta come accade quando si fa ricorso a politiche repressive.
Per leggere il testo integrale
https://www.aggiornamentisociali.it/articoli/disinnescare-la-retorica-della-violenza-in-politica/