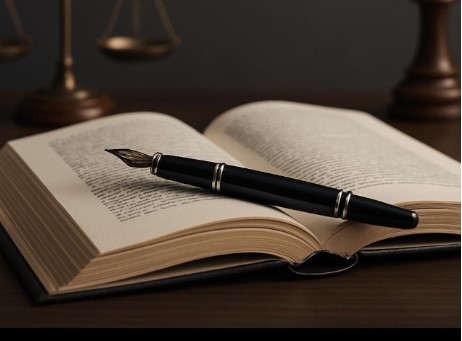Quello che oggi sembra non si comprenda più è che la politica è prima un’arte che una scienza. In quanto arte, essa implica già una tecnica – ma si tratta di una tecnica umana, complessa, empirica, radicata nella prassi e nell’intuito. Non è materia da correggere o addomesticare con algoritmi. È questo l’abbaglio di chi, negli ultimi decenni, ha cercato di ridurre il governo della cosa pubblica a una sequenza di calcoli, delegando alla tecnocrazia funzioni che appartengono alla sovranità popolare come pensata dalla Costituzione.
La competenza politica non è subalterna alla competenza tecnica
I padri costituenti, i De Gasperi, i Pastore, i Malagodi, i Fanfani, i Moro, e persino i disciplinari interni del Pci – così come li conobbero generazioni di militanti – incarnavano una politica che era già competenza, sapere operativo, perizia concreta. Non c’era bisogno di portarsi dietro un ingegnere. Le mediazioni erano ardue, ma la stoffa dei politici sapeva reggerle.
Chi impostava, discuteva e deliberava trattati internazionali non lo faceva da sprovveduto. Donat-Cattin, ad esempio, sulle questioni del lavoro ne sapeva più di un intero studio di giuslavoristi – come una volta osservò, con ammirazione, Michele Tiraboschi durante un convegno a Lecco.
La competenza politica non è meno rigorosa di quella tecnica: è solo più larga, più intrinsecamente legata alla vita e alla responsabilità. *Più dipendente dalla qualità delle Relazioni.
La resa al managerialismo
Il declino dei moderati – e in generale della democrazia rappresentativa – nasce anche da qui: dall’aver inseguito le sirene del managerialismo, confondendo la precisione con la sapienza, la rendicontazione con il giudizio. Si è smarrito il senso del limite. E con esso, come direbbe Ungaretti, “la pace fu persa”.
Invece di ascoltare, valutare e decidere, i politici hanno cominciato a subire i rimbrotti dei tecnici (che sanno le cose a priori), rinunciando progressivamente alla propria funzione. Una rinuncia tanto più grave quanto più visibile: la gente, forse, capisce poco delle dinamiche istituzionali, ma tocca con mano che una commissione tecnica (di nominati) conta più del Parlamento (degli eletti). E allora perché andare a votare? Se le sorti del “tuo voto” sono comunque affidate agli “esperti”, la rappresentanza si svuota, e con essa la cittadinanza.
La tecnica non si ferma a proporre ma dispone
Soprattutto dalla fine del Secolo scorso, la traiettoria della politica – italiana e non solo – è stata una lenta ma continua abdicazione alla tecnica. Forse non ci si è resi conto di quanto la questione fosse capitale, la sua portata. Perché la tecnica, come dice Galimberti, non è uno strumento ma il mondo. La tecnica non un semplice meccanismo ma un dispositivo, e i dispositivi, per loro natura, dispongono. Una volta messi in moto, decidono per noi. E noi, alla fine, obbediamo.
In un simile scenario, è lecito domandarsi: De Gasperi – ad esempio – si sarebbe mai fatto sostituire? Probabilmente no. Avrebbe difeso la politica come funzione primaria, come perspicacia d’azione, responsabilità di governo e visione dell’uomo. Non si sarebbe fatto incantare dal soluzionismo, non avrebbe accettato, come ha detto recentemente Giuliano Pisapia, giunte composte solo da tecnici, che sono sempre – alla lunga – pericolose per la democrazia.
Forse la cifra di quest’epoca l’ha detta per tutto e tutti Finkielkraut: “In un mondo dove non ci sono più adulti, bisogna ricorrere agli esperti”.