Parlerò prevalentemente, seppur brevemente, di Leopoldo Elia uomo politico. Anche se non sarà facile distinguere le due figure di politico e giurista, perché di lui si può dire che c’era il politico nel giurista e il giurista nel politico.
In politica era nota la sua particolare sintonia e consuetudine di rapporti soprattutto con Nino Andreatta e Pietro Scoppola, a cui si aggiunsero negli anni Ottanta Sergio Mattarella e Roberto Ruffilli: un gruppo di intellettuali che ha esercitato un certo peso nelle scelte della Democrazia Cristiana.
Perché la Dc era fatta così: contavano le tessere, contavano le correnti e non di rado le clientele, insomma la dimensione materiale del potere. Ma appena si avvistavano tornanti difficili da superare, calava il silenzio e il chiasso e la disinvoltura facevano spazio al pensiero e a chi era capace di produrlo. Aldo Moro, che è stato maestro e riferimento costante di personalità come quelle che ho menzionato, in alcuni momenti — chiunque fosse formalmente alla guida — diventava il centro attorno a cui gravitava tutta l’iniziativa politica, spesso non solo del suo partito. E i suoi allievi, ognuno con caratteristiche proprie, altrettanto.
Elia era ascoltato, e richiesto spesso di pareri, non solo sulle tematiche istituzionali e costituzionali, ma anche politiche in senso stretto. Gli piaceva discutere di scenari e di futuro. Gli piaceva evocare il passato. Di lui era infatti riconosciuta e ammirata la straordinaria erudizione di conoscenze storiche, coltivata — su suggerimento e insieme a Dossetti — che lo indusse alla conoscenza di autori come Ortega y Gasset e Huizinga. Non riusciva a discutere di politica senza evocare, anche comparativamente con la storia di altri Paesi, soprattutto la Francia e la Germania, le cause generative dei problemi del presente.
Parlare di Elia vuol dire parlare di una generazione di giovanissimi studiosi che sin dai primi anni delle loro ricerche erano in grado di aprire discussioni di livello su riviste come “Cronache Sociali”, intorno a tematiche che continueranno a sviluppare per anni, e per alcuni di loro per tutta la vita, passando dalla campagna amministrativa di Giuseppe Dossetti a Bologna nel 1956 — per il quale prepareranno il famoso “Libro Bianco” — all’accompagnamento dall’esterno di alcune discussioni sul ruolo dei laici nella Chiesa che stavano sviluppandosi all’interno del Concilio Vaticano II, sino al passaggio politicamente decisivo dal centrismo al centrosinistra negli anni Sessanta e infine alla fondazione — una decina d’anni dopo — di quello speciale laboratorio di pensiero democratico contemporaneo rappresentato dalla Lega Democratica, che in una qualche misura orientò non poco, finché fu possibile, l’iniziativa politica del cattolicesimo democratico.
Possiamo dire che il capolavoro di Elia fu quello di aver contribuito, in modo rilevante, con il pensiero e le battaglie parlamentari, a far sopravvivere la Costituzione alle forze politiche che l’avevano elaborata e votata. È morto nel 2008, nel mezzo della stagione berlusconiana caratterizzata dal lento ma progressivo depotenziamento dei presupposti culturali ed etici che continuavano a legittimarla, e proprio quando le campagne elettorali italiane — e ancor più quella in corso negli Stati Uniti che porterà poi all’elezione di Barack Obama — facevano intravvedere il ruolo della rivoluzione digitale nei processi di acquisizione del consenso. Quando, insomma, si cominciava a comprendere come l’organizzazione del consenso veniva surclassata dalla fabbricazione delle motivazioni del consenso. Lui, che tanti studi aveva dedicato al rafforzamento dei partiti politici come veicoli della volontà popolare, cominciava a rendersi conto che proprio le ragioni del consenso stavano per essere progressivamente sottratte alla logica della partecipazione e persino della politica in senso stretto.
Da poco più di una decina d’anni si era riavvicinato a Dossetti, anche se non se ne era mai allontanato veramente, se escludiamo il giudizio sulla prima guerra del Golfo in cui si rammaricava di non poter assecondare la visione di “catastrofista presbite” dell’antico maestro e amico. Ma nel biennio 1994-95, quello della promozione dei Comitati in difesa della Costituzione, torna di nuovo al suo fianco, perché intuisce che è giunto il momento di organizzare una difesa “attiva e creativa” della Carta. E gli dà atto che il suo lavoro per dar vita a una sorta di patriottismo costituzionale che non c’era mai stato veramente ha consentito di riunire ancora una volta cattolici e laici e, soprattutto, “giuristi di scuole diverse”.
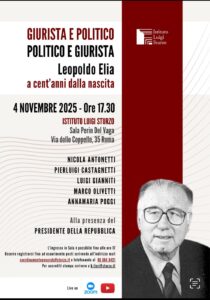
Aggiungeva che gli stimoli che venivano da questa iniziativa dossettiana non si estinguevano con quella campagna e con la morte del suo autore, anzi risultavano di stringente attualità in un tempo caratterizzato da avventate proposte di revisione costituzionale. Insomma, se il prof. Leopoldo Elia negli ultimi anni della sua vita si impegnò tanto nella difesa della Costituzione, non fu per un attaccamento ossessivo a un testo che aveva contribuito fortemente lui stesso a corroborare di motivazioni scientifiche ulteriori rispetto a quelle originarie — al punto che un suo collega costituzionalista (il prof. Valerio Onida) sosteneva che, per varie ragioni, si poteva considerare il prof. Elia un padre costituente — ma fu per la convinzione profonda che la lenta e felpata corrosione dei nuclei fondativi della Carta, come quello della solidità dei partiti politici, potesse essere contenuta e contrastata solo da una più intensa fiducia nelle potenzialità della Costituzione.
Vedeva crescere il prof. Elia, infatti, una preoccupante instabilità del sistema non a causa di una aumentata conflittualità politica come era stata nei primi anni del dopoguerra, ma, al contrario, per un “di meno” di politica, rivelato anche dal progressivo infragilimento di taluni istituti e principi quali quello del contrappesamento dei poteri.
La sottovalutazione e la distrazione rispetto a questi processi (è proprio in questa fase che il professore pubblica la “Costituzione aggredita”, ed. Il Mulino) era frutto di una intenzionale relativizzazione del valore della Carta che lo inquietava molto, essendo lui invece convinto che essa continuasse a rappresentare il baluardo più solido rispetto al rischio di regressione politica generale. Chi avesse voluto favorire un ritorno non tanto al fascismo, quanto a una situazione di democrazia più “sobria”, non avrebbe avuto che da promuovere un alleggerimento dei vincoli interni, quelli della Carta, e dei vincoli esterni, quelli dei Trattati comunitari, che nel tempo avevano reso inattaccabile la nostra democrazia.
La sua ultima battaglia è stata rivolta alla difesa della laicità. Ne ha parlato in un impegnativo intervento al Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti che si tenne a Napoli il 26 e 27 ottobre 2007, e in una intervista al Corriere della Sera (13 febbraio 2007) che fece un certo scalpore, soprattutto in chi non lo conosceva, poiché il principe dei costituzionalisti, parlando con voce sommessa e sorriso mite, disse cose insolitamente dure (come osservò l’intervistatore Aldo Cazzullo) a proposito della presa di posizione della CEI sul disegno di legge del governo Prodi riguardante “Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi”. Di quell’intervista colpiva l’incipit d’apertura: “Forse sarò troppo drastico. Ma preferisco parlar chiaro oggi piuttosto che pentirmi domani per aver taciuto”. In queste parole c’è tutto il vigore di una responsabilità laicale che, soprattutto dopo il Concilio e le sue costituzioni — Lumen Gentium e Gaudium et Spes — non poteva essere rinunciata. Ma c’è anche la consapevolezza che il tema della laicità dello Stato, quando è trattato da politici credenti, assume un rilievo particolare, poiché in loro evoca non solo la dimensione politica ma quella più personale della coscienza: non si tratta del tema dell’obbedienza e della disobbedienza ma di quello della responsabilità, posto che “le leggi vanno fatte per i credenti e per i non credenti”, senza rinunciare beninteso al dovere della profondità e della perdurante centralità del valore della vita e della persona, valori sicuramente costituzionali.
Da ultimo mi concedo una licenza che è quantomeno discutibile, ponendomi la domanda: cosa direbbe e cosa ci suggerirebbe di fare oggi Leopoldo Elia se fosse ancora tra noi? Io credo che ci esorterebbe a ritrovare il senso della politica, ad abbandonare le posture del presentismo e del fatalismo, a non spaventarci dell’IA e — comunque — dei progressi scientifici, a occuparci del fenomeno dell’assenteismo politico ed elettorale in particolare, a cercare di capire le ragioni di un fenomeno che può mettere a rischio la credibilità e la stessa preferibilità della democrazia come sistema di governo delle nazioni e del mondo. Ci suggerirebbe di applicarci soprattutto nello studio di questo fenomeno e scopriremmo forse che esso non è generato tanto da una domanda di maggiore sinistra o maggiore destra, ma da una domanda di un’altra qualità della politica.
“È noto che la politica — amava ripetere Leopoldo Elia citando testualmente Aldo Moro — è un fatto di forza, più propriamente di consapevolezza, di fiducia nel proprio compito, ma ci deve essere più in fondo una ragione, un fondamento ideale, una finalità umana per i quali ci si costituisce in potere e il potere si esercita”.
Se tale ragione ideale, aggiungo io, si rende più visibile ai cittadini, forse l’assenteismo non sarà più un problema.


