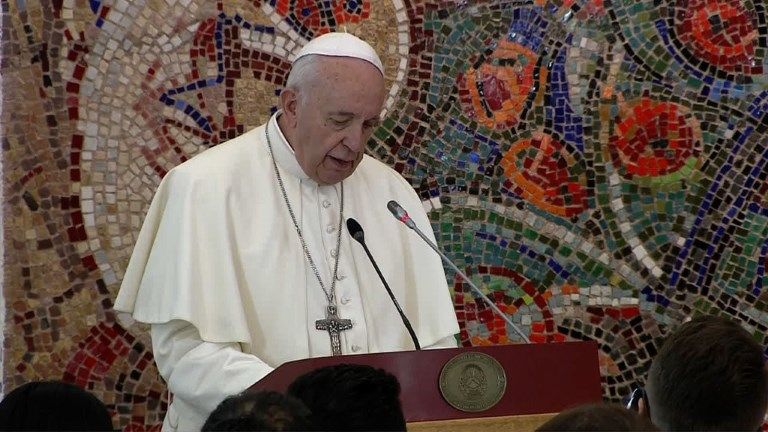La filosofia di Pascal, tutta in paradossi, procede da uno sguardo tanto umile quanto lucido, che cerca di raggiungere «la realtà illuminata dal ragionamento». Egli parte dalla constatazione che l’uomo è come un estraneo a sé stesso, grande e miserabile. Grande per la sua ragione, per la sua capacità di dominare le sue passioni, grande anche «in quanto si riconosce miserabile». In particolare, aspira ad altro che ad appagare i propri istinti o a resistervi, «infatti, ciò che è natura negli animali, noi la chiamiamo miseria nell’uomo». Esiste una sproporzione insopportabile tra, da una parte, la nostra volontà infinita di essere felici e di conoscere la verità e, dall’altra, la nostra ragione limitata e la nostra debolezza fisica, che conduce alla morte. Perché la forza di Pascal è anche nel suo implacabile realismo: «Non occorre un’anima molto elevata per capire che in questo mondo non esistono soddisfazioni autentiche e stabili, che tutti i nostri piaceri non sono altro che vanità e i nostri mali sono infiniti, e che infine la morte, che ci minaccia ad ogni istante, deve immancabilmente metterci entro pochi anni nell’orribile necessità di essere eternamente o annientati o infelici. Nulla è più reale né più terribile di questo. Facciamo pure gli spavaldi quanto vogliamo: ecco la fine che attende la vita più bella del mondo». In questa condizione tragica, si comprende che l’uomo non possa rimanere in sé stesso, poiché la sua miseria e l’incertezza del suo destino gli risultano insopportabili. Ha bisogno quindi di distrarsi, ciò che Pascal riconosce di buon grado: «Da qui deriva che gli uomini amano tanto il clamore e il movimento». Se infatti l’uomo non si distrae dalla propria condizione — e tutti sappiamo tanto bene distrarci con il lavoro, i piaceri o le relazioni familiari o amicali, ma ahimé anche con i vizi a cui ci portano certe passioni — la sua umanità sperimenta «il suo nulla, il suo abbandono, la sua insufficienza, la sua dipendenza, la sua impotenza, il suo vuoto. [Ed escono] dal fondo della sua anima […] la noia, l’umor nero, la tristezza, il dispiacere, la stizza, la disperazione». E tuttavia il divertimento non placa, né colma, il nostro grande desiderio di vita e di felicità. Questo, tutti noi lo sappiamo bene.
È allora che Pascal pone la sua grande ipotesi: «Cosa dunque ci gridano quest’avidità e quest’impotenza, se non che un tempo ci fu nell’uomo un’autentica felicità di cui ora gli restano soltanto il segno e l’orma del tutto vuota, che egli tenta invano di riempire con tutto ciò che lo circonda, chiedendo alle cose assenti l’aiuto che non ottiene dalle presenti? Ma invano, perché quest’abisso infinito non può essere colmato se non da un oggetto infinito e immutabile, ossia da Dio stesso». Se l’uomo è come «un re spodestato», che tende solo a ritrovare la grandezza perduta e che tuttavia se ne vede incapace, chi è dunque? «Quale chimera è dunque l’uomo? Quale stramberia, quale mostruosità, quale caos, quale soggetto di contraddizioni, quale prodigio? Giudice di tutte le cose, debole verme della terra, depositario del vero, cloaca di incertezza e di errore, gloria e rifiuto dell’universo. Chi sbroglierà questo groviglio?». Pascal, come filosofo, vede bene che «quanto più si hanno lumi, tanto più si scopre grandezza e bassezza nell’uomo», ma che questi opposti sono inconciliabili. Perché la ragione umana non può armonizzarli, né risolvere l’enigma.
Per questo Pascal rileva che, se c’è un Dio e se l’uomo ha ricevuto una rivelazione divina — come diverse religioni affermano — e se tale rivelazione è veritiera, là deve trovarsi la risposta che l’uomo attende per risolvere le contraddizioni che lo tormentano: «Le grandezze e le miserie dell’uomo sono così palesi che necessariamente occorre che la vera religione ci insegni che c’è nell’uomo qualche grande principio di grandezza, e che c’è un grande principio di miseria. Inoltre, occorre che essa ci spieghi questi stupefacenti contrasti». Ora, avendo studiato le grandi religioni, Pascal conclude che «nessun pensare e nessun fare ascetico-mistico può offrire una via di salvezza», se non a partire dal «superiore criterio di verità della irradiazione della grazia nell’anima». (37) «Invano, o uomini — scrive Pascal immaginando ciò che il vero Dio potrebbe dirci — cercate in voi stessi il rimedio alle vostre miserie. Tutti i vostri lumi possono giungere al massimo a capire che non troverete in voi né la verità né il bene. I filosofi ve l’hanno promesso e non vi sono riusciti. Essi non sanno né quale sia il vostro vero bene, né quale sia la vostra vera condizione».
Arrivato a questo punto, Pascal, che ha scrutato con la singolare forza della sua intelligenza la condizione umana, la Sacra Scrittura e la tradizione della Chiesa, intende proporsi con la semplicità dello spirito d’infanzia quale umile testimone del Vangelo. È quel cristiano che vuole parlare di Gesù Cristo a quanti concludono un po’ in fretta che non ci sono ragioni consistenti per credere alle verità del cristianesimo. Pascal, al contrario, sa per esperienza che ciò che si trova nella Rivelazione non solo non si oppone alle richieste della ragione, ma apporta la risposta inaudita alla quale nessuna filosofia avrebbe potuto giungere da sé stessa.
Potete leggere il testo integrale della Lettera apostolica