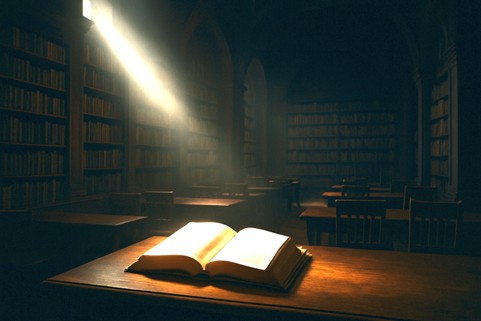Fino a oggi l’editore Adelphi aveva meritoriamente pubblicato trentadue libri a firma Jorge Luis Borges. Arriva in questi giorni in libreria il libro trentatreesimo: La mappa segreta, Testi ritrovati (1933-1983), 288 pagine, 22 euro, traduzione di Rodja Bernardoni. Si tratta di una scelta di saggi e articoli fatta del curatore, Tommaso Scarano, all’interno dei monumentali Textos recobrados 1931-1955 e Textos recobrados 1956-1986, pubblicati nel 2002-3 dalla Emecé di Buenos Aires a opera di Sara Luisa del Carril e Mercedes Rubio de Zocchi.
A consigliarne la lettura basterebbe la presenza di scritti dedicati al Don Chisciotte e alla Divina Commedia, punti fermi dell’esperienza culturale di Borges, sui quali ha lavorato a lungo in maniera illuminante. Riguardo al primo capolavoro troviamo tra l’altro una toccante analisi del suo capitolo finale, quello che descrive la morte del cavaliere, ormai tornato in sé e proprio per questo condannato dal suo creatore a scomparire. Per quello che concerne la Divina Commedia, possiamo leggere ne La mappa segreta il racconto di una serie continua di incontri e approfondimenti che dalla prima, difficile lettura su di un testo con traduzione in inglese a fronte, giunge ad affermare che «la più conosciuta e ripetuta delle terzine, può, un pomeriggio, rivelarmi chi sono o che cos’è l’universo». Dove il delicato “un pomeriggio” conferma la gigantesca levatura letteraria di Borges stesso.
Il libro, con ogni evidenza, è destinato ai cultori dello scrittore argentino. Si potrebbe dire che abbia la forma conversativa dell’incontro tra vecchi amici che da troppo tempo non si rivedono. Scarano ha conservato la successione cronologica degli interventi e questo aiuta a riconoscere linee di tendenza, interessi che maturano, sviluppi in continuità, come la riflessione ininterrotta sull’Argentina e su Buenos Aires in particolare. La città è giudicata qualcosa di più di una capitale: una sorta di centro del Paese, rispetto al quale ogni altra località costituisce una periferia marginale. Tanto che la figura tragica ed eroica del gaucho, mandriano delle grandi pianure, deve raggiungere Buenos Aires e trasferirsi lì per maturare e affermarsi.
Molto interessante anche la ricorrente e approfondita attenzione per Walt Whitman, colosso dell’autorappresentazione poetica degli Stati Uniti, poco conosciuto in Europa ed estraneo al canone del vecchio continente, che ha preferito riconoscere Emily Dickinson quale testimone dell’estetica nordamericana. Forse per una sensibilità maggiormente europea, lontana dai grandi spazi dell’Ovest, nei quali si è affermato il gigantismo, anche letterario, degli Usa. Numerosi i riferimenti a Chesterton, riconosciuto come interprete del meglio della sensibilità britannica, in particolare per le critiche ricevute dallo scrittore londinese da significative componenti della società all’interno della quale si trovò a vivere. Curiosi e commoventi alcuni ricordi d’infanzia, come quelli relativi alla sorella maggiore protettiva e alle case dei nonni, nelle quali si parlavano due lingue diverse, l’inglese in una e lo spagnolo nell’altra, senza che questo apparisse in nessun modo strano ai bimbi.
Il tratto prevalente di Borges, e il più moderno, si conferma, anche negli scritti meno recenti, la capacità di sintesi, di esporre concetti complessi attraverso frasi brucianti quali: «la comparsa di un’opera d’arte influisce su tutte le opere d’arte che l’hanno preceduta» (1933) o «la fama è sempre una semplificazione e a volte una perversione della realtà: non c’è uomo celebre che non sia un po’ calunniato dalla propria fama» (1940).