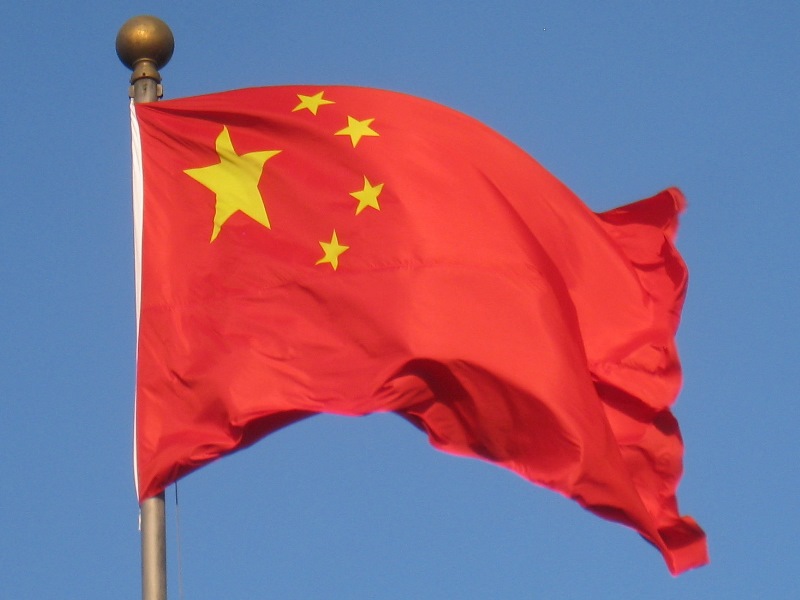Enrico Farinone
Le terrificanti immagini che hanno testimoniato l’uscita di scena forzata dell’ex Presidente Hu Jintao dalla Grande Sala del Popolo dove si celebrava l’ultima giornata del XX° Congresso del Partito Comunista Cinese lo scorso ottobre rappresentano plasticamente quello che la Cina è oggi: una dittatura spietata. Il vecchio capo cerca di rimanere seduto, lì in prima fila a fianco di Xi Jinping, imperturbabile, ma alla fine viene portato via dagli addetti all’incombenza, quasi di peso. Il segnale è preciso: il Congresso è finito e un nuovo gruppo dirigente di stretta fiducia del leader supremo sostituisce completamente gli uomini del vecchio potere. Punto e a capo.
Una dittatura con la quale però bisogna fare i conti. Questa è la realtà con la quale Stati Uniti e Unione Europea devono confrontarsi. Ricordiamo che l’esito del XX° Congresso, ovvero la riconferma per un terzo mandato quinquennale del Presidente Xi Jinping, era probabile ma non scontato. Negli ultimi anni, infatti, Xi ha dovuto affrontare la pandemia da Covid-19 e per farlo ha adottato quella politica di lockdown radicale che ha comportato un indebolimento economico consistente e proteste – per quanto possibili – della popolazione. Sempre il Covid ha prodotto un deterioramento delle relazioni internazionali del Paese, perché in ogni caso l’idea che il virus sia partito dalla Cina a causa di un qualche errore ivi compiuto ha coinvolto molte persone nel globo.
La contrazione che ne è derivata di una crescita economica che sembrava inarrestabile ha generato più di un malumore non solo fra la classe imprenditoriale che traina lo sviluppo materiale della Cina ma pure all’interno del Partito. Al punto che nel corso del 2022 alcuni rumours fatti filtrare dalle altrimenti spesse mura della Città Proibita avevano ipotizzato la detronizzazione di Xi ad opera dell’allora Primo Ministro Li Keqiang, uomo più apprezzato in occidente in quanto ritenuto di visioni più aperte e moderne.
Le cose però sono andate ben diversamente. Xi non solo è stato confermato ma ha pure imposto l’allontanamento dai vertici del potere di tutta la vecchia guardia e la composizione di un Comitato Permanente del Politburo interamente occupato dai suoi fedelissimi. Di questi, il nuovo numero due del partito e quindi nuovo Primo Ministro è Li Qiang, già segretario del partito di Shangai. Il caso è interessante perché molti osservatori ritenevano che se Xi si fosse trovato in difficoltà lo avrebbe sacrificato, essendo egli il responsabile operativo del duro lockdown di due mesi che ha chiuso la seconda città del Paese e che tante proteste popolari ha suscitato. Visto il risultato, evidentemente Xi non solo non ha avuto problemi ma ha avuto la forza per consolidarsi quale dominus assoluto del Partito e dello Stato.
Dal punto di vista della politica estera di Pechino sin dalla sua relazione congressuale Xi aveva ribadito la linea nota su Taiwan, esposta con un tono ancora più assertivo se possibile. La questione, come noto, potrebbe divenire il nuovo e più pericoloso punto di crisi mondiale e la riconferma da parte della leadership mandarina che entro il 2049 (quanto prima?) Taiwan sarà parte integrante della Cina certamente non tranquillizza circa il prossimo futuro. Joe Biden, si ricorderà, un anno fa nel corso della sua visita in Giappone rispose con un franco “yes” alla domanda circa l’eventuale volontà statunitense di difendere militarmente l’isola.
Nei mesi seguiti al Congresso Xi ha dapprima adottato la decisione più attesa all’interno del Paese: la fine della politica zero-contagi e la conseguente ripresa dell’attività economica secondo ritmi più consoni alla Cina dell’ultimo quarto di secolo. E subito dopo ha avviato una risoluta linea di politica estera con la quale ha voluto dimostrare le proprie potenzialità a livello internazionale. La mediazione fra Iran e Arabia Saudita (i cui sviluppi, se ci saranno, potrebbero cambiare radicalmente lo scenario mediorientale e gli stessi rapporti nel mondo islamico) ne è stata al momento il successo più rilevante, ma non l’unico.
Perché anche il “Piano di Pace” per il conflitto ucraino sta ottenendo qualche risultato: tanto per cominciare, l’interessamento da parte di Kiev. I suoi 12 punti programmatici di principio non sono certo stati elaborati per risolvere davvero la questione, essendo troppo lontani dall’affrontare i suoi termini fondamentali, quanto piuttosto per lanciare un messaggio a Putin, ormai considerato uno junior partner: la nostra amicizia è solida, ma quando te lo diremo noi la guerra tu dovrai concluderla. L’atteggiamento possibilista e interlocutorio di Zelensky nei confronti del Piano potrebbe in effetti significare che il Presidente ucraino ha letto la mossa di Pechino proprio in questa ottica.
Tutto però è stato dalla leadership cinese accompagnato da una insistita rivendicazione territoriale su Taiwan, spostata in avanti nel tempo ma al contempo abbinata a manovre militari dimostrative e ad affermazioni sempre più assertive. Fino a che punto si spingerà Xi? Questo è quanto si domandano a Washington. Un tema che verrà posto sul tavolo del prossimo vertice del G7, in Giappone. A poche miglia da Pechino.