Quando ho iniziato a preparare questo intervento sul controverso tema dell’accelerazione nella nostra società ho trovato (appunto) “immediatamente” una quantità esorbitante di articoli, saggi e analisi a riprova del fatto che la questione è aperta, sentita e dolorosa e che nonostante ciò ognuno ne trae all’occorrenza anche il suo beneficio.
Ho letto con interesse una moltitudine di testi messi a disposizione online e consultato perfino un libro consigliatomi da un blog sulla materia…con il risultato che più riflettevo sugli effetti collaterali della vita ad alta velocità più lavoravo con estrema e ritrovata lentezza, rischiando per altro di arrivare impreparata all’appuntamento.
Cosa ho appreso?
– Stiamo andando troppo veloci senza sapere verso dove né tanto meno perché;
– Continuiamo a non aver capito un accidente del senso ultimo dell’esistenza, anzi possibilmente più corriamo e meno ne sappiamo;
– Abbiamo abbandonato le giovani generazioni in prima linea nella ridicola lotta contro il tempo (e lo spazio): la gen-Z è la fascia più appetibile del mercato ma anche la più martoriata dai ritmi incalzanti di una vita al massimo, lasciata per lo più priva di strumenti per difendersene.
Da docente di Lettere, dopo  aver letto questa lunga serie di ottime dissertazioni scientifiche di cui sopra, sono tornata alla Letteratura che prima di tutti e spesso meglio di tutti racconta vizi e virtù della nostra fragile umanità. Ho deciso, allora, di cominciare da una frase: “Io, se avessi cinquantatré minuti da spendere, camminerei adagio adagio verso una fontana…”. Siamo al capitolo XXIII del Piccolo Principe e il nostro giovane protagonista con genuina e spiazzante saggezza si rivolge così al mercante di pillole che levano la sete e quindi fanno risparmiare un certo numero di minuti alla settimana. Con una semplice e genuina affermazione egli oppone alla logica acefala della velocità e del risparmio di secondi quella di una lentezza carica di senso. Ed è lui lo stesso Piccolo Principe a cui una simpatica volpe ha spiegato magistralmente, in un paio di capitoli precedenti, che è proprio il tempo perduto per accudire la sua rosa a renderla così speciale.
aver letto questa lunga serie di ottime dissertazioni scientifiche di cui sopra, sono tornata alla Letteratura che prima di tutti e spesso meglio di tutti racconta vizi e virtù della nostra fragile umanità. Ho deciso, allora, di cominciare da una frase: “Io, se avessi cinquantatré minuti da spendere, camminerei adagio adagio verso una fontana…”. Siamo al capitolo XXIII del Piccolo Principe e il nostro giovane protagonista con genuina e spiazzante saggezza si rivolge così al mercante di pillole che levano la sete e quindi fanno risparmiare un certo numero di minuti alla settimana. Con una semplice e genuina affermazione egli oppone alla logica acefala della velocità e del risparmio di secondi quella di una lentezza carica di senso. Ed è lui lo stesso Piccolo Principe a cui una simpatica volpe ha spiegato magistralmente, in un paio di capitoli precedenti, che è proprio il tempo perduto per accudire la sua rosa a renderla così speciale.
Del resto, il senso è che la fiducia si conquista deponendo la fretta e prestando attenzione agli incontri, perché solo attraverso la pazienza, la gradualità e la fedeltà ci si può “addomesticare”. Ed “addomesticare” (e lasciarsi “addomesticare”) è innanzitutto una responsabilità emotiva, una delle responsabilità, forse la principale, che nella nostra epoca fatichiamo a prenderci. Ecco, comprendere questo assunto è forse il significato più interessante del viaggio del Piccolo Principe e più che mai oggi dovrebbe essere il significato anche del nostro di viaggio, così contaminato da quella che il sociologo Paul Virilio chiama la dromocrazia, ossia il potere consegnato alla rapidità.
 Lo sapeva bene Collodi (anche senza aver letto Virilio) che del burattino toscano campione di velocità e frenesia, quel Pinocchio spasmodicamente affamato di novità e di esperienza, ne ha fatto una metaforica quanto impeccabile profezia dell’uomo contemporaneo, in balia degli eventi e intrappolato nel suo moto tanto continuo quanto ingannevole. E lo sappiamo bene anche noi insegnanti che come dice Rosseau nell’Emilé, facciamo “un mestiere in cui bisogna saper perdere tempo per guadagnarne”. L’apprendimento, l’assimilazione, la lettura, la riflessione, la ricerca, il discernimento, la rielaborazione sono attività cognitive per le quali valgono più o meno gli stessi domini temporali da secoli e secoli, non c’è progresso che tenga: quando si tratta di imparare bisogna riuscire a rallentare, il tempo del pensiero non sarà mai il tempo del motore. Eppure, approfondire, scandagliare, sperimentare sembrano non essere più delle priorità nel nostro universo iper connesso e iper complesso dove restare in una dimensione orizzontale e quindi superficiale e quindi banale è di gran lunga più consigliato di addentrarsi nelle vertiginose profondità della nostra dimensione verticale.
Lo sapeva bene Collodi (anche senza aver letto Virilio) che del burattino toscano campione di velocità e frenesia, quel Pinocchio spasmodicamente affamato di novità e di esperienza, ne ha fatto una metaforica quanto impeccabile profezia dell’uomo contemporaneo, in balia degli eventi e intrappolato nel suo moto tanto continuo quanto ingannevole. E lo sappiamo bene anche noi insegnanti che come dice Rosseau nell’Emilé, facciamo “un mestiere in cui bisogna saper perdere tempo per guadagnarne”. L’apprendimento, l’assimilazione, la lettura, la riflessione, la ricerca, il discernimento, la rielaborazione sono attività cognitive per le quali valgono più o meno gli stessi domini temporali da secoli e secoli, non c’è progresso che tenga: quando si tratta di imparare bisogna riuscire a rallentare, il tempo del pensiero non sarà mai il tempo del motore. Eppure, approfondire, scandagliare, sperimentare sembrano non essere più delle priorità nel nostro universo iper connesso e iper complesso dove restare in una dimensione orizzontale e quindi superficiale e quindi banale è di gran lunga più consigliato di addentrarsi nelle vertiginose profondità della nostra dimensione verticale.
Cosa può fare la scuola per le nuove generazioni immerse nella pervasiva onnipresenza della tecnologia, invorticate nella cronofagia, indotte a fagocitare tempo, prodotti, relazioni con il minor sforzo cerebrale possibile? La scuola può provare a salvare il salvabile con gli strumenti che ha, molto pochi, e con le risorse umane di cui dispone, per fortuna ancora generose. Com’è lo stato dell’arte? Pessimo: i nostri ragazzi sono ultra sollecitati da stimoli continui e contraddittori, incastrati in luoghi virtuali solo apparentemente illimitati che accorciano i loro orizzonti, comprimono le loro energie, ostacolano quotidianamente la loro immaginazione e li riducono a meri contenitori di dati commerciali rivendibili al miglior offerente. E ancora sono attanagliati dall’invidia e dalla mitizzazione, (i più grandi combustibili dei social network), sono invasi in ogni sfera, anche la più intima, dai tentacoli del web: insicuri, arrendevoli, pavidi, scoraggiati, disarmati e disarmanti.
Ma soprattutto frettolosi.
Eppure, se le attività di ogni giorno sono sempre “più facili e veloci” e se, come vogliamo far credere loro, “si può avere tutto e subito”, perché sembra non abbiano mai abbastanza tempo e perché sembra non riescano mai ad essere soddisfatti dei loro traguardi? E come mai se ci sono così tante imperdibili avventure da affrontare “al top”, due giovani su cinque tra i 25 e i 30 anni trascorrono le loro giornate senza né studiare né lavorare e perché la maggior parte dei miei studenti adolescenti dichiara di morire di noia ogni pomeriggio? E inoltre, se lo scopo dei potenti mezzi di comunicazione era connettere più persone possibile simultaneamente ed efficacemente, perché i ragazzi si sentono così terribilmente soli? …Perché ci sentiamo così terribilmente soli?
 Del resto, ammettiamolo, i giovani sono solo più esposti e meno consapevoli, ma la realtà è che il loro disagio riguarda a livelli diversi noi tutti. Il sovraccarico di comunicazioni crea impasse e frustrazione, (prendiamo ad esempio la mole di mail che riceviamo ogni giorno sulle nostre caselle e la loro conseguente saturazione), così come il sovrannumero di macchine e persone nelle nostre aree urbane crea blocchi e intasamenti. Allo stesso modo, la foga di fare ingenera la nostra poca voglia di fare, perdiamo prezioso tempo a scrollare un telefono (come tra l’altro alcuni di voi staranno probabilmente facendo anche adesso per scarso interesse) poiché manca la percezione di investire opportunamente il tempo, fosse anche solo per ritrovare un vecchio ricordo. Manca la cura del tempo. La depressione non è mai stata così diffusa e, ahimè, sembrerebbe funzionare come la sclerotizzazione del movimento, un movimento eccessivo, dispersivo, febbricitante, disarticolato che porta in ultima istanza alla paralisi.
Del resto, ammettiamolo, i giovani sono solo più esposti e meno consapevoli, ma la realtà è che il loro disagio riguarda a livelli diversi noi tutti. Il sovraccarico di comunicazioni crea impasse e frustrazione, (prendiamo ad esempio la mole di mail che riceviamo ogni giorno sulle nostre caselle e la loro conseguente saturazione), così come il sovrannumero di macchine e persone nelle nostre aree urbane crea blocchi e intasamenti. Allo stesso modo, la foga di fare ingenera la nostra poca voglia di fare, perdiamo prezioso tempo a scrollare un telefono (come tra l’altro alcuni di voi staranno probabilmente facendo anche adesso per scarso interesse) poiché manca la percezione di investire opportunamente il tempo, fosse anche solo per ritrovare un vecchio ricordo. Manca la cura del tempo. La depressione non è mai stata così diffusa e, ahimè, sembrerebbe funzionare come la sclerotizzazione del movimento, un movimento eccessivo, dispersivo, febbricitante, disarticolato che porta in ultima istanza alla paralisi.
Lo so, speravate che vi dessi buone notizie, ma non è questo il caso. Possiamo, tuttavia, consolarci ripercorrendo un po’ la storia di questa accelerazione che oggi ricasca così violentemente sulle spalle dei nostri nipoti, figli o studenti. Il progresso è un fenomeno che ha interessato l’intera umanità sin dai tempi più antichi, lo slancio verso il cambiamento ha caratterizzato da sempre la nostra specie, trovando forse la maggior espressione nell’ambizioso uomo europeo dell’età moderna. Le ore, i minuti, i secondi, gli istanti si sono messi a correre a partire dalla Rivoluzione Scientifica e Industriale, ma anche attraverso il mito americano della conquista del West, trasportati ad alto voltaggio dall’ampliamento della frontiera. Era il 1872 quando nel suo immaginifico “giro del mondo in ottanta giorni” Verne fantasticava sull’abbattimento dei tempi di percorrenza del Pianeta e sulla contrazione delle lunghe distanze attraverso efficientissimi mezzi di trasporto, qualche decennio dopo accadeva davvero. Nel primo Novecento i Futuristi italiani affermavano nel loro Manifesto che la magnificenza del mondo si era arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. “Un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia” scriveva Marinetti. Quanti ne ha fatti di danni poi quella “mitraglia”…
 Dal cronometro di Taylor introdotto in fabbrica agli attuali sistemi di rilevazioni e tracciabilità, la cultura della sorveglianza non si è mai arrestata, solo affinata, come il resto dei brevetti, fino ad arrivare ai giorni nostri: nella realtà aumentata i battiti delle nostre palpebre possono perfino dare impercettibili comandi digitali, eserciti di algoritmi istantanei governano mercati finanziari ormai completamente scollati dall’effettiva produzione industriale, vorticose salite di titoli si alternano a fulminee cadute di interi sistemi economici, la precarietà del mondo al galoppo si allarga a macchia d’olio alle comunità umane dandoci l’impressione, attraverso i mezzi di informazione, di transitare di fatto da una catastrofe all’altra.
Dal cronometro di Taylor introdotto in fabbrica agli attuali sistemi di rilevazioni e tracciabilità, la cultura della sorveglianza non si è mai arrestata, solo affinata, come il resto dei brevetti, fino ad arrivare ai giorni nostri: nella realtà aumentata i battiti delle nostre palpebre possono perfino dare impercettibili comandi digitali, eserciti di algoritmi istantanei governano mercati finanziari ormai completamente scollati dall’effettiva produzione industriale, vorticose salite di titoli si alternano a fulminee cadute di interi sistemi economici, la precarietà del mondo al galoppo si allarga a macchia d’olio alle comunità umane dandoci l’impressione, attraverso i mezzi di informazione, di transitare di fatto da una catastrofe all’altra.
Pensate che, secondo il filosofo Andrea Colamedici, oggi il peggior competitor di un’azienda non è affatto un’altra azienda dello stesso settore, ma è l’uomo che dorme, poiché non consuma. E non corre. Le vite nostre e quelle dei nostri figli o studenti sono programmate in ogni dettaglio, perfino il relax o il piacere sono “schedulati” dentro rigide pianificazioni, e questo perché non stare al passo (svelto) “di tutti gli altri” vuol dire rischiare di diventare obsoleti, come un prodotto superato, nella china scivolosa di un anacronismo. Quando Pascal scriveva che tutta l’infelicità degli esseri umani derivava dal non saper restarsene tranquilli in una stanza, non immaginava proprio che di lì a poco l’uomo non sarebbe più riuscito a starsene tranquillo neanche in quella stanza: una stanza da cui a ben vedere oggi possiamo potenzialmente acquistare e raggiungere tutto…tranne la felicità.
E così i rapporti sono effimeri, l’ansia è epidemica e si seda con rimedi farmacologici, la spiritualità va bene solo se è monetizzabile, lo studio serve solo se è sufficientemente specifico e spendibile nel mercato del lavoro, i messaggi vocali WhatsApp si alterano per velocizzarli, le attese (di una risposta, di un semaforo verde, dello smaltimento di una coda di traffico) diventano insopportabili. Per “fortuna”, i nostri schermi ammortizzano questi temuti interstizi di tempo, questi “vuoti d’aria”. Ma cos’è che non vogliamo sentire in quelle pause che non ci concediamo più? Con tutta probabilità quando non ci fermiamo è la morte che non vogliamo sentire, la grande rivale grazie alla quale abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto, nel bene e nel male. Eppure, rimuoverla, rifuggirla, significa rifuggire anche dalla vita che le è indissolubilmente legata, in un rovescio della medaglia.
 Sono cresciuta dentro un’Accademia, l’Accademia Nazionale di Danza. Nella musica e nella danza, come anche nella recitazione, le pause hanno esattamente lo stesso valore del suono, se non maggiore… dialogano con l’azione, esprimono una loro identità, danno tempo al tempo del recupero, della sedimentazione, del raccolto, tanto all’artista quanto allo spettatore. I tempi delle pause, i tempi lenti, o meglio sarebbe dire i tempi giusti, sono poi a ben vedere gli stessi della natura, della preghiera, della gravidanza, del battito del cuore, dei cambiamenti sociali. E se la pausa è invece percepita come pigrizia, come assenza di buona volontà e di operatività, allora l’agire senza tregua ci sottrae dall’ozio. Ma cos’è l’ozio se non quel concetto che gli Antichi Romani tanto amavano nella consapevolezza che esso servisse a creare bene e meglio. Nella gerarchia dei romani lo status sociale di un cittadino dipendeva da quanto tempo poteva dedicare allo svago. Gli sfortunati, invece, caterve di schiavi e simili, erano intenti a mandare materialmente avanti l’impero e non potevano che occuparsi del “nec otium”. Ossia della negazione dell’ozio.
Sono cresciuta dentro un’Accademia, l’Accademia Nazionale di Danza. Nella musica e nella danza, come anche nella recitazione, le pause hanno esattamente lo stesso valore del suono, se non maggiore… dialogano con l’azione, esprimono una loro identità, danno tempo al tempo del recupero, della sedimentazione, del raccolto, tanto all’artista quanto allo spettatore. I tempi delle pause, i tempi lenti, o meglio sarebbe dire i tempi giusti, sono poi a ben vedere gli stessi della natura, della preghiera, della gravidanza, del battito del cuore, dei cambiamenti sociali. E se la pausa è invece percepita come pigrizia, come assenza di buona volontà e di operatività, allora l’agire senza tregua ci sottrae dall’ozio. Ma cos’è l’ozio se non quel concetto che gli Antichi Romani tanto amavano nella consapevolezza che esso servisse a creare bene e meglio. Nella gerarchia dei romani lo status sociale di un cittadino dipendeva da quanto tempo poteva dedicare allo svago. Gli sfortunati, invece, caterve di schiavi e simili, erano intenti a mandare materialmente avanti l’impero e non potevano che occuparsi del “nec otium”. Ossia della negazione dell’ozio.
Nella nostra società invece assistiamo al paradosso che solo chi è sempre a lavoro, produttivo e reperibile è lodevole e degno di stima.
Troppo occupati nel nostro agire fatichiamo alla fine a pensare autonomamente senza prima aver consultato quello che le nostre rassicuranti indicizzazioni ci consigliano nei feed. Il villaggio globale tanto auspicato non è stato mai veramente fondato, diciamolo una buona volta: abitiamo piuttosto micro enclave abbastanza smarrite nell’individualismo, nell’utilità, nella concorrenza, nel consumo, nell’iper personalizzazione, mentre l’umanità dovrebbe essere nutrita dalla comunità, dalla cooperazione e dalla condivisione. Il vero quesito, dunque, che mi e vi pongo è quale ruolo vogliamo dare al passato e al futuro, considerando che viviamo in un presente esteso e onnipresente, sempre più accentuato ed enfatizzato. Le visioni di breve termine non portano lontano perché sono le esperienze che richiedono una costruzione strutturata e progressiva quelle che gettano fondamenta stabili per il futuro, per la società e per la memoria collettiva.
Occorre riflettere sul fatto che il tempo prima ancora di essere una merce di scambio è, come spiega Sant’Agostino, “una dimensione interna che coinvolge l’essere umano integralmente”. Non solo quindi una dimensione consequenziale e lineare, ma anche trascendentale e intima. C’è una dimensione del tempo che non si può misurare, ma non per questo è meno reale. Invece, noi, dimenticandolo, avanziamo di corsa, a colpi di Post e di App, verso un futuro senza avvenire da osservare in mondovisione tra un incidente in diretta e una scoperta per procedere più veloci privi di meta. Atleti del nulla. Meglio le ali spiegate della Nike di Samotracia, l’automobile ruggente io la lascio ai piloti.
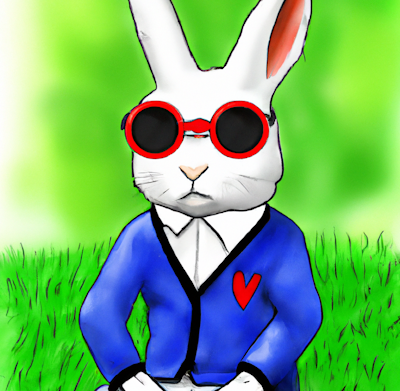 In conclusione, la cattiva notizia è che il tempo è diventato redditizio tanto quanto il petrolio, se non di più, perché la sua accelerazione è uno dei massimi paradigmi del nostro sistema sociale. Ma una buona notizia c’è ed è che in parte ne siamo ancora padroni e abbiamo il dovere di farlo capire ai nostri ragazzi. Non è eliminando lo sviluppo informatico che risolveremo il problema, piuttosto rimettendo in discussione il suo scopo. E chiudo con il capolavoro di Lewis Carroll: “Per quanto tempo è per sempre?” chiede Alice al Bianconiglio. E il Bianconiglio risponde: “Alle volte, solo un secondo”. Cerchiamo di sentirlo ancora scorrere questo infinito, infinito secondo.
In conclusione, la cattiva notizia è che il tempo è diventato redditizio tanto quanto il petrolio, se non di più, perché la sua accelerazione è uno dei massimi paradigmi del nostro sistema sociale. Ma una buona notizia c’è ed è che in parte ne siamo ancora padroni e abbiamo il dovere di farlo capire ai nostri ragazzi. Non è eliminando lo sviluppo informatico che risolveremo il problema, piuttosto rimettendo in discussione il suo scopo. E chiudo con il capolavoro di Lewis Carroll: “Per quanto tempo è per sempre?” chiede Alice al Bianconiglio. E il Bianconiglio risponde: “Alle volte, solo un secondo”. Cerchiamo di sentirlo ancora scorrere questo infinito, infinito secondo.

