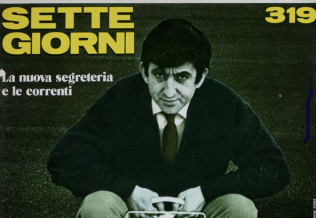Dalle notizie che giungono dal Cile non è ancora possibile conoscere i risvolti della vicenda delle dimissioni – annunciate e ritirate nel giro di 24 ore – dell’intero governo, nel vortice di una crisi economica e sociale sempre più grave (a causa dello sciopero degli autotrasportatori manca l’approvvigionamento dei beni di prima necessità e del carburante per le auto e per il riscaldamento) e all’indomani della pausa intervenuta nel dialogo tra Unitad popular e la democrazia cristiana. Un significativo rimpasto ministeriale era stato chiesto dalla Dc, come una delle condizioni per avviare un diverso rapporto tra governo e opposizione. Allende, però, ha solo ritardato i tempi del rimpasto: avverrà “quando le circostanze politiche saranno opportune“, ha detto.
Contrario nei giorni scorsi a un inserimento dei militari nel gabinetto, potrebbe essere indotto a cambiare opinione sia per far fronte allo “stato di necessità” (cioè, per intervenire con maggiore energia contro la paralisi economica provocata dagli autotrasportatori, come già fece nell’autunno scorso), sia per favorire e accelerare un compromesso con il partito democristiano.
La Dc aveva chiesto, infatti, che la presenza dei militari fosse massiccia ma potrebbe, infine, ridurre le proprie pretese al riguardo, qualora gli fossero accordate alcune garanzie politiche. Il rischio di un condizionamento delle forze politiche da parte di militari è, del resto, presente anche in un paese come il Cile dove pure le forze armate hanno una lunga tradizione democratica e ancora di recente hanno dato prova di fedeltà ai doveri che la costituzione loro impone.
Il dialogo tra la Dc e il governo si è sviluppato nel corso di due giornate: 30 e 31 luglio. Alla vigilia, il presidente democristiano Patricio Aylwin aveva illustrato, a grandi linee, la piattaforma del partito mostrandosi fiducioso nei confronti di un compromesso che avrebbe potuto portare anche un inserimento della Dc nel governo. Il clima era disteso tra le parti malgrado il partito socialista – diviso nel suo interno, dove tuttavia prevale la linea radicale e intransigente – avesse, attraverso suoi qualificati esponenti, manifestato perplessità, critiche e anche aperte ostilità al dialogo. Aveva detto il segretario generale socialista Altamirano il 12 luglio: non accetteremo mai la conciliazione con “i nemici del Cile, del governo popolare, dei lavoratori”; “in questo momento qualsiasi accordo con la democrazia cristiana servirebbe soltanto favorire i gruppi faziosi che operano nel suo seno e nelle alte sfere reazionarie, il cui unico immutabile obiettivo consiste nel recupero del potere e dei suoi privilegi”.
Era dovuto intervenire il segretario del partito comunista Louis Corvalan, che in un discorso al comitato centrale avvertiva che “il dialogo non è né sarà facile“, tuttavia, abbattuti i primi ostacoli, non ci si sarebbe dovuti tirare indietro; bisognava invece fare di tutto per “unire la maggioranza dei cittadini contro coloro che si sono lanciati sul cammino della situazione: la maggioranza del paese – proseguiva – indipendentemente se abbia o no simpatia per il governo, non ne vuole il rovesciamento e ne riconosce la legittimità”.
Un dialogo franco è stato quello tra Allende e Aylwin. Sulla sua interruzione – provocata certo da difficoltà nel trovare l’intesa e quindi dalla necessità di un riesame delle posizioni – non sono mancate le speculazioni di chi, per ragioni diverse, aveva interesse a farlo naufragare: sia da parte della destra democristiana e del partito nazionale che teme un suo isolamento all’opposizione, sia da parte di alcune componenti di Unitad popolar, in special modo dei socialisti. Ma il filo del confronto non si è spezzato. “sostanzialmente positiva”, è stata definita da Aylwin la risposta che Allende ha dato il 3 agosto alle richieste che la Dc gli aveva consegnato in dossier, al termine della prima fase di incontri.
Questa dossier conteneva alcune precise condizioni per un modo diverso di stare all’opposizione della Dc. Le principali sono: assicurare l’ordine costituzionale e la piena applicazione dello stato di diritto; far rispettare il mandato costituzionale secondo cui le forze armate e i corpi di polizia sono “i soli depositari della forza”: ciò significa che devono essere sciolti e dichiarati illegali tutti i gruppi armati paramilitari; mettere fine a tutte le forme di occupazione delle fabbriche o di altre proprietà da parte di “gruppi minoritari che si ergono a rappresentanti del popolo e dei lavoratori per imporre i loro voleri con la forza”; definire una volta per tutte il regime di proprietà dell’imprese, delimitando logicamente il settore sociale, quello misto e quello privato, e regolamentando la partecipazione dei lavoratori; infine, la formazione di un di un ministero con la partecipazione delle forze armate, “dotato di sufficienti poteri”.
La risposta di Allende è sembrata soddisfacente al partito democristiano. Allende, in sostanza, ha detto che avrebbe potuto accettare il progetto di riforma costituzionale democristiano, già approvato dal parlamento ma bloccato dal veto presidenziale, a patto, però, che la Camera e il Senato si impegnassero (e quindi si impegnasse anche la Dc) a varare una serie di disegni di legge che consoliderebbero alcune riforme di struttura e offrirebbero al governo adeguati poteri nel settore industriale e commerciale. Queste misure prevedono, tra l’altro: l’esclusività dei poteri dello Stato nei settori strategici della economia; la definizione dei poteri del governo nella requisizione di aziende industriali e commerciali; la delimitazione delle tre aree economiche (sociale, privata e mista); garanzie per la piccola e media industria; definizione della “autogestione“ dei lavoratori in alcune aziende requisite; maggiori poteri al governo per la repressione dei diritti economici, quali il mercato nero e le speculazioni, che tanta parte hanno avuto nell’aggravamento della crisi sociale ed economica del paese.
È sui contenuti concreti di queste misure che il dialogo tra Dc e Allende dovrebbe proseguire e concludere positivamente nei prossimi giorni. Se non avverranno impennate della destra, ma anche della sinistra radicale del partito socialista preoccupata soprattutto di tenere relegata la Dc all’opposizione.
N.B. Il titolo dell’articolo, pubblicato sul numero 319 di “Settegiorni” (12 agosto 1973) era il seguente: “Cile. L’accordo possibile”. La sigla P.d.S., apposta alla fine del pezzo, lascia intendere che l’autore fosse Pino di Salvo, uno dei principali redattori della rivista. La rilettura di questo resoconto accurato è importante anche in vista delle iniziative – in primo luogo quella annunciata dall’Istituto Sturzo – per l’inquadramento storico e il riesame critico, a cinquant’anni di distanza, delle tragiche vicende cilene. Come è noto, i militari di Pinochet presero il potere l’11 settembre del 1973 a seguito di una cruenta operazione che portò all’assalto della Moneda, sede ufficiale del Presidente della Repubblica, e al suicidio di Salvador Allende. Il colpo di stato indusse il segretario del Pci, Enrico Berlinguer, a scrivere per “Rinascita” – il settimanale ufficiale delle Botteghe Oscure – tre fondamentali articoli, raccolti poi nel saggio “Riflessioni sull’Italia dopo i fatti del Cile”, da cui scaturì la proposta del compromesso storico.