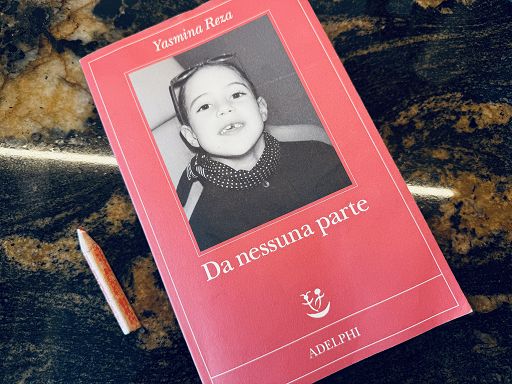Roma, 28 feb. (askanews) – Alleati e avversari degli Stati Uniti hanno reagito agli attacchi congiunti lanciati questa mattina da Washington e dall’alleato Israele contro l’Iran, con alcuni stretti partner americani che hanno definito la situazione ‘grave’ e ‘pericolosa’.
– Unione europea La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha definito gli ‘sviluppi’ in Iran ‘estremamente preoccupanti’. Ha ricordato le sanzioni dell’Ue contro il regime iraniano e i suoi Guardiani della Rivoluzione, affermando che ‘garantire la sicurezza nucleare e prevenire qualsiasi azione che possa ulteriormente aggravare le tensioni o minare il regime globale di non proliferazione è di importanza cruciale’.
Ha inoltre sottolineato che Bruxelles ha ‘costantemente promosso sforzi diplomatici volti ad affrontare i programmi nucleare e balistico attraverso una soluzione negoziata’. L’invito a ‘tutte le parti è esercitare la massima moderazione, proteggere i civili e rispettare pienamente il diritto internazionale’, ha dichiarato Von der Leyen.
Kaja Kallas, alta rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, ha dichiarato di aver parlato con il ministro degli Esteri israeliano e con altri funzionari della regione, aggiungendo che ‘l’Ue sta inoltre coordinandosi strettamente con i partner arabi per esplorare percorsi diplomatici. La protezione dei civili e il diritto internazionale umanitario sono una priorità’.
Ha precisato che una missione navale europea nel Mar Rosso è in stato di massima allerta e pronta ad aiutare a mantenere aperto il corridoio marittimo.
– Nazioni Unite Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato ‘l’escalation militare odierna in Medio Oriente’, affermando che l’operazione e la risposta iraniana minano ‘la pace e la sicurezza internazionale’.
‘Chiedo l’immediata cessazione delle ostilità e la de-escalation’, ha dichiarato Guterres. ‘In caso contrario, si rischia un conflitto regionale più ampio con gravi conseguenze per i civili e la stabilità regionale. Incoraggio con forza tutte le parti a tornare immediatamente al tavolo dei negoziati’.
Guterres ha inoltre sottolineato che i membri delle Nazioni Unite ‘devono rispettare i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale’, inclusa la Carta dell’Onu, che vieta ‘la minaccia o l’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi stato’.
Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu dovrebbe riunirsi alle 16 di sabato (le 22 italiane) presso la sede di New York per una riunione d’emergenza.
– Italia A seguito dell’aggravarsi della crisi in Medio Oriente, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato una riunione telefonica con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, e il ministro della Difesa Guido Crosetto, oltre ai sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.
Tajani ha chiarito che nessun italiano è coinvolto e ha espresso la convinzione che quello di Stati Uniti e Israele ‘non sarà certamente l’attacco di un giorno’. Ha aggiunto di non credere che ‘l’Iran abbia interesse’ a estendere il conflitto’ perchè ‘sarebbe la sua fine non avendo la forza di resistere a lungo ad un attacco congiunto di Usa e Israele. – Russia La Russia ha condannato gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. ‘Washington e Tel Aviv hanno ancora una volta intrapreso un percorso pericoloso che sta rapidamente spingendo la regione verso un disastro umanitario, economico e potenzialmente persino radiologico’, ha dichiarato il ministero degli Esteri russo.
‘La natura sostenuta e sistematica degli attacchi destabilizzanti condotti dall’amministrazione statunitense contro i principi fondamentali dell’ordine giuridico internazionale negli ultimi mesi suscita particolare timore’, ha aggiunto il ministero, chiedendo ‘un immediato ritorno a un percorso politico e diplomatico’.
– Regno Unito ‘All’Iran non deve mai essere consentito di sviluppare un’arma nucleare ed è per questo che abbiamo costantemente sostenuto gli sforzi per raggiungere una soluzione negoziata’, ha sottolineato un portavoce del governo del Regno Unito.
Londra non ha partecipato all’attacco Usa-Israele contro l’Iran e il primo ministro Keir Starmer era previsto presiedesse una riunione d’emergenza dei ministri nel corso della giornata. La Gran Bretagna è pronta a proteggere i propri interessi nella regione e ‘non vuole assistere a un’ulteriore escalation verso un conflitto regionale più ampio’.
– Francia Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che ‘lo scoppio di una guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran comporta gravi conseguenze per la pace e la sicurezza internazionale’.
Macron ha affermato che la Francia è pronta a dispiegare risorse per proteggere i propri partner, se richiesto. ‘L’escalation in corso è pericolosa per tutti. Deve fermarsi. Il regime iraniano deve capire che non ha altra scelta se non impegnarsi in negoziati in buona fede per porre fine ai suoi programmi nucleare e balistico, così come alle sue azioni di destabilizzazione regionale. Questo è assolutamente essenziale per la sicurezza di tutti in Medio Oriente. Anche il popolo iraniano deve poter costruire liberamente il proprio futuro. I massacri perpetrati dal regime islamico lo squalificano e richiedono che la parola venga restituita al popolo. Prima sarà, meglio sarà’, ha dichiarato Macron.
– Canada Il primo ministro del Canada, Mark Carney, ha affermato: ‘La Repubblica Islamica dell’Iran è la principale fonte di instabilità e terrore in tutto il Medio Oriente, ha uno dei peggiori record di diritti umani al mondo e non deve mai essere autorizzata a ottenere o sviluppare armi nucleari’.
Il Canada ‘sostiene gli Stati Uniti nell’agire per impedire all’Iran di ottenere un’arma nucleare e per impedire al suo regime di minacciare ulteriormente la pace e la sicurezza internazionale’, ha detto Carney.
– Finlandia Il presidente finlandese Alexander Stubb ha affermato che gli Stati Uniti stanno operando in gran parte al di fuori del diritto internazionale tradizionale dopo i loro attacchi contro l’Iran, ha riportato l’emittente pubblica finlandese Yleisradio Oy (Yle).
‘Di solito, la giustificazione per questo tipo di attacchi è stata cercata presso le Nazioni Unite o almeno presso gli alleati. Ora, non ci sono state molte domande al riguardo’, ha detto Stubb, secondo Yle.
Stubb, che ha trascorso ore a giocare a golf con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha affermato di non aspettarsi che la sua controparte americana si avvalga di intermediari per negoziare la fine del conflitto, ha riportato l’emittente.
‘Sono abbastanza sicuro che il presidente Trump non coinvolgerà alcun intermediario in questa vicenda’, ha affermato. ‘Speriamo che la situazione si calmi, ma al momento sembra che si stia intensificando’, ha affermato Stubb, secondo Yle.
– Oman Il ministro degli Esteri dell’Oman, Badr Albusaidi, che stava svolgendo un ruolo di mediatore nei negoziati in corso tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare, si è detto ‘sgomento’.
‘Negoziati attivi e seri sono stati ancora una volta compromessi’, ha dichiarato Albusaidi. ‘Né gli interessi degli Stati Uniti né la causa della pace globale ne traggono beneficio. E prego per gli innocenti che soffriranno. Esorto gli Stati Uniti a non lasciarsi trascinare ulteriormente. Questa non è la vostra guerra’.
– Kuwait Il Kuwait, sede di una grande base aerea statunitense colpita dall’Iran, ha condannato ‘l’odioso attacco iraniano’ e ha affermato di avere il diritto di difendersi ‘in risposta a questa palese aggressione, in modo proporzionato alla portata e alla natura di questa violazione e in conformità con il diritto internazionale’.
– Qatar Il Qatar, che ospita la più grande base militare statunitense in Medio Oriente anch’essa presa di mira dall’Iran, ha dichiarato che gli attacchi costituiscono ‘una palese violazione della sua sovranità nazionale, un attacco diretto alla sua sicurezza e alla sicurezza del suo territorio e un’escalation inaccettabile che minaccia la sicurezza e la stabilità della regione’.
Il ministero degli Esteri del Qatar ha sottolineato che lo stato ‘è stato e rimane tra i primi a chiedere il dialogo con la Repubblica Islamica dell’Iran’ e ha invocato ‘l’immediata cessazione di qualsiasi azione di escalation, il ritorno al tavolo del dialogo e la priorità al linguaggio della ragione e della saggezza, per contenere la crisi e preservare la sicurezza della regione’.