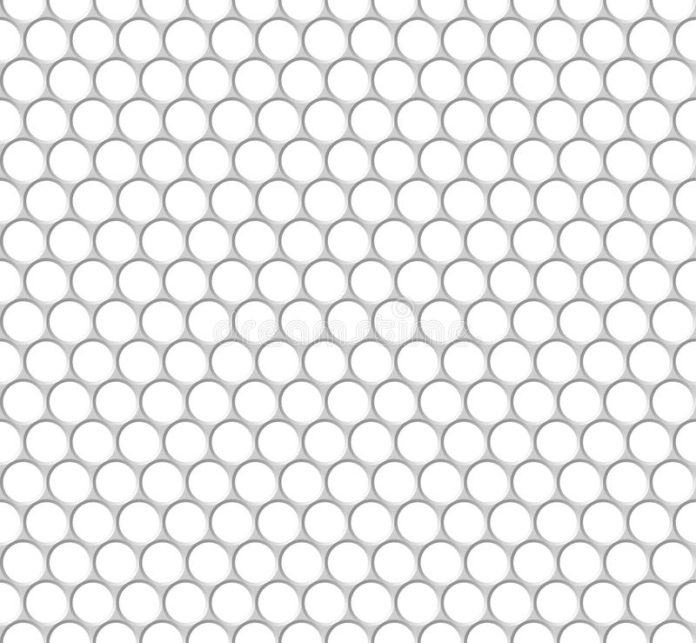Articolo già apparso su huffingtonpost.it
Quel che è certo, oggi, riguarda l’aspetto tormentato della vicenda democratica italiana. La sfida che abbiamo di fronte richiede un analisi attenta e approfondita.
Siamo di fronte a un cambiamento vero, più profondo di quanto immaginiamo, che non va letto con superficialità. Gli italiani hanno compiuto scelte che portano alla ribalta posizioni e attegggiamenti in contrasto aperto con la coscienza di una nazione civile. Con le ultime elezioni è tornato in auge l’appello ai valori, o meglio ai valori gridati, che nella storia del nostro paese ha sempre rappresentato, all’apparire del declino della politica, un ancoraggio solido.
Cosa è accaduto? Una parte consistente dell’elettorato, anche e soprattutto di sinistra, ha virato in direzione di una proposta populista e pauperista, dove la vecchia istanza umanitario-socialista sprofonda in una sorta di “plebeismo social”, molto facile da maneggiare e troppo difficile da rimuovere. Tutto ciò, nutrito di angoscia per la crisi e le difficoltà quotidiane, si è tradotto nella ricerca del capro espiatorio: identificare cioè il colpevole del degrado e delle sofferenze, quali che siano le responsabilità ad esso attribuibili. Come è noto, la figura del capro espiatorio attira su di sé la punizione, non importa se giusta o sbagliata, poiché deve rappresentare un simbolo di catarsi per la rabbia e lo sconcerto che nel vissuto della “gente” sembrano anzitutto determinati dai vistosi insuccessi della stagione politica più recente. E tale ordalia, che serve nel pensiero corrente a ripristinare l’ordine delle cose, dunque a punire i colpevoli, giustifica e più ancora esige l’avvento dell’uomo forte, quindi dell’uomo solo al comando.
In realtà l’uomo della provvidenza non cancella il malessere, piuttosto alza la tensione canalizzando l’astio sociale verso ciò che appare la necessaria sanzione. Ma una simile concatenazione di presupposti e conseguenze, genera e alimenta una liturgia politica ambigua e pericolosa, tutta concentrata sul desiderio di esaltazione del capo, al quale ci si affida, al di là dei meriti, nella speranza di venire a capo delle difficoltá. Da qui la dislocazione di un ampio segmento di elettorato radicale nel campo attualmente occupato dal M5S, senza che il connubio di populismo e nazionalismo (“Prima l’Italia e gli italiani”), riassunto nel patto di governo tra Salvini e Di Maio, venga a turbare nell’immediato l’autogiustificazione in ordine alla scelta compiuta nelle urne. Una scelta, diciamolo con chiarezza, nutrita di aspirazioni di sinistra, ma che finisce per spostare fortemente a destra l’asse politico del Paese.
Ma cosa rappresenta questa nuova destra nazionalista, alla Le Pen o alla Orbàn, nel contesto di un’Europa infragilita, quasi deformata? È una destra che vuole elevare una diga insormontabile nei confronti dello straniero e del diverso, di tutte le diversità. È forte con i deboli, i primi ad essere trasformati nell’immaginario della demagogia e della propaganda in capri espiatori per l’ordine infranto, e quindi per il declino di un’Italia penosamente ridotta a subire l’urto dell’immigrazione clandestina a causa dell’insensibilità o peggio del cinismo degli euroburocrati di Bruxelles.
La destra leghista, comunque, non dimentica i poteri forti, dato che conosce bene la loro forza di condizionamento. Sicché, dopo aver fatto la voce grossa, lancia messaggi che celano a stento la volontà di aprirsi a un’alleanza capace di stabilizzare una maggioranza per i prossimi decenni. È quanto traspare dagli annunci e dai gesti che la pubblica opinione ha imparato a decifrare: castigare chi non si piega, piazzare nei posti di comando i fedelissimi, anche se inadeguati, pressare gli indecisi. Naturalmente si propina al popolo una narrazione e una scenografia distanti anni luce dalla realtà. La vera realtà ci dice che questo blocco di potere sostanzialmente a guida leghista sta cercando di costruire il terzo pilastro del suo consenso. Gli manca, infatti, l’appoggio della Chiesa.
Certamente il magistero di Papa Francesco, attraversato dalle ombre di un dissenso che non si fa scrupolo di lanciare accuse e diffondere malignità, rivelando l’esistenza dello “zoccolo duro” del clericalismo preconciliare, non è un magistero che si adatti all’aspro discorso sui respingimenti dei profughi o la ramazzata degli zingari. C’è però una Chiesa che vive una stagione di ripiegamento, un po’ per nostalgia del tempo di Ruini, un po’ per mancanza di fiducia nel laicato. In passato, perciò, Berlusconi si fece paladino dei cosiddetti valori non negoziabili nel campo della bioetica, pure con saltuarie irruzioni in quello della morale e dei costumi.
Illudersi oggi che la fermezza di Papa Francesco e del Presidente della CEI, Card. Bassetti, come di tanti altri Vescovi e prelati, sia sufficiente a bloccare le pulsioni negative della “base” cattolica, è un errore d’ingenuità o superficialità. La mancanza di un partito di tipo degasperiano non aiuta la Chiesa, né tanto meno l’Italia. Chi svolge quell’attività di mediazione o quel lavoro di filtro rispetto all’incomposta dialettica tra fede e politica, tanto all’interno quanto all’esterno della vita ecclesiale, che ha permesso ai cattolici di esercitare in cinquant’anni di vita repubblicana un decisivo ruolo di guida politica? Ecco, intanto che maturi l’interrogativo sul presente e sul futuro del cattolicesimo italiano, insieme alla valutazione più serena del giudizio sulla irrepetibilità di determinate esperienze storiche, si perde e si degrada un pezzo della nostra democrazia.
Ignorare il panorama della “questione cattolica”, cancellando la memoria storica, ci porta fuori strada. A forza di convivere con le semplificazioni, ognuno osservando un canone di pigrizia per rimuovere la fatica del confronto e tutti coltivando il miraggio di una politica sana e buona, proprio in virtù del “punto zero” delle identità e delle appartenenze ideali, costituisce il peccato originale del Partito democratico. Molti ne sono consapevoli e cercano un rimedio, specie se trovato nel rito dei gazebo. Bisogna stare attenti, a questo punto, allo strabismo di una proposta che occhieggia alla resurrezione di una sinistra decorata. Per andare dove, ma per fare cosa? Se la línea consiste nel restauro della “tradizione rossa”, la coperta di questa politica unilaterale è troppo corta. Vale solo se accetta di comporsi come parte di un disegno più ampio, se perde il carattere onnivoro e polivalente di un nuovo “fronte popolare”, con forze sussidiarie a far da semplice corona, in modo variopinto, al “nocciolo duro” di questa sinistra debitamente rimotivata e riorganizzata.
C’è la necessità di rimettere in gioco tutto. Non ci sono più rendite di posizione, né carriere personali al coperto di liturgie o simboli del passato. Occorre riconoscere errori e fallimenti, prendere atto di un progetto che per nostri limiti non è riuscito a dispiegarsi e a radicarsi durevolmente, generando identità e senso di appartenenza. Occorre perciò ripartire dal basso, dai territori e dalle comunità, dalla pluralità e diversità delle storie e delle culture, per dar vita ad una larga rete di sostegno e di coesione ad una alleanza, politica e sociale, capace di promuovere un’alternativa seria allo schieramento giallo-verde.
Dunque un lavoro immane, che necessita di molti contributi, al di là dell’ossessione di stabilire chi è il capo – magari per sapere cosa faccio io – e della pretesa, in questo frangente, di uniformare costrittivamente le diverse modalità del fare opposizione. Ci viene in soccorso un esempio che viene da lontano. Cento anni fa, in un analogo contesto di crisi e sofferenza per l’Italia, Luigi Sturzo lanciò l’appello ai “liberi ed ai forti” con l’obiettivo unire le forze per la salvezza dell’Italia, proponendo di “attingere dall’anima popolare gli elementi di conservazione e di progresso”. Certo, l’appello del 1919 è consegnato alla storia, ma lo spirito che lo animò rappresenta tuttora un monito per noi, un punto luminoso per il nostro presente.
Accettiamo dunque la sfida, guardiamo oltre con lungimiranza, rinunciamo a qualche scampolo di tardivo senso dell’egemonia. Le elezioni europee vanno affrontate con intelligenza e passione. Sta di fatto che il Pd non basta, serve qualcosa di più. Anzi, serve molto di più. È una valutazione che accomuna molti di noi. Per questo ad ottobre, partendo dallo spirito che segnò l’appello di Sturzo, ci metteremo in cammino, non da soli, per trovare i motivi e le circostanze di uno stare insieme, con il pieno rispetto dell’autonomia degli uni e degli altri, scommettendo sulla possibilità di interpretare oggi, in maniera originale, l’essere “liberi e forti” nel tempo che ci è dato vivere.