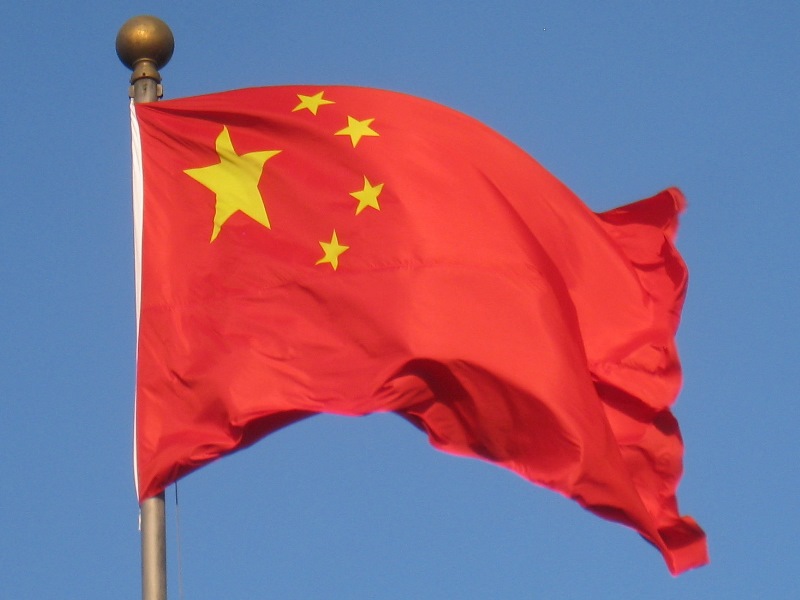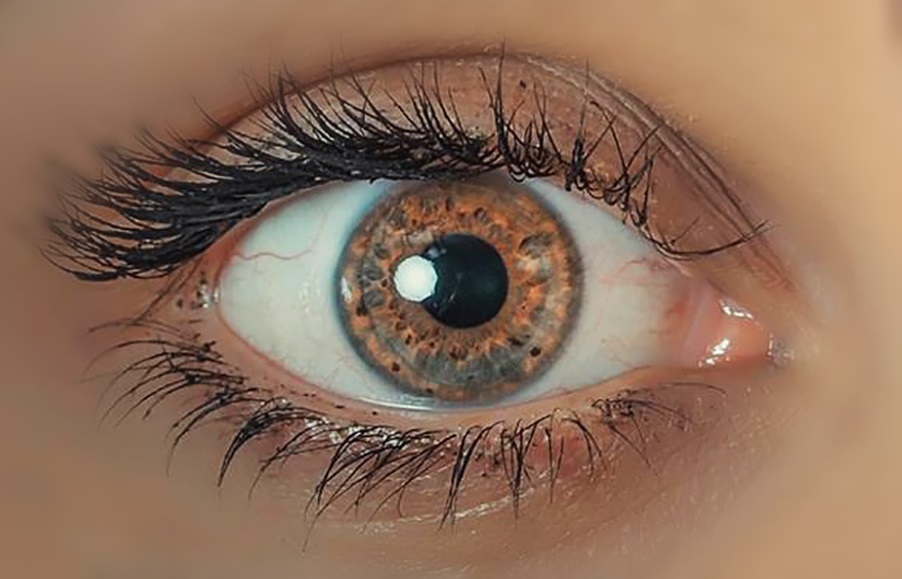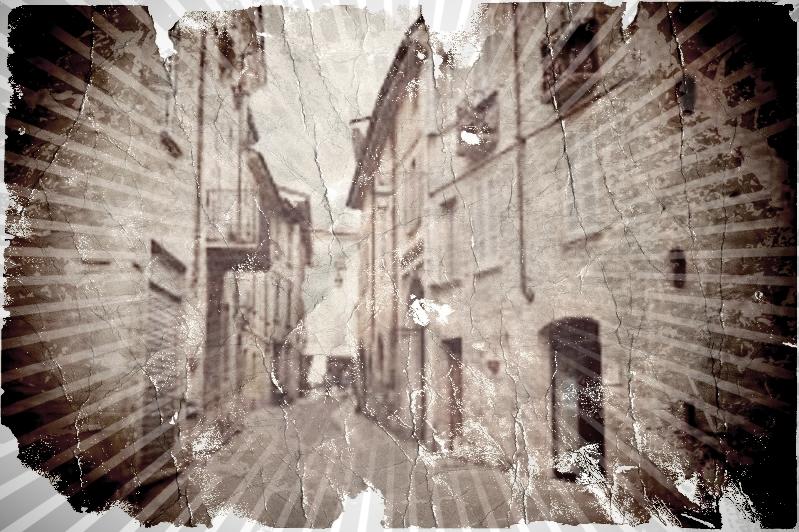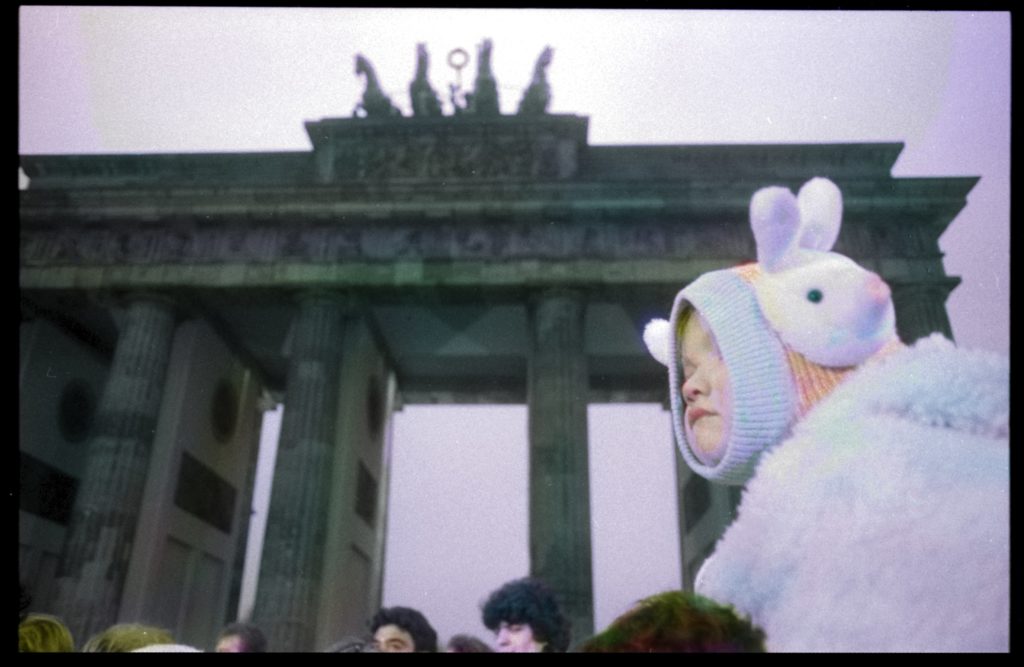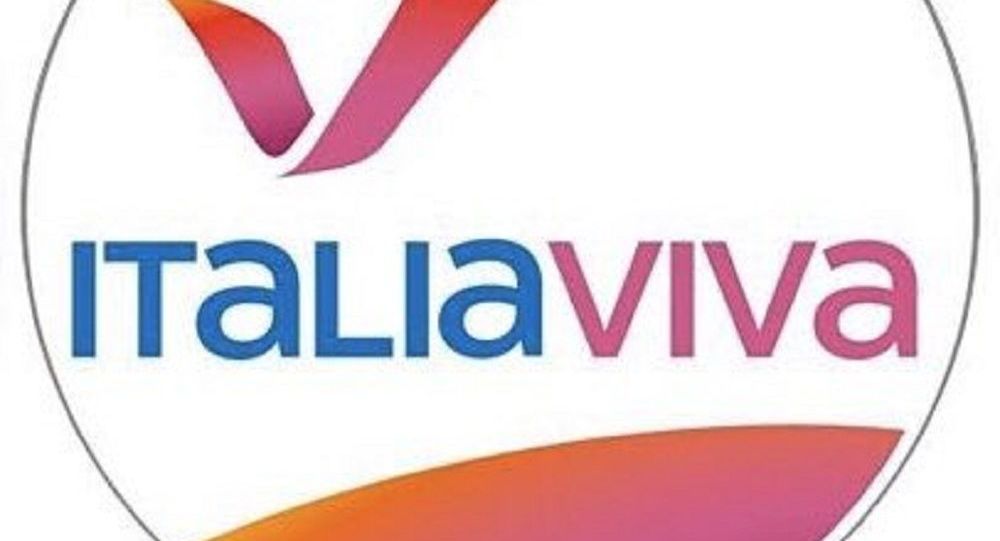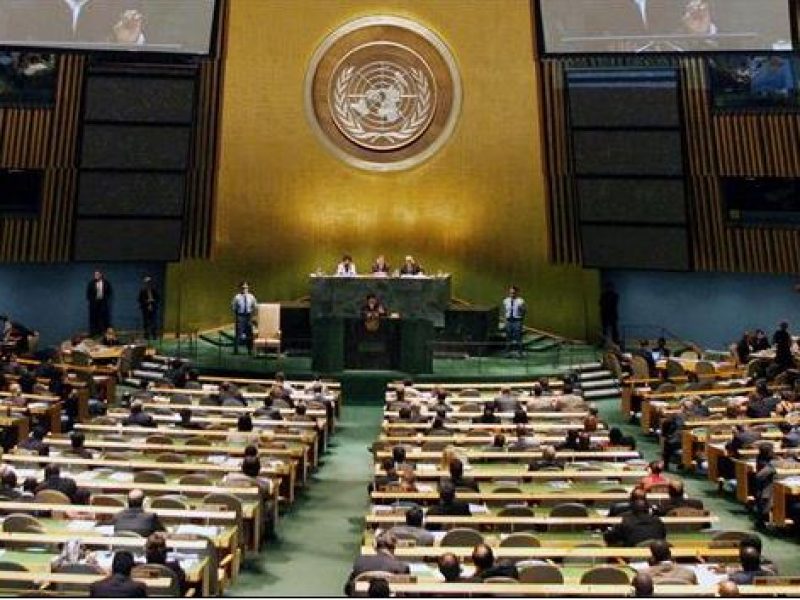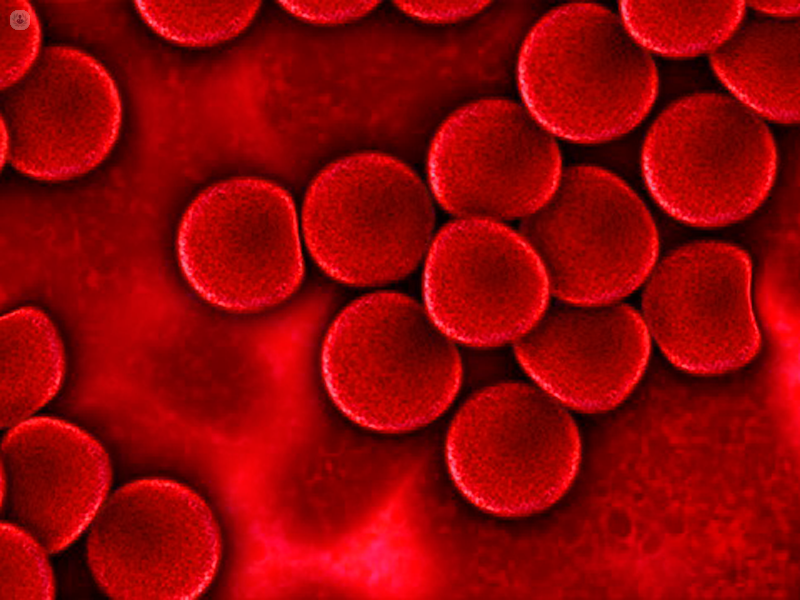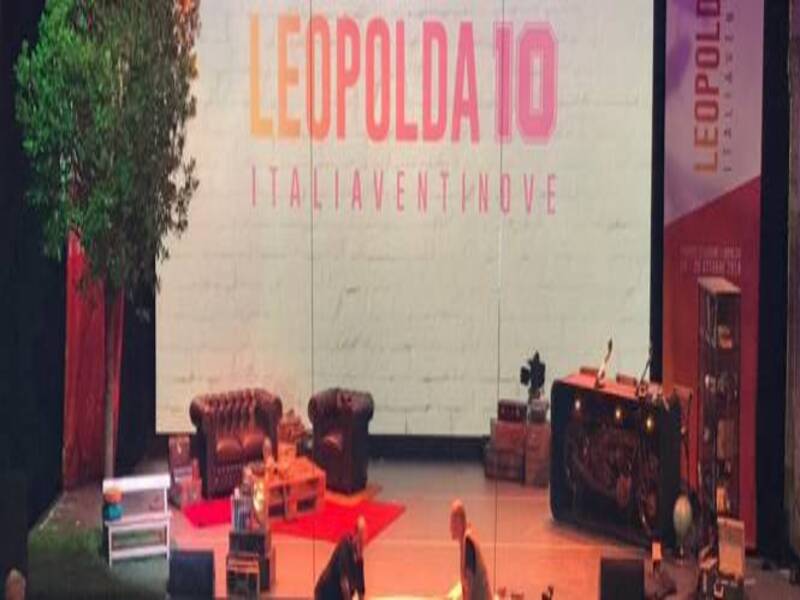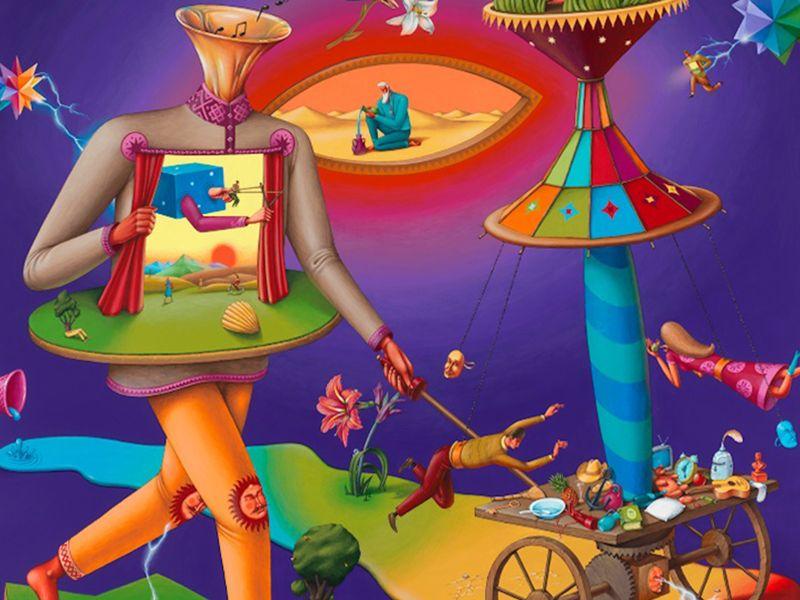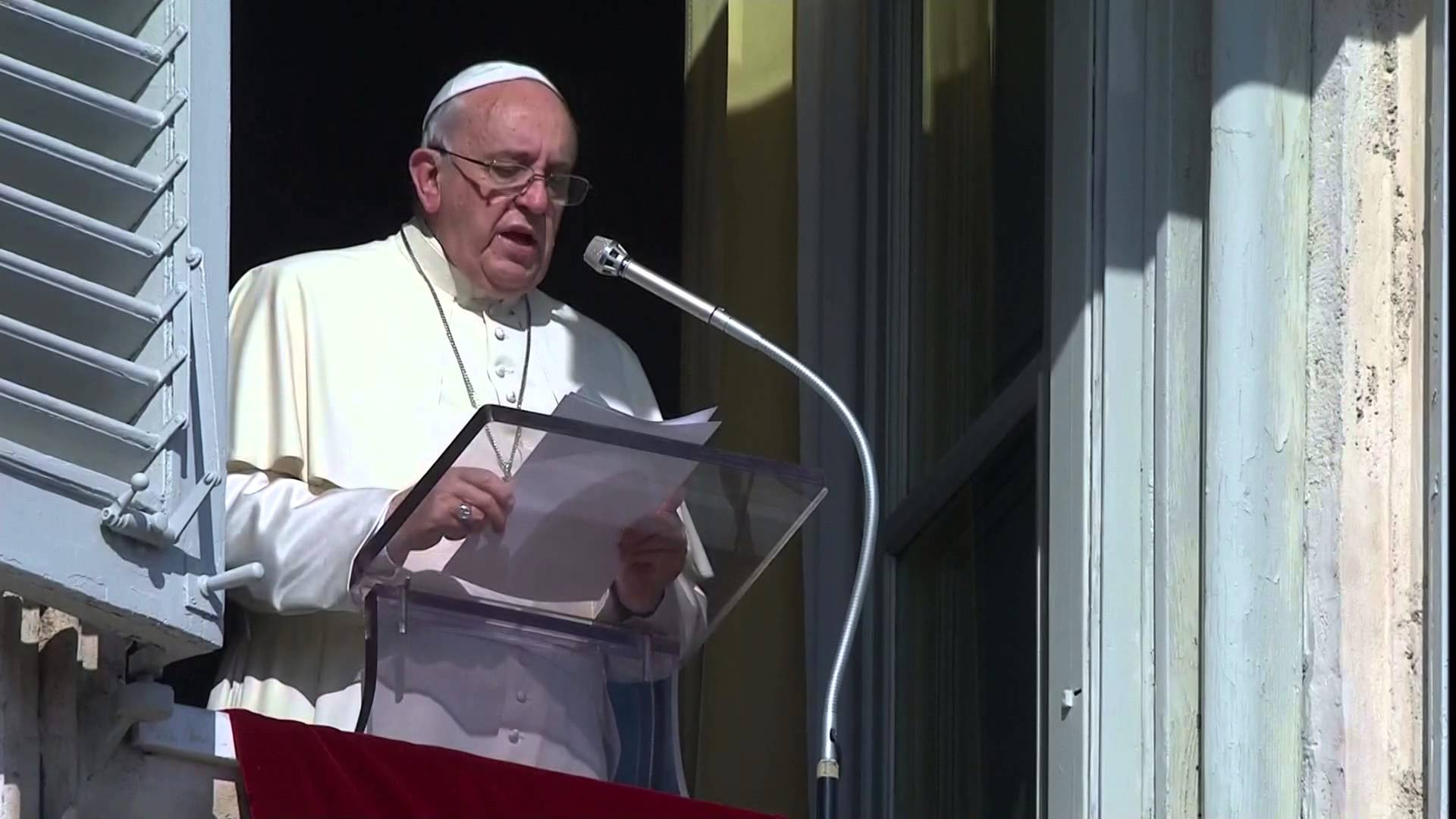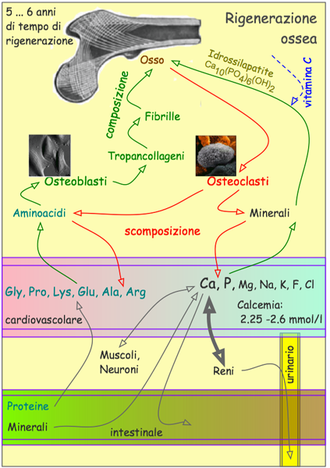E’ difficile ricordare in pochi minuti una amicizia lunga quaranta anni, fin da quando, Renzo entrò a Montecitorio nel lontano 1979.
C’è il rischio che le emozioni, i ricordi personali, i sentimenti prevalgano sulla ragione e su una lettura meditata dei passaggi della vita, soprattutto se lo facciamo in questa Sala per noi così carica di ricordi.
La vita parlamentare di Renzo Patria si intreccia con la mia, che seguivo per il Gruppo parlamentare l’area economica. Renzo Patria fu sempre componente della Commissione Finanze e Tesoro, fino a diventarne Presidente nella XIV legislatura.
Per quindici anni abbiamo condiviso scelte politiche, avvenimenti di vita parlamentare e quelli personali. Era una vita parlamentare intensa, fatta di tanti momenti di vita comune che terminavano ben oltre gli orari delle sedute.
Aveva competenze specifiche che gli venivano riconosciute e che venivano valorizzate nell’esame dei provvedimenti in particolare sulla finanza locale, sul fisco, sulla Amministrazione finanziaria, sui quali spesso veniva chiamato a svolgere il ruolo di relatore, così come sul bilancio dello Stato dove non mancava di intervenire. Era in fondo il riconoscimento della sua specializzazione, delle sue competenze, delle sue relazioni e della sua sensibilità in una Commissione dove era forte la professionalità dei suoi componenti. Era la commissione per citare dei nomi, degli Usellini, dei Citterio, dei Fiori, degli Azzaro, di De Cosmo, dei Rubbi, ma anche di Felice Borgoglio, Spaventa, D’Alema padre, Sarti Armando, Vincenzo Visco e tanti altri, dove il confronto delle posizioni era di alto livello e dove la sensibilità politica doveva essere coniugata con la competenza. Le sue iniziative legislative guardavano ai settori prima ricordati, ma non mancava di porre attenzione al territorio dove il suo legame era forte, sia con la previsione di sezioni distaccate delle Corti di Appello, e per l’Università Sud Orientale, così come per i compendi pubblici da destinare all’ente locale come l’ex ospedale militare e l’ex caserma San Martino, valorizzando il decentramento e la vicinanza su aspetti fondamentali come la giustizia e la Istruzione, come esigenza dei giovani e dei cittadini rispetto alla “lontana Torino”.
Nell’ambito fiscale sottolineò con anticipo, anche per la sua esperienza di amministratore locale la “spinta al riordino della imposizione del settore immobiliare e norme severe in materia di responsabilità per il dissesto”. Ribadiva come “la mancanza di autonomia impositiva e l’insoddisfacente impianto normativo porta a difficoltà di gestione”. Era una risposta alla esigenza e alle spinte che stavano maturando, anche con fratture politiche, per l’autonomia sostanziale degli enti locali. Tutto questo con largo anticipo rispetto alle concrete innovazioni nell’ordinamento. Il suo impegno parlamentare sui problemi ambientali è contrassegnato dalla lunga azione sull’Acna di Cengio e sulla Val Bormida che lo coinvolgerà con numerosi atti di sindacato ispettivo nella decima legislatura.
Soltanto alcuni anni dopo, nel 1994, si arriverà alla istituzione della commissione monocamerale di inchiesta.
Interpellanze, mozioni parlamentari erano seguite passo dopo passo, non azioni estemporanee, ma con la piena consapevolezza dell’obiettivo da raggiungere anche attraverso un confronto duro con il suo partito la DC, con la stessa maggioranza e con il Ministro dell’Ambiente Giorgio Ruffolo. Gerardo Bianco in quel tempo Vicepresidente della Camera dovrebbe ricordare una di queste sedute movimentate. Muovevano i primi passi le politiche di compatibilità ambientali per l’assenza di controllo nei decenni nelle produzioni inquinanti. Sottolineò la necessità di prevedere processi di risanamento per rendere compatibili le produzioni con l’ambiente e di istituire autorità ambientali, perché i rischi ambientali superano i confini amministrativi delle provincie e delle Regioni e degli Stati. E’ stato così per Chernobil come per le fabbriche della Germania Est che inquinavano le foreste della Baviera. Era così per la Val Bormida. In una occasione la sua penetrante attenzione ai testi in discussione gli fece scoprire che un punto del dispositivo della mozione Matulli, quindi del responsabile Ambiente del suo partito, era scomparso nel testo in votazione. Non era cosa di poco conto perché prevedeva di “assicurare che nessuna attività produttiva sia avviata prima che venga attivato integralmente il monitoraggio” ( di cui al punto 2). Un vero e proprio giallo. La sua Mozione non fu approvata. Rimase fermo sulla sua posizione, ma fu un alto momento tra i partiti e all’interno della stessa DC dove il confronto democratico era un valore assoluto.
Lo studio di quei problemi ambientali lo portò a presentare trenta anni or sono una iniziativa di riforma della Costituzione per la tutela dell’ambiente, del paesaggio, e il patrimonio storico della nazione per promuovere la collaborazione internazionale per la salvaguardia dell’ecosistema. Sono questioni recentemente richiamate dal Presidente del Consiglio Conte nelle recenti dichiarazioni programmatiche di agosto. Metteva la persona umana al centro degli interessi per la salubrità degli ambienti di vita e di lavoro.
La sua iniziativa costituzionale per la detrazione fiscale delle spese per l’istruzione eliminando la sperequazione tra istituti pubblici e privati si muoveva all’interno della cornice costituzionale degli articoli 33 e 34 della Costituzione.
Ma è sul bilancio interno che emergeva la sua sensibilità istituzionale. In un suo intervento del 1983 non v’era solo il riconoscimento formale della Presidenza Iotti, per le grandi trasformazioni della Camera dei Deputati in atto come la creazione dell’Ufficio di Bilancio, una innovazione specifica, come strumento di valutazione della spesa e la creazione della struttura per la redazione dei testi legislativi o come il trasferimento della biblioteca e la sua trasformazione in Biblioteca di ricerca. Non mancava di sottolineare la “urgenza di recuperare la centralità del Parlamento”. Quel Parlamento che oggi si vuole limitare nelle sue funzioni di rappresentanza e con idee strampalate sulla democrazia diretta.
Poi nell’ultima sua legislatura quella dal 2001 al 2006 voglio ricordare la sua azione in difesa del ruolo e della funzione delle Banche popolari e di credito cooperativo, come fu attivo protagonista, quando il Paese fu attraversato da scandali finanziari, nella indagine conoscitiva sui rapporti tra le imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio che portò alla definizione di una buona legge, la 262 del 2005, che ancora oggi riscontra notevoli apprezzamenti, per le profonde innovazioni nelle infrastrutture normative introdotte a tutela dei risparmiatori.
Auspicò come “adempimento al dovere del legislatore di accendere un faro che indichi la strada per la ricostruzione di una etica finanziaria” come sollecitato da Ciampi, ma al tempo stesso “la politica doveva recuperare un ruolo primario se non vogliamo – disse – che la finanza e i poteri forti siano essi a dettare l’agenda anche alle Istituzioni elettive”. Come sono attuali queste parole!
Aveva la grande preoccupazione di evitare il rischio di far ricadere sulle Istituzioni la crisi che colpiva i partiti politici nei primi anni novanta “pena l’irreparabile decadenza della nostra democrazia”. La tutela delle condizioni di vita e di lavoro dei deputati non poteva, secondo Renzo Patria, essere intesa “quale tutela di privilegi individuali e corporativi, ma va ricondotta nell’ambito suo proprio e cioè di garanzia della funzione di rappresentanza popolare che i membri del Parlamento esercitano”. “Delegittimare il Parlamento significa sconfiggere la sovranità popolare facendo prevalere con la piazza minoranze velleitarie e violente ma non per questo meno pericolose per le sorti della democrazia del nostro Paese.
Sapeva ascoltare i fermenti della società civile. “Sarebbe semplicistico e colpevole – disse in Aula – se ignorassimo le domande, e non ci accorgessimo della profondità della crisi che è di identità e di credibilità dei nostri comportamenti”.
Riteneva preminente l’obiettivo di restituire le Assemblee legislative alle loro finalità più vera, la sede nella quale si operano scelte nell’interesse dei cittadini.
Nei suoi interventi sul bilancio interno della Camera, per la sua sensibilità, poneva particolare attenzione alla “condizione del parlamentare” per renderlo sempre più libero dai condizionamenti dei partiti e dei Gruppi. Difese l’autonomia amministrativa della Camera, esprimendo preoccupazione per le insidie che si manifestavano verso il personale della Camera.
Rifiutava il concetto di Camera come “azienda”.
Per Renzo “l’amministrazione della Camera non è altro che uno degli strumenti attraverso i quali l’ordinamento ha inteso garantire all’Istituzione-Camera le condizioni necessarie di autonomia per il pieno esercizio delle proprie funzioni costituzionali. Efficienza ed economicità di gestione non possono costituire per la Camera dei valori assoluti, ma vanno perseguiti entro i limiti dell’interesse generale al complessivo funzionamento delle Istituzioni rappresentative”. L’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori sono chiamati a svolgere nella loro qualità di organi collegiali di direzione politica funzioni che nulla hanno in comune con i consigli di amministrazione operanti nelle realtà aziendali.
Nel suo agire quotidiano portava avanti l’idea e i valori degasperiani della Democrazia Cristiana. Forte era la sua Fede democratica. Sentiva profondamente il contatto con il mondo cattolico da cui era stato formato. Ripeteva “dobbiamo ripartire dagli oratori e dalla società civile”. Nella diaspora non cancellò le amicizie, ma mantenne rapporti cordiali senza rancori.
L’associazionismo nelle sue varie forme e articolazioni era il momento per portare avanti insieme le idee. Fino all’ultimo istante è stato protagonista nella Associazione Democratici Cristiani dove mi volle fortemente.
Dopo le esperienze parlamentari non abbandonò la politica ma si dedicò con impegno nella vita degli ex parlamentari per tredici anni di cui otto anni con responsabilità comuni con Gerardo Bianco e poi con Antonello Falomi. Abbiamo avuto altri intensi momenti di vita vissuta. Nella Associazione ha potuto traslare tutta la sua esperienza nella gestione quotidiana dei problemi grandi e piccoli, anche rispetto all’ondata di populismo e antipolitica, soprattutto nella valorizzazione di un corpo intermedio con le sue regole ancorate ai valori costituzionali, che non erano un retaggio del passato, ma la stella polare dell’agire quotidiano.
Ha partecipato con entusiasmo alla promozione di iniziative su tutto il territorio nazionale, da Napoli sui temi del Mezzogiorno e Milano per l’Expo, fino a Torino per l’anniversario dei 150 anni della unità di Italia. Portava la sua esperienza istituzionale, quindi con una conoscenza profonda dell’Istituto parlamentare proprio mentre più forti si diffondevano i germi dell’antipolitica e avanzava l’odio sociale contro il Parlamento con una campagna antisistema volta a ridurne ruolo e funzione, Queste erano preoccupazioni in lui ben presenti e non mancava di sottolinearle quotidianamente.
Renzo Patria apparteneva alla categoria dei parlamentari seri, fortemente impegnati nel duro lavoro parlamentare sia d’ Aula che di Commissione, profondamente legato al suo territorio, alla Sua Frugarolo, alla Sua Alessandria, al Suo Piemonte; era una presenza quotidiana e costante perché legata ai principi del “proporzionale” che non ammetteva fughe dagli elettori, ma contatti quotidiani, permanenti.
In venti anni di presenza in Parlamento, i numeri di Renzo Patria offrono un quadro rappresentativo di 900 progetti presentati, di 692 atti di indirizzo e di 162 interventi in Aula e nelle Commissioni. La difesa del Parlamento era a tutto tondo. Per Renzo Patria anche “il parlamentare che ha cessato la funzione in considerazione dell’attività resa debba avere sempre il rispetto del rango che gli compete nelle pubbliche manifestazioni, così come peraltro accade quando responsabile della organizzazione è il cerimoniale del Quirinale”.
Volle dotare la nostra Associazione del proprio vessillo come simbolo di unità e di rappresentanza perché nelle manifestazioni ufficiali fossimo presenti con il coraggio e l’orgoglio della nostra storia senza distinzioni partitiche.
Non si rassegnava alle spinte verso la cancellazione della memoria e fino all’ultimo ha difeso le proprie idee i valori per i quali ha lottato nella sua vita.