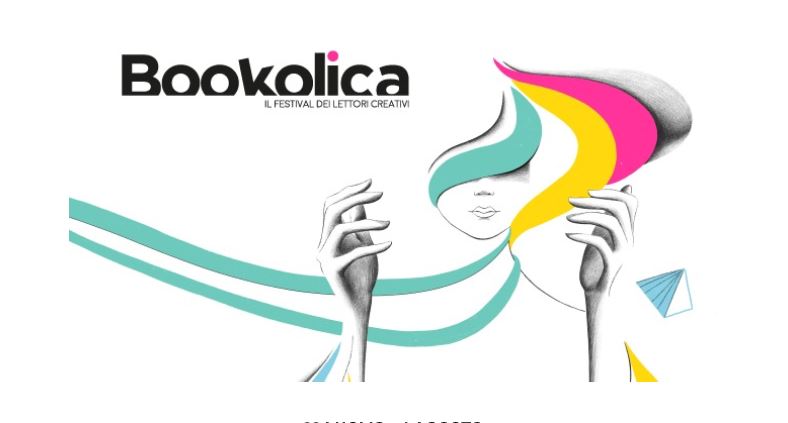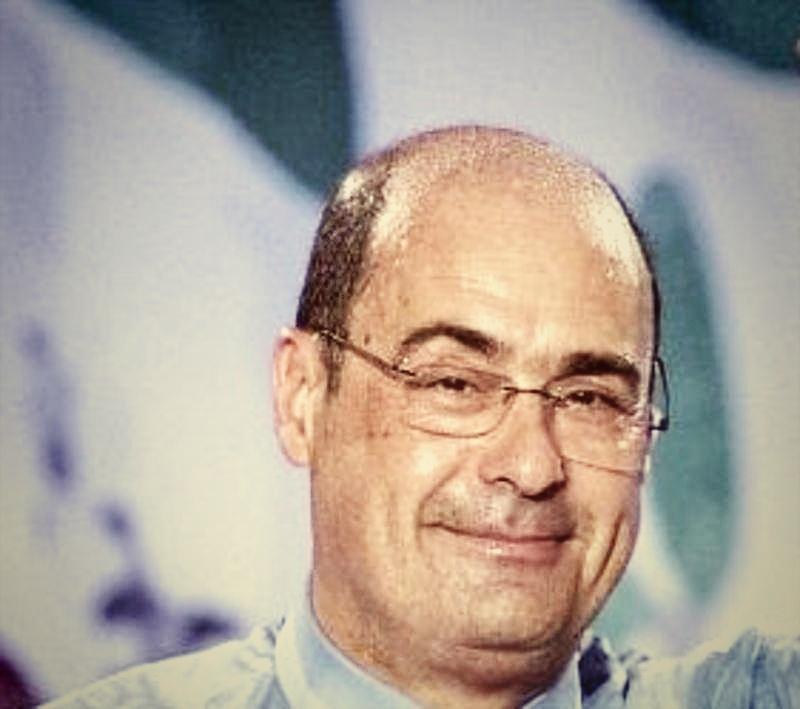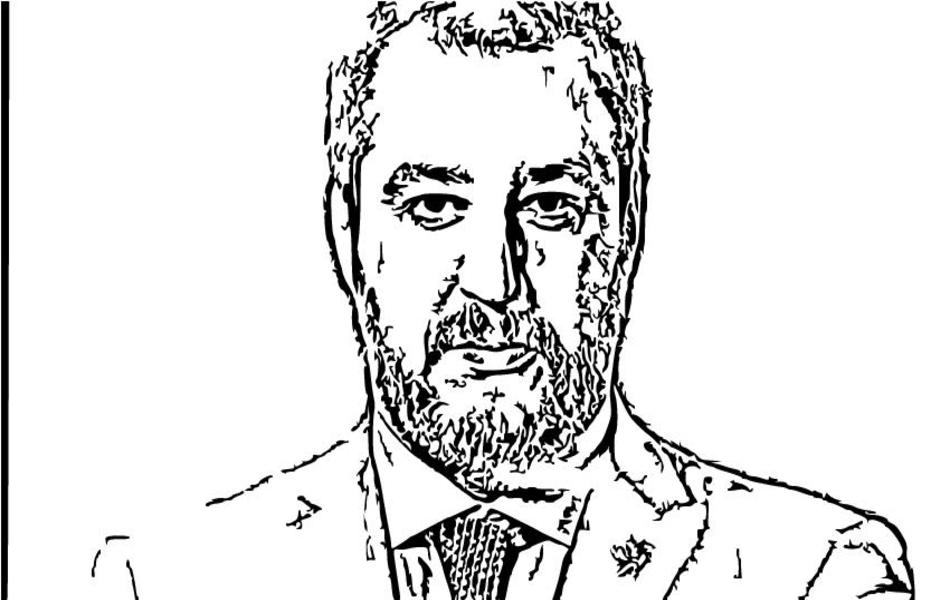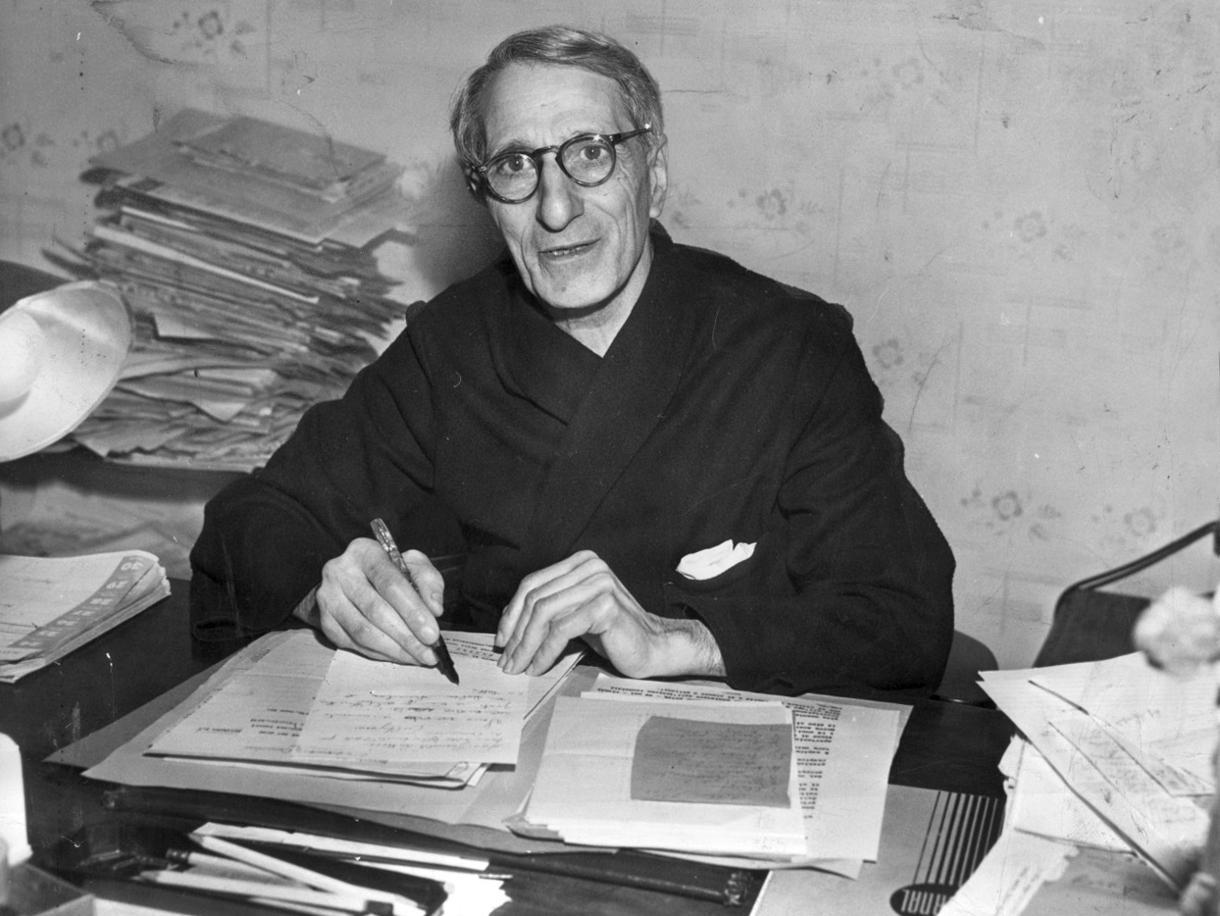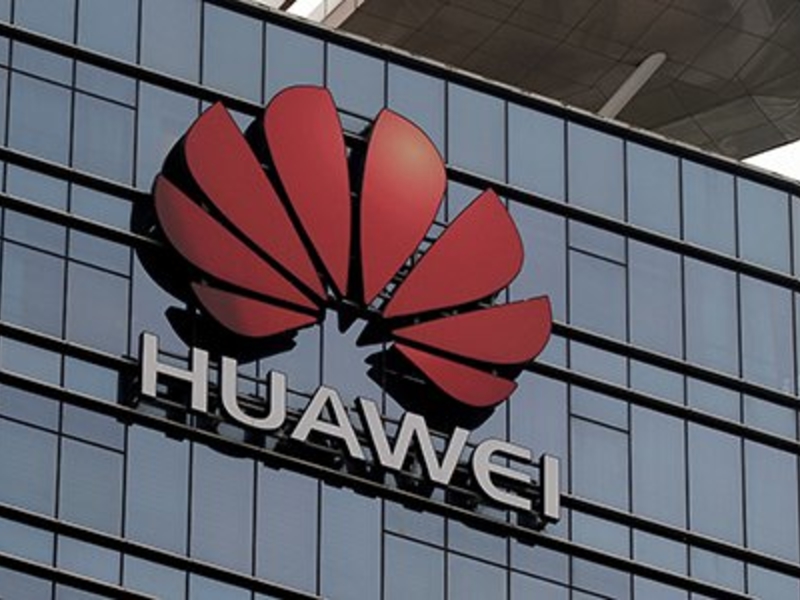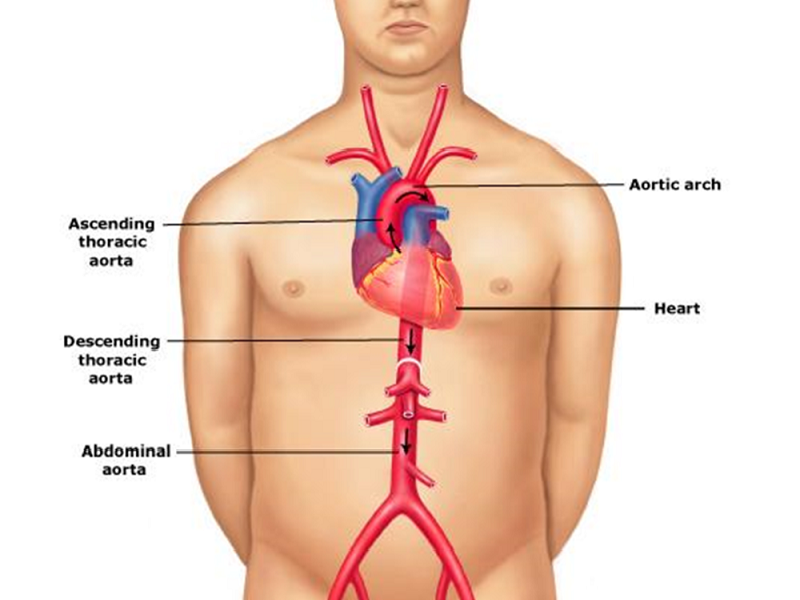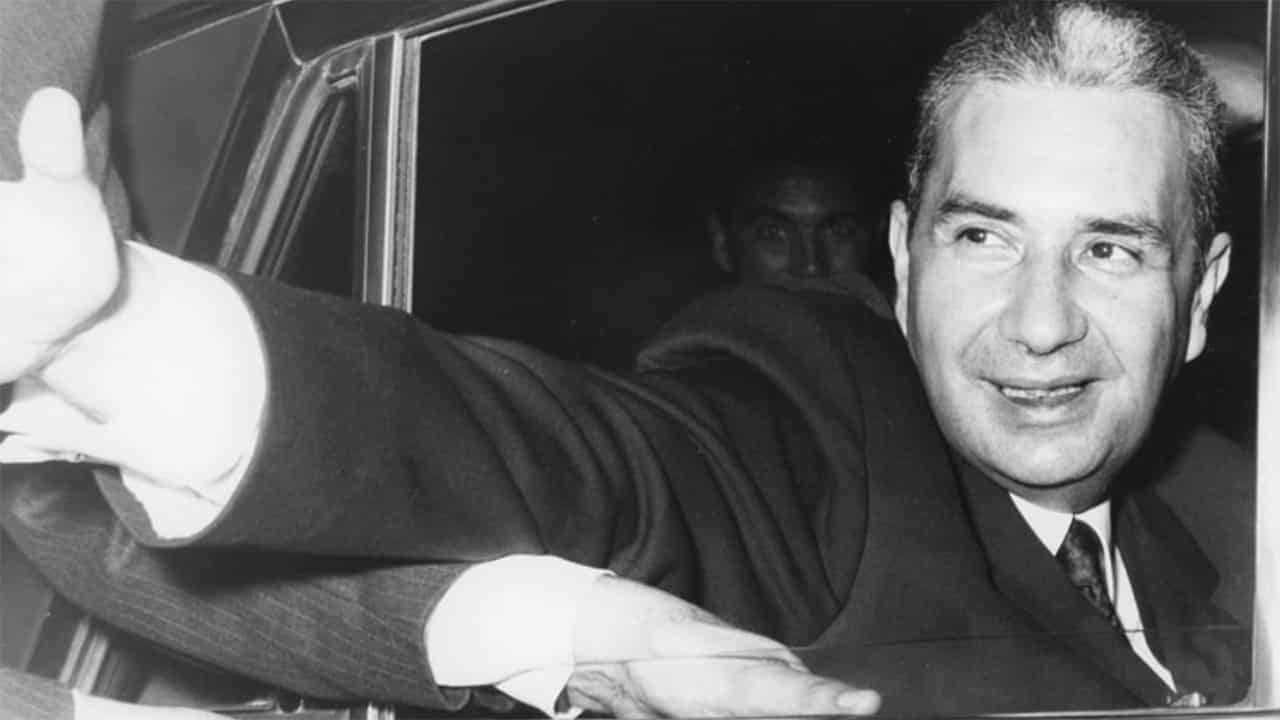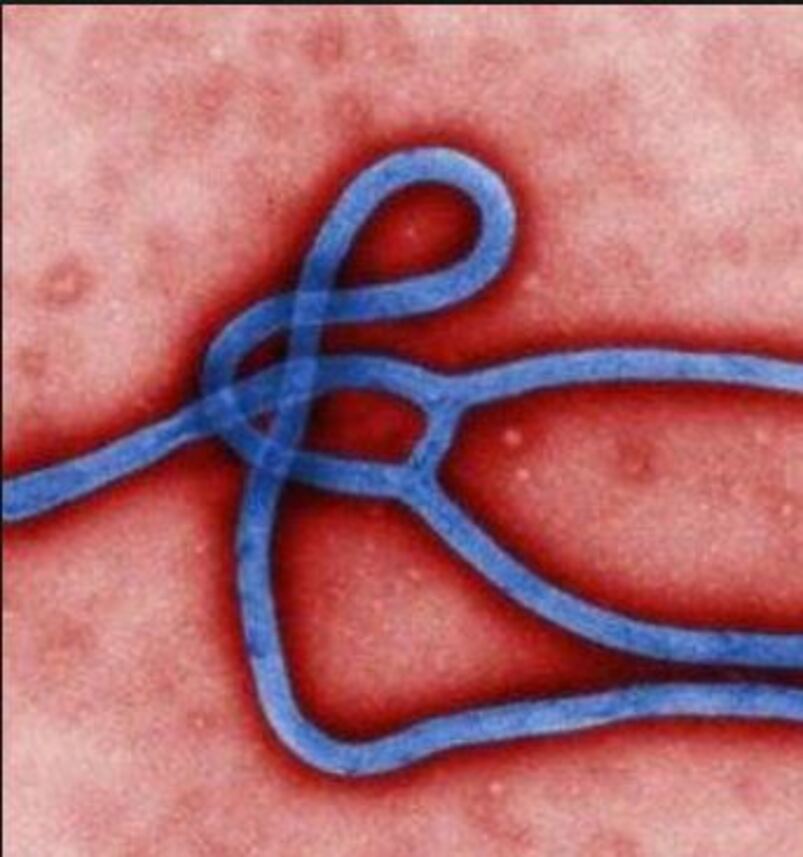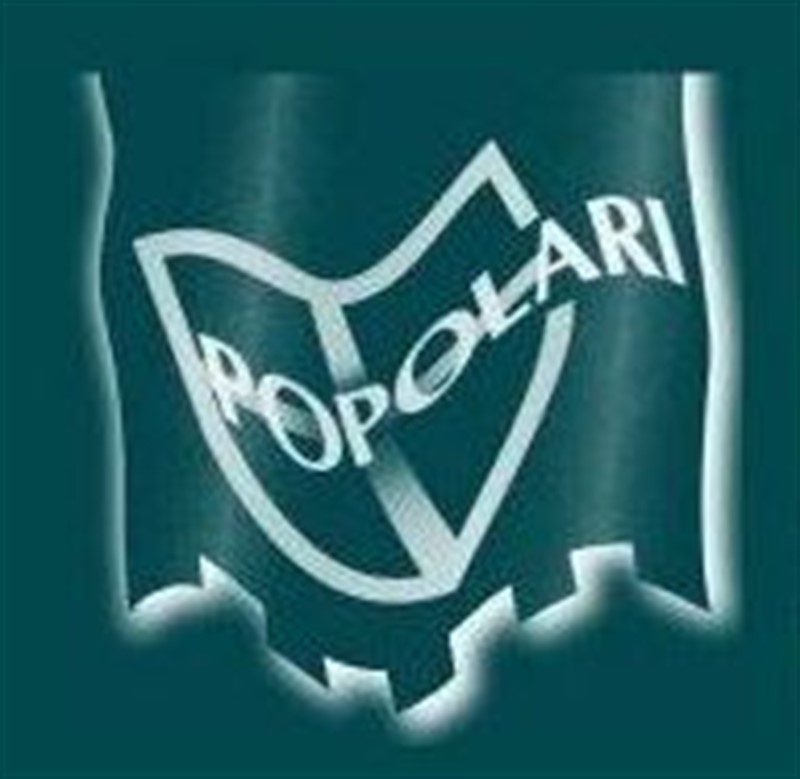Articolo già pubblicato sulle pagine dell’Osservatore Romano a firma di Andrea Monda
Portare «il messaggio dell’eccedenza» in una società dominata dal «messaggio dell’eccesso», ricordando che chi vuol trattenere la propria vita la perde, mentre «chi è disposto a perderla la riceve moltiplicata!». Per Chiara Giaccardi, professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università Cattolica di Milano e membro del comitato di direzione del mensile «donne, chiesa, mondo», è questo il contributo che ci si attende dalla Chiesa di fronte a una società sempre più impaurita e chiusa in se stessa.
Giuseppe De Rita su queste pagine ha affermato che per il buon governo c’è bisogno di due autorità: una civile e una spirituale-religiosa. Quella civile garantisce la sicurezza, quella spirituale offre un orizzonte di senso. L’uomo ha bisogno di tutte e due le cose. Se invece si esclude una delle due, la società soffre, diventa schizofrenica. Quale potrebbe essere il ruolo della Chiesa nell’attuale situazione italiana?
L’ossessione sicuritaria è diventata un tratto quasi nevrotico della nostra società, che esprime una diffidenza e un rifiuto totale per tutto ciò che sfugge al controllo. Come insegna la psicanalisi, per il nevrotico vale solo la ripetizione e ciò che è conosciuto: l’inedito, tutto ciò che può interferire con le abitudini, diventa intollerabile.
Sicurezza viene da sine-cura, senza preoccupazione. Ci sono due modi per alleggerire la preoccupazione: delegare ad altri il compito di controllare, e così evitare di coinvolgersi; oppure “prendersi cura”, e in questo modo correre un rischio che paradossalmente riduce il pericolo. In fondo l’ospite (hospes) è il nemico (hostis) di cui ci si prende cura (-pa), riducendo la distanza e le ragioni di rancore.
Una società incapace di prendersi cura (dei bambini, degli anziani, dei fragili) è una società che delega l’esercizio del controllo a scopo sicuritario, nello stesso tempo chiamandosi fuori dalle condizioni che determinano lo stato di criticità. Una società dove l’altro diventa una minaccia. Così si corre il rischio di far diventare permanente quello che Agamben chiamava “stato di eccezione”, dove la violenza (fisica, verbale, simbolica) è legittimata, così come la sospensione dei diritti più elementari, anche quelli conquistati nel tempo con fatica. Il rischio della disumanità è dietro ogni angolo della nostra vita quotidiana oggi.
Da una parte mi pare che quello dei migranti sia un capro espiatorio sul quale canalizzare il disagio delle classi sociali che più hanno risentito degli effetti collaterali di una globalizzazione che ha avvantaggiato pochi e prodotto tanta umanità di scarto, per evitare di affrontare questioni ben più cruciali. Siamo ben lontani da quella ecologia integrale di cui parla Papa Francesco nella Laudato si’, che è tuttavia sempre più necessaria.
Non ci si è presi cura del pianeta, non ci si prende cura delle persone, la tecnoeconomia è il principale motore dello sviluppo e questo sta rendendo il mondo disumano.
Dall’altra parte c’è una questione antropologica urgente da affrontare: la società che non si prende cura è anche una società che non genera: una società stagnante dove alla fine prevalgono le logiche mortifere, la rassegnazione, la difesa contro gli altri, la violenza.
La sfida è proprio questa: riscoprire il movimento antropologico co-originario al consumo (mettere dentro), che è generare (mettere fuori, mettere al mondo). Oggi siamo educati solo al primo, che sembra la soluzione per tutte le questioni, dalla realizzazione di sé alla crescita economica. Ma quando viene assolutizzato, lo vediamo, si rovescia nel suo contrario.
Mettere al mondo, dare inizio è un movimento “contributivo” altrettanto originario, che invece è poco raccontato e valorizzato (fuori da schemi ideologici). Per Hannah Arendt fare esistere qualcosa che non c’era, piuttosto che scegliere tra opzioni predeterminate, è il segno più alto della libertà umana. Un modo non individualistico di autorealizzazione che ha nell’unicità del fatto della nostra nascita la radice della propria possibilità.
La Chiesa oggi ha il compito di ricordarci (e testimoniare) che “tutto è connesso”, che accogliere l’embrione e il migrante sono due passi di uno stesso movimento: un sì a quella vita che sempre ci eccede, e portandoci fuori di noi ci libera e ci regala una pienezza che non sapremmo mai fabbricare. Romano Guardini scriveva che l’autonomia che consente la realizzazione di sé è sempre in rapporto con la totalità, mentre l’“autonomismo” che pretende di sciogliere i legami o di renderli irrilevanti alimenta solitudine, fragilità e allontana dalla vita.
Perché la vita ci porta sempre al di là di noi stessi e delle forme, pur indispensabili, che sappiamo costruire e che sono dunque sempre dinamiche e perfettibili. Una vita che mai può essere imbrigliata, posseduta, tantomeno trasformata in bandiera ideologica. Anche su questo la Chiesa ha il compito di vigilare.
Ma soprattutto la Chiesa oggi ha da portare il messaggio dell’eccedenza (quel “di più” che ci arriva solo quando accettiamo il rischio della perdita, della morte: chi vuol trattenere la propria vita la perde, chi è disposto a perderla la riceve moltiplicata!) a fronte di quello dell’eccesso (un aumento quantitativo di tutto, per riuscire a provare quell’intensità che sempre sfugge se si pretende di dominare la vita).
Entrambi i movimenti rispondono al bisogno di autotrascendenza tipico dell’essere umano (l’unico animale che non si accontenta di essere ciò che è, come scriveva Camus) ma solo il primo lo realizza, in modo sempre dinamico e mai dato una volta per tutte; il secondo lo anestetizza temporaneamente, per lasciarlo insoddisfatto alimentando i tratti più patologici della nostra società.
L’ossessione per la sicurezza tradisce un rifiuto della vita, mentre dichiara di proteggerla pretendendo di azzerare il rischio. Ma il “rischio zero” non esiste: è espressione ideologica, falsamente consolatoria e per di più incompatibile con la vita piena. Abbiamo ridotto il rischio alla sua faccia più negativa (il rischio di perdere qualcosa, in ultima istanza il rischio della morte) senza dimenticare che esso articola vita e morte in modo tale che la disponibilità ad accettare la perdita e la morte apre un orizzonte di “più vita”.
Solo chi è disposto a rischiare la propria vita può trovarla. La vita vera è avventura. Lo scriveva Romano Guardini alla fine degli anni ’20 con parole di straordinaria attualità: «Tanto più viva si sperimenta la vita, quanto più libera sgorga da se stessa; quanto più essa è audacia e avventura; quanto più decisamente essa si regge su ciò ch’è sempre nuovo e mai prevedibile, libero da schema e da regola. Si sente espandere in ampiezza la vita nella misura in cui continuamente si arrischia. Nemica al borghese, che pretende sicurezze e ferme tradizioni e vie già percorse».
Invece una società che rimuove la morte e pratica in ogni ambito la misura stretta del calcolo costi-benefici non può che considerare il rischio solo come una minaccia di perdita, che vede l’altro come un pericolo, come chi ci può solo togliere qualcosa.
L’autorità civile che assolutizza il proprio compito sicuritario dimenticando lo spirito che è vita si trasforma in stato di polizia che rende la vita insicura per tutti, soprattutto per i più vulnerabili. La società che sogna il “rischio zero” è una società morta.
La società italiana oggi sembra dominata dal rancore. Da dove nasce questo rancore? In questa situazione emerge un dato che ha una sua ambiguità, anche inquietante, cioè il dato dell’identità come risposta alla globalizzazione ma una risposta che si colora di chiusura e violenza.
Il rancore non è che la reazione di chi ha compreso che le promesse della globalizzazione hanno avvantaggiato pochi a scapito di tanti. La forbice sociale si è allargata, moltissime persone hanno visto peggiorare le proprie condizioni. Cosa ancor più insopportabile a fronte delle retoriche cosmopolitiche tuttora forti e di una imminenza dell’uscita dalla crisi annunciata ma ben lontana dal realizzarsi. La reazione sovranista non è che un esito della disillusione di chi ha sperato di avanzare e si è trovato a retrocedere: se questo è l’effetto della globalizzazione meglio chiamarsi fuori: ciascuno per sé — tanto, peggio di così…
Gli psicologi sociali parlano di senso di “deprivazione relativa” nella relazione tra gruppi diversi quando lo stato di soddisfazione di una persona o di un gruppo dipende meno dalle condizioni oggettive che dal confronto con altre persone o gruppi che vengono percepiti come maggiormente avvantaggiati nella situazione di comune difficoltà. Una sorta di “guerra tra poveri” insomma, che generalmente si accompagna alla logica del capro espiatorio: il gruppo ugualmente (o maggiormente) svantaggiato dalla situazione viene percepito come la causa dei mancati benefici. In questo caso non sarebbe la forma tecnoeconomica che la globalizzazione ha preso, bensì la presenza dei migranti a impedire a tanti di godere dei benefici che erano stati promessi. Ci sono forze politiche populiste che hanno tutto l’interesse a cavalcare questa insoddisfazione e alimentare questa “dislocazione” del malcontento per evitare di affrontare questioni reali e urgenti — in primis quella che Gael Giraud chiama la “transizione ecologica” — che richiederebbero nuovi equilibri e trasformazioni profonde che nessuno ha la forza e la visione per realizzare.
Una transizione che ha bisogno di tempo, mentre ora tutto è schiacciato sullo spazio dei confini, degli schieramenti, della contrapposizione tra blocchi irrigiditi.
Nessun dialogo è possibile con queste premesse. Solo una dialettica bellica e sterile, incapace di costruire e volta semplicemente a distruggere l’avversario. La violenza verbale è legittimata dalle massime autorità dello stato, e sui social innesca molto più movimento e interazioni della comunicazione positiva. Anche su questo la Chiesa può avere un compito, che non è censorio né moralistico bensì costruttivo: “avete sentito… ma io vi dico”, la logica paradossale del Vangelo che esce dalle dicotomie dei luoghi comuni e riconfigura il livello della comunicazione, l’accoglienza del nemico che lo spiazza anziché la guerra per annientarlo sono tutti elementi tratti dal patrimonio della sapienza cristiana che oggi possono essere preziosissimi, indispensabili direi. E non solo per i credenti, ma per tutti.
Il Papa propone ormai da anni il tema anzi il metodo della sinodalità, cioè il camminare insieme, il conoscersi, il fare qualcosa insieme, alto e basso che si intrecciano armoniosamente. Si avverte però un po’ di fatica a capire bene come realizzare questa sinodalità all’interno della Chiesa e della società, come mai?
Papa Francesco viene dall’altra parte del mondo, da un cattolicesimo diversamente “inculturato”. Questo aspetto viene sottovalutato. A me, per esempio, colpisce come l’Islam cambi a seconda della cultura sulla quale si innesta, con differenze profonde, per esempio, tra Est Europa, Nordafrica, Centro Africa, Pakistan… Così è anche per il cattolicesimo. In Europa ha attecchito sulla cultura greca che ha senz’altro grandi meriti ma della quale conserva un certo dualismo, razionalismo, formalismo, una aspirazione alla perfezione (e immutabilità) della forma, un disprezzo per il divenire e la corporeità. Con non pochi problemi a comprendere pienamente il messaggio rivoluzionario dell’incarnazione.
Papa Francesco proviene da una cultura diversa, dalla teologia del popolo, da una cultura dell’incarnazione appunto. Le critiche di “eresia” che gli vengono rivolte risentono moltissimo di questo pregiudizio culturale, di cui non si è per nulla consapevoli. A mia memoria è la prima volta che un pontefice subisce attacchi così pesanti dall’interno della sua stessa chiesa, e la forma eurocentrica che il cattolicesimo ha assunto, contraddicendo la sua vocazione universale (“tutto l’uomo e tutti gli uomini”, Caritas in veritate 55) ne è certamente almeno in parte responsabile. Peccato che in Europa il cattolicesimo sia in gravissima crisi, mentre è molto più vitale in America Latina e anche in Asia!
L’opzione decisa di Papa Francesco per il metodo della sinodalità è vista con sospetto da chi continua a guardare la Chiesa dallo specchietto retrovisore.
La scelta della sinodalità ha a che fare inevitabilmente con la questione della perdita: perdita di controllo, perdita di potere… Può essere letta (e lo è da qualcuno) in chiave solo negativa: per chi sogna il “rischio zero” anche nella Chiesa, quello della sinodalità è un tema fastidioso. Eppure vale anche per la Chiesa, oggi infragilita dalla secolarizzazione e dalla drammatica questione degli abusi (sessuali, finanziari, di potere), il monito evangelico che chi vuol salvare la propria vita la perde, e solo chi è disposto a perderla la trova moltiplicata. Difendersi è come sotterrare i talenti per paura di perderli.
Quella della sinodalità è al contrario una via per ritrovare la vita accettando il rischio della perdita. Un modo di “scommettere” (nel senso pascaliano) sulla vita, che eccede sempre tutti gli sforzi di “metterla in sicurezza”.
Ai tentativi difensivi che irrigidiscono la dimensione dottrinale e sognano di restaurare il potere della Chiesa, Papa Francesco risponde con il metodo del camminare insieme, dell’inclusione, del coinvolgimento, dell’attribuzione di responsabilità. E, parallelamente, dell’alleggerimento delle strutture e degli apparati che, nati per tutelare, rischiano invece di soffocare.
È un’autorità generativa quella che fa crescere, “autorizza” a farsi compartecipi del cammino di rinnovamento della chiesa, invita a prendere iniziative tenendo conto del passo dei più fragili. Un’autorità capace di “lasciar andare”: movimento senza il quale il generare si volge in dominio mortifero.
In fondo è in gioco il tema della libertà, un nodo da sempre spinoso per la Chiesa. Eppure Dio ha creato l’uomo libero, e solo alla nostra libertà fa appello il suo invito. Il movimento dell’affidarsi (perché la fede è affidamento — da fides, legame, da cui anche fiducia, fedeltà…), dello scegliere liberamente a cosa legare la nostra vita, entrando in una relazione che nutre ogni altro legame: è questo il senso della fede oggi, cui Papa Francesco ci richiama. La fede come “affidamento”, una relazione intima che ci costituisce dal di dentro, come quella coi genitori e i fratelli, e ci porta oltre noi stessi, anziché come “adesione” a un corpus di precetti e dottrine che rimane sempre esteriore, rispetto al quale si è sempre inadeguati, e che rischia di alimentare un dualismo tra purezza dei principi e pratiche che vanno da tutt’altra parte. In fondo Gesù ha detto «Io sono la via, la verità e la vita». Non c’è verità fuori da questo rapporto personale e da questo cammino. L’invito di Gesù è camminare insieme, sulla strada che Lui ha aperto con la sua vita. L’invito è proprio a una Chiesa sinodale.
Che poi è una Chiesa viva, che non avendo paura di perdere si ritrova. Come scrive ancora Guardini: «Quanto più forte è l’energia vitale, tanto più pienamente la vita si conserva».
Ed è una Chiesa di popolo. Camminare insieme è anche rispondere all’individualismo esasperato che produce tanta disumanità e solitudine. Il popolo non è una somma di individui, una massa. È un corpo sociale, dove l’identità è frutto della relazione, dove la molteplicità non impedisce l’unità ma la nutre, la rende viva. Dove le differenze non scavano fossati e dove le tensioni non diventano guerre. Dove si comunica riducendo le distanze, tessendo un “dialogo dialogico” (come lo chiamava Panikkar) anziché alimentare una dialettica bellica.
Il popolo cammina col ritmo salutare della prossimità e abita la casa comune, della quale si prende cura. Il popolo è il modo di abitare la terra nella consapevolezza che “tutto è connesso”: che ogni nostro gesto può inquinare o ossigenare il mondo; che la mia libertà si compie in quella degli altri; che l’ospitalità è il modo umano di vivere sulla terra, perché non si può amare Dio senza amare il prossimo. E il “come te stesso” per me non è un paragone tra esteriorità, una similitudine, bensì il segno di un legame intimo, profondo, costitutivo: ama il prossimo “in quanto” te stesso. Nessuno di noi è separabile dalla rete dei legami che ci costituisce; il “chi siamo” è sempre relazionale; non ci si libera né ci si salva da soli.
L’antropologia del popolo è profondamente evangelica e il sinodo è il modo, sempre in divenire e mai “perfetto” (finito) di abitare il mondo.
Una Chiesa viva è una Chiesa di popolo, in cammino, fedele a Gesù. Solo così si può rigenerare, e può rinnovare il mondo. Lo ha scritto, in modo splendido, Romano Guardini tanti anni fa: «Ogni cosa viva, essere od opera o azione, è in ultima analisi cosa nuova. In essa non è stato adattato qualcosa di preesistente, ma generato qualcosa di nuovo. Essa non realizza schemi dati, ma ci mette davanti ciò che non era mai esistito. Ogni cosa viva esiste una volta sola. Vivere significa creare. E tanto più viva è la vita, quanto più è creatrice. Tanto più originale, quanto più c’è di sorgivo in essa, di primitività zampillante dal fondo creativo. Vita è fecondità».