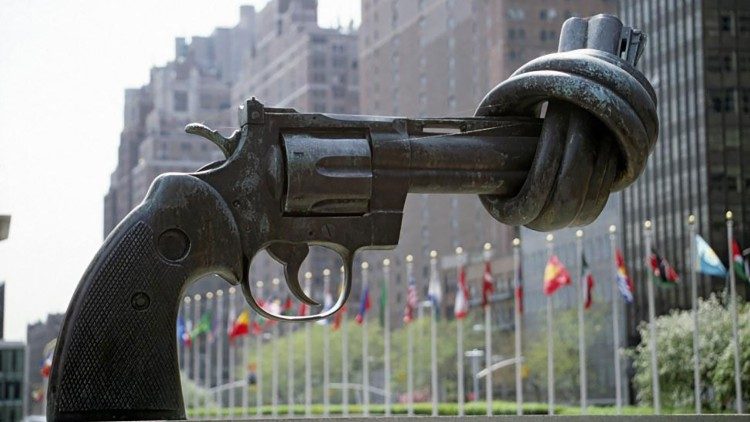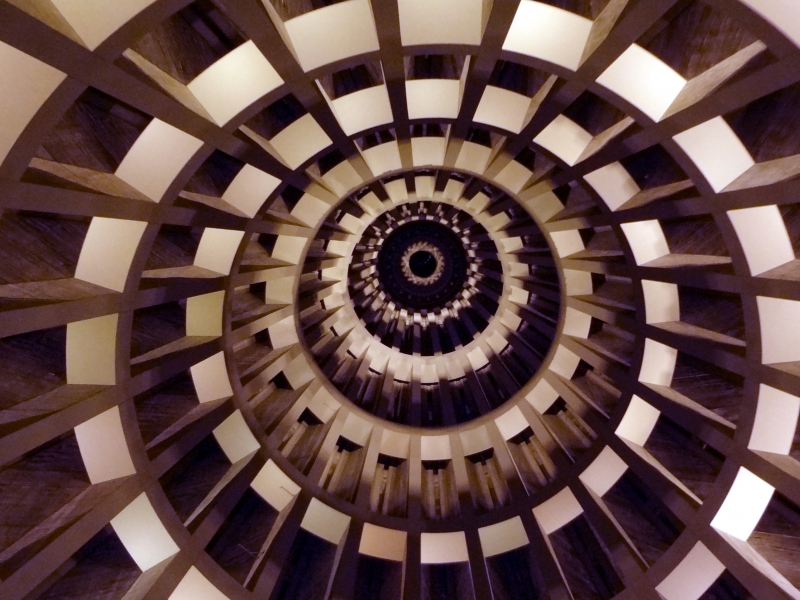1. Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo!
2. Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a te c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza.
3. A tutti i giovani cristiani scrivo con affetto questa Esortazione apostolica, vale a dire una lettera che richiama alcune convinzioni della nostra fede e, nello stesso tempo, incoraggia a crescere nella santità e nell’impegno per la propria vocazione. Tuttavia, dato che si tratta di una pietra miliare nell’ambito di un cammino sinodale, mi rivolgo contemporaneamente a tutto il Popolo di Dio, ai pastori e ai fedeli, perché la riflessione sui giovani e per i giovani interpella e stimola tutti noi. Pertanto, in alcuni paragrafi parlerò direttamente ai giovani e in altri proporrò approcci più generali per il discernimento ecclesiale.
4. Mi sono lasciato ispirare dalla ricchezza delle riflessioni e dei dialoghi del Sinodo dell’anno scorso. Non potrò raccogliere qui tutti i contributi, che potrete leggere nel Documento Finale, ma ho cercato di recepire, nella stesura di questa lettera, le proposte che mi sembravano più significative. In questo modo, la mia parola sarà arricchita da migliaia di voci di credenti di tutto il mondo che hanno fatto arrivare le loro opinioni al Sinodo. Anche i giovani non credenti, che hanno voluto partecipare con le loro riflessioni, hanno proposto questioni che hanno fatto nascere in me nuove domande.
CAPITOLO PRIMO
Che cosa dice la Parola di Dio sui giovani?
5. Andiamo a recuperare alcuni tesori delle Sacre Scritture, in cui diverse volte si parla dei giovani e di come il Signore va loro incontro.
Nell’Antico Testamento
6. In un’epoca in cui i giovani contavano poco, alcuni testi mostrano che Dio guarda con altri occhi. Ad esempio, vediamo che Giuseppe era quasi il più piccolo della famiglia (cfr Gen 37,2-3). Tuttavia, Dio gli comunicò grandi cose in sogno ed egli superò tutti i suoi fratelli in incarichi importanti quando aveva circa vent’anni (cfr Gen 37-47).
7. In Gedeone riconosciamo la sincerità dei giovani, che non hanno l’abitudine di addolcire la realtà. Quando gli fu detto che il Signore era con lui, rispose: «Se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo?» (Gdc 6,13). Dio però non fu infastidito da quel rimprovero e gli raddoppiò la posta in gioco: «Va’ con questa tua forza e salva Israele» (Gdc 6,14).
8. Samuele era un giovane insicuro, ma il Signore comunicava con lui. Grazie al consiglio di un adulto, aprì il suo cuore per ascoltare la chiamata di Dio: «Parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta» (1 Sam 3,9.10). Per questo è stato un grande profeta che è intervenuto in momenti importanti per la sua patria. Anche il re Saul era un giovane quando il Signore lo chiamò a compiere la sua missione (cfr 1 Sam 9,2).
9. Il re Davide è stato scelto quando era un ragazzo. Quando il profeta Samuele stava cercando il futuro re d’Israele, un uomo gli presentò come candidati i suoi figli più grandi e più esperti. Il profeta, però, disse che il prescelto era il giovane Davide, che pascolava le pecore (cfr 1 Sam 16,6-13), perché «l’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore» (v. 7). La gloria della gioventù sta nel cuore più che nella forza fisica o nell’impressione che si provoca negli altri.
10. Salomone, quando doveva succedere a suo padre, si sentì perduto e disse a Dio: «Io sono solo un ragazzo; non so come regolarmi» (1 Re 3,7). Tuttavia, l’audacia della giovinezza lo spinse a chiedere a Dio la saggezza e si dedicò alla sua missione. Qualcosa di simile accadde al profeta Geremia, chiamato a risvegliare il suo popolo quando era molto giovane. Nel suo timore disse: «Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so parlare, perché sono giovane» (Ger 1,6), ma il Signore gli chiese di non dire così (cfr Ger 1,7) e aggiunse: «Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti» (Ger 1,8). La dedizione del profeta Geremia alla sua missione mostra ciò che diventa possibile se si uniscono la freschezza della gioventù e la forza di Dio.
11. Una ragazzina ebrea, che era al servizio del militare straniero Naaman, intervenne con fede per aiutarlo a guarire dalla sua malattia (cfr 2 Re 5,2-6). La giovane Rut fu un esempio di generosità nel rimanere con la suocera caduta in disgrazia (cfr Rt 1,1-18) e mostrò anche la sua audacia per andare avanti nella vita (cfr Rt 4,1-17).
Nel Nuovo Testamento
12. Racconta una parabola di Gesù (cfr Lc 15,11-32) che il figlio “più giovane” volle andarsene dalla casa paterna verso un paese lontano (cfr vv. 12-13). Ma i suoi sogni di autonomia si trasformarono in libertinaggio e dissolutezza (cfr v. 13) e sperimentò la durezza della solitudine e della povertà (cfr vv. 14-16). Tuttavia, fu capace di ripensarci per ricominciare (cfr vv. 17-19) e decise di alzarsi (cfr v. 20). È tipico del cuore giovane essere disponibile al cambiamento, essere in grado di rialzarsi e lasciarsi istruire dalla vita. Come non accompagnare il figlio in questa nuova impresa? Il fratello maggiore, però, aveva già un cuore vecchio e si lasciò possedere dall’avidità, dall’egoismo e dall’invidia (cfr vv. 28-30). Gesù elogia il giovane peccatore che riprende la buona strada più di colui che crede di essere fedele ma non vive lo spirito dell’amore e della misericordia.
13. Gesù, l’eternamente giovane, vuole donarci un cuore sempre giovane. La Parola di Dio ci chiede: «Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova» (1 Cor 5,7). Al tempo stesso, ci invita a spogliarci dell’«uomo vecchio» per rivestirci dell’uomo «nuovo» (cfr Col 3,9.10).[1] E quando spiega cosa significa rivestirsi di quella giovinezza «che si rinnova» (v. 10), dice che vuol dire avere «sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro» (Col 3,12-13). Ciò significa che la vera giovinezza consiste nell’avere un cuore capace di amare. Viceversa, ad invecchiare l’anima è tutto ciò che ci separa dagli altri. Ecco perché conclude: «Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto» (Col 3,14).
14. Notiamo che a Gesù non piaceva il fatto che gli adulti guardassero con disprezzo i più giovani o li tenessero al loro servizio in modo dispotico. Al contrario, chiedeva: «Chi tra voi è più grande diventi come il più giovane» (Lc 22,26). Per Lui, l’età non stabiliva privilegi, e che qualcuno avesse meno anni non significava che valesse di meno o che avesse meno dignità.
15. La Parola di Dio dice che i giovani vanno trattati «come fratelli» (1 Tm 5,1) e raccomanda ai genitori: «Non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino» (Col 3,21). Un giovane non può essere scoraggiato, la sua caratteristica è sognare grandi cose, cercare orizzonti ampi, osare di più, aver voglia di conquistare il mondo, saper accettare proposte impegnative e voler dare il meglio di sé per costruire qualcosa di migliore. Per questo insisto coi giovani che non si lascino rubare la speranza e ad ognuno ripeto: «Nessuno disprezzi la tua giovane età» (1 Tm 4,12).
16. Tuttavia, nello stesso tempo ai giovani si raccomanda: «Siate sottomessi agli anziani» (1 Pt 5,5). La Bibbia invita sempre ad avere un profondo rispetto per gli anziani, perché possiedono un patrimonio di esperienza, hanno sperimentato i successi e i fallimenti, le gioie e i grandi dolori della vita, le speranze e le delusioni, e nel silenzio del loro cuore custodiscono tante storie che possono aiutarci a non sbagliare e a non essere ingannati da falsi miraggi. La parola di un anziano saggio invita a rispettare certi limiti e a sapersi dominare al momento giusto: «Esorta ancora i più giovani a essere prudenti» (Tt 2,6). Non va bene cadere nel culto della gioventù, oppure in un atteggiamento giovanile che disprezza gli altri per i loro anni o perché sono di un’altra epoca. Gesù diceva che la persona saggia sa estrarre cose nuove e cose antiche dal suo tesoro (cfr Mt 13,52). Un giovane saggio si apre al futuro, ma è sempre capace di valorizzare qualcosa dell’esperienza degli altri.
17. Nel Vangelo di Marco compare una persona che, quando Gesù gli ricorda i comandamenti, afferma: «Tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza» (10,20). Lo diceva già il Salmo: «Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. […] Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie» (71,5.17). Non bisogna pentirsi di spendere la propria gioventù essendo buoni, aprendo il cuore al Signore, vivendo in un modo diverso. Nulla di tutto ciò ci toglie la giovinezza, bensì la rafforza e la rinnova: «Si rinnova come aquila la tua giovinezza» (Sal 103,5). Per questo S. Agostino si lamentava: «Tardi ti ho amato, bellezza così antica e così nuova! Tardi ti ho amato!».[2] Tuttavia quell’uomo ricco, che era stato fedele a Dio nella sua giovinezza, lasciò che gli anni gli portassero via i sogni, e preferì rimanere attaccato ai propri beni (cfr Mc 10,22).
18. Invece, nel Vangelo di Matteo appare un giovane (cfr Mt 19,20.22) che si avvicina a Gesù per chiedere di più (cfr v. 20), con quello spirito aperto tipico dei giovani, alla ricerca di nuovi orizzonti e grandi sfide. In realtà, il suo spirito non era così giovane, perché si era già aggrappato alle ricchezze e alle comodità. Con la bocca affermava di volere qualcosa di più, ma quando Gesù gli chiese di essere generoso e di distribuire i suoi beni, si rese conto che non era capace di staccarsi da ciò che possedeva. Alla fine, «udita questa parola, il giovane se ne andò, triste» (v. 22). Aveva rinunciato alla sua giovinezza.
19. Il Vangelo ci parla anche di alcune giovani prudenti che erano pronte e attente, mentre altre vivevano distratte e addormentate (cfr Mt 25,1-13). Infatti, si può trascorrere la propria giovinezza distratti, volando sulla superficie della vita, addormentati, incapaci di coltivare relazioni profonde e di entrare nel cuore della vita. In questo modo si prepara un futuro povero, senza sostanza. Oppure si può spendere la propria giovinezza coltivando cose belle e grandi, e in questo modo preparare un futuro pieno di vita e di ricchezza interiore.
20. Se hai perso il vigore interiore, i sogni, l’entusiasmo, la speranza e la generosità, davanti a te si presenta Gesù come si presentò davanti al figlio morto della vedova, e con tutta la sua potenza di Risorto il Signore ti esorta: «Ragazzo, dico a te, alzati!» (Lc 7,14).
21. Indubbiamente ci sono molti altri testi della Parola di Dio che possono illuminarci su questa stagione della vita. Ne analizzeremo alcuni nei prossimi capitoli.
CAPITOLO SECONDO
Gesù Cristo sempre giovane
22. Gesù è «giovane tra i giovani per essere l’esempio dei giovani e consacrarli al Signore».[3] Per questo il Sinodo ha affermato che «la giovinezza è un periodo originale e stimolante della vita, che Gesù stesso ha vissuto, santificandola».[4] Cosa ci racconta il Vangelo sulla giovinezza di Gesù?
La giovinezza di Gesù
23. Il Signore «emise lo spirito» (Mt 27,50) su una croce quando aveva poco più di trent’anni (cfr Lc 3,23). È importante prendere coscienza che Gesù è stato un giovane. Ha dato la sua vita in una fase che oggi è definita come quella di un giovane-adulto. Nel pieno della sua giovinezza iniziò la sua missione pubblica e così «una luce è sorta» (Mt 4,16), specialmente quando diede la sua vita fino alla fine. Questo finale non è stato improvvisato, al contrario tutta la sua giovinezza è stata una preparazione preziosa, in ognuno dei suoi momenti, perché «tutto nella vita di Gesù è segno del suo mistero»[5] e «tutta la vita di Cristo è mistero di redenzione».[6]
24. Il Vangelo non parla della fanciullezza di Gesù, ma ci racconta alcuni avvenimenti della sua adolescenza e giovinezza. Matteo colloca questo periodo della giovinezza del Signore tra due eventi: il ritorno della sua famiglia a Nazaret, dopo il tempo di esilio, e il suo battesimo nel Giordano, dove ha iniziato la sua missione pubblica. Le ultime immagini di Gesù bambino sono quella di un piccolo rifugiato in Egitto (cfr Mt 2,14-15) e poi quella di un rimpatriato a Nazaret (cfr Mt 2,19-23). Le prime immagini di Gesù giovane-adulto sono quelle che ce lo presentano tra la folla accanto al fiume Giordano, venuto per farsi battezzare da suo cugino Giovanni il Battista come uno dei tanti del suo popolo (cfr Mt 3,13-17).
25. Quel battesimo non era come il nostro, che ci introduce alla vita della grazia, bensì è stata una consacrazione prima di iniziare la grande missione della sua vita. Il Vangelo dice che il suo battesimo è stato motivo della gioia e del beneplacito del Padre: «Tu sei il Figlio mio, l’amato» (Lc 3,22). Immediatamente Gesù è apparso ricolmo di Spirito Santo ed è stato condotto dallo Spirito nel deserto. In questo modo, era pronto per andare a predicare e a fare prodigi, per liberare e guarire (cfr Lc 4,1-14). Ogni giovane, quando si sente chiamato a compiere una missione su questa terra, è invitato a riconoscere nella sua interiorità quelle stesse parole che Dio Padre gli rivolge: «Tu sei mio figlio amato».
26. Tra questi racconti, ne troviamo uno che mostra Gesù in piena adolescenza. È quando ritornò con i suoi genitori a Nazaret, dopo che lo avevano perso e ritrovato nel Tempio (cfr Lc 2,41-51). Qui dice che «stava loro sottomesso» (cfr Lc 2,51), perché non aveva rinnegato la sua famiglia. Subito Luca aggiunge che Gesù «cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2,52). Vale a dire, si stava preparando e in quel periodo stava approfondendo il suo rapporto con il Padre e con gli altri. San Giovanni Paolo II ha spiegato che non cresceva solo fisicamente, ma che «vi è stata in Gesù anche una crescita spirituale» perché «la pienezza di grazia in Gesù era relativa all’età: c’era sempre pienezza, ma una pienezza crescente col crescere dell’età».[7]
27. In base a questi dati evangelici possiamo affermare che, nella sua fase giovanile, Gesù si stava “formando”, si stava preparando a realizzare il progetto del Padre. La sua adolescenza e la sua giovinezza lo hanno orientato verso quella missione suprema.
28. Nell’adolescenza e nella giovinezza il suo rapporto con il Padre era quello del Figlio amato; attratto dal Padre, cresceva occupandosi delle sue cose: «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 2,49). Tuttavia, non dobbiamo pensare che Gesù fosse un adolescente solitario o un giovane che pensava a sé stesso. Il suo rapporto con la gente era quello di un giovane che condivideva tutta la vita di una famiglia ben integrata nel villaggio. Aveva imparato il lavoro del padre e poi lo ha sostituito come falegname. Per questo, nel Vangelo in una occasione viene chiamato «il figlio del falegname» (Mt 13,55) e un’altra volta semplicemente «il falegname» (Mc 6,3). Questo dettaglio mostra che era un ragazzo del villaggio come gli altri e che aveva relazioni del tutto normali. Nessuno lo considerava un giovane strano o separato dagli altri. Proprio per questo motivo, quando Gesù si presentò a predicare, la gente non si spiegava da dove prendesse quella saggezza: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» (Lc 4,22).
29. Il fatto è che «neppure Gesù crebbe in una relazione chiusa ed esclusiva con Maria e Giuseppe, ma si muoveva con piacere nella famiglia allargata in cui c’erano parenti e amici».[8] Comprendiamo così perché, al momento di ritornare dal pellegrinaggio a Gerusalemme, i genitori fossero tranquilli pensando che quel ragazzo di dodici anni (cfr Lc 2,42) camminasse liberamente tra la gente, benché non lo vedessero per un giorno intero: «credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio» (Lc 2,44). Di certo – pensavano – Gesù stava lì, andava e veniva in mezzo agli altri, scherzava con quelli della sua età, ascoltava i racconti degli adulti e condivideva le gioie e le tristezze della carovana. Il termine greco usato da Luca per la carovana dei pellegrini – synodía – indica precisamente questa “comunità in cammino” di cui la Santa Famiglia è parte. Grazie alla fiducia dei suoi genitori, Gesù si muove con libertà e impara a camminare con tutti gli altri.
La sua giovinezza ci illumina
30. Questi aspetti della vita di Gesù possono costituire un’ispirazione per ogni giovane che cresce e si prepara a compiere la sua missione. Ciò comporta maturare nel rapporto con il Padre, nella consapevolezza di essere uno dei membri della famiglia e della comunità, e nell’apertura ad essere colmato dallo Spirito e condotto a compiere la missione che Dio affida, la propria vocazione. Nulla di tutto questo dovrebbe essere ignorato nella pastorale giovanile, per non creare progetti che isolino i giovani dalla famiglia e dal mondo, o che li trasformino in una minoranza selezionata e preservata da ogni contagio. Abbiamo bisogno, piuttosto, di progetti che li rafforzino, li accompagnino e li proiettino verso l’incontro con gli altri, il servizio generoso, la missione.
31. Gesù non illumina voi, giovani, da lontano o dall’esterno, ma partendo dalla sua stessa giovinezza, che egli condivide con voi. È molto importante contemplare il Gesù giovane che ci mostrano i Vangeli, perché Egli è stato veramente uno di voi, e in Lui si possono riconoscere molti aspetti tipici dei cuori giovani. Lo vediamo, ad esempio, nelle seguenti caratteristiche: «Gesù ha avuto una incondizionata fiducia nel Padre, ha curato l’amicizia con i suoi discepoli, e persino nei momenti di crisi vi è rimasto fedele. Ha manifestato una profonda compassione nei confronti dei più deboli, specialmente i poveri, gli ammalati, i peccatori e gli esclusi. Ha avuto il coraggio di affrontare le autorità religiose e politiche del suo tempo; ha fatto l’esperienza di sentirsi incompreso e scartato; ha provato la paura della sofferenza e conosciuto la fragilità della Passione; ha rivolto il proprio sguardo verso il futuro affidandosi alle mani sicure del Padre e alla forza dello Spirito. In Gesù tutti i giovani possono ritrovarsi».[9]
32. D’altra parte, Gesù è risorto e vuole farci partecipare alla novità della sua risurrezione. Egli è la vera giovinezza di un mondo invecchiato ed è anche la giovinezza di un universo che attende con «le doglie del parto» (Rm 8,22) di essere rivestito della sua luce e della sua vita. Vicino a Lui possiamo bere dalla vera sorgente, che mantiene vivi i nostri sogni, i nostri progetti, i nostri grandi ideali, e che ci lancia nell’annuncio della vita che vale la pena vivere. In due curiosi dettagli del Vangelo di Marco possiamo vedere la chiamata alla vera giovinezza dei risorti. Da una parte, nella passione del Signore appare un giovane timoroso che cercava di seguire Gesù ma che fuggì via nudo (cfr 14,51-52), un giovane che non ebbe la forza di rischiare tutto per seguire il Signore. Invece, vicino al sepolcro vuoto, vediamo un giovane «vestito di una veste bianca» (16,5) che invitava a vincere la paura e annunciava la gioia della risurrezione (cfr 16,6-7).
33. Il Signore ci chiama ad accendere stelle nella notte di altri giovani; ci invita a guardare i veri astri, quei segni così diversificati che Egli ci dà perché non rimaniamo fermi, ma imitiamo il seminatore che osservava le stelle per poter arare il campo. Dio accende stelle per noi affinché possiamo continuare a camminare: «Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioito; egli le ha chiamate e hanno risposto» (Bar 3,34-35). Ma Cristo stesso è per noi la grande luce di speranza e di guida nella nostra notte, perché Egli è «la stella radiosa del mattino» (Ap 22,16).
La giovinezza della Chiesa
34. Essere giovani, più che un’età, è uno stato del cuore. Quindi, un’istituzione antica come la Chiesa può rinnovarsi e tornare ad essere giovane in diverse fasi della sua lunghissima storia. In realtà, nei suoi momenti più tragici, sente la chiamata a tornare all’essenziale del primo amore. Ricordando questa verità, il Concilio Vaticano II affermava che «ricca di un lungo passato sempre in essa vivente, e camminando verso la perfezione umana nel tempo e verso i destini ultimi della storia e della vita, essa è la vera giovinezza del mondo». In essa è sempre possibile incontrare Cristo «il compagno e l’amico dei giovani».[10]
Una Chiesa che si lascia rinnovare
35. Chiediamo al Signore che liberi la Chiesa da coloro che vogliono invecchiarla, fissarla sul passato, frenarla, renderla immobile. Chiediamo anche che la liberi da un’altra tentazione: credere che è giovane perché cede a tutto ciò che il mondo le offre, credere che si rinnova perché nasconde il suo messaggio e si mimetizza con gli altri. No. È giovane quando è sé stessa, quando riceve la forza sempre nuova della Parola di Dio, dell’Eucaristia, della presenza di Cristo e della forza del suo Spirito ogni giorno. È giovane quando è capace di ritornare continuamente alla sua fonte.
36. È vero che noi membri della Chiesa non dobbiamo essere tipi strani. Tutti devono poterci sentire fratelli e vicini, come gli Apostoli, che godevano «il favore di tutto il popolo» (At 2,47; cfr 4,21.33; 5,13). Allo stesso tempo, però, dobbiamo avere il coraggio di essere diversi, di mostrare altri sogni che questo mondo non offre, di testimoniare la bellezza della generosità, del servizio, della purezza, della fortezza, del perdono, della fedeltà alla propria vocazione, della preghiera, della lotta per la giustizia e il bene comune, dell’amore per i poveri, dell’amicizia sociale.
37. La Chiesa di Cristo può sempre cadere nella tentazione di perdere l’entusiasmo perché non ascolta più la chiamata del Signore al rischio della fede, a dare tutto senza misurare i pericoli, e torna a cercare false sicurezze mondane. Sono proprio i giovani che possono aiutarla a rimanere giovane, a non cadere nella corruzione, a non fermarsi, a non inorgoglirsi, a non trasformarsi in una setta, ad essere più povera e capace di testimonianza, a stare vicino agli ultimi e agli scartati, a lottare per la giustizia, a lasciarsi interpellare con umiltà. Essi possono portare alla Chiesa la bellezza della giovinezza quando stimolano «la capacità di rallegrarsi per ciò che comincia, di darsi senza ritorno, di rinnovarsi e di ripartire per nuove conquiste».[11]
38. Chi di noi non è più giovane ha bisogno di occasioni per avere vicini la loro voce e il loro stimolo, e «la vicinanza crea le condizioni perché la Chiesa sia spazio di dialogo e testimonianza di fraternità che affascina».[12] Abbiamo bisogno di creare più spazi dove risuoni la voce dei giovani: «L’ascolto rende possibile uno scambio di doni, in un contesto di empatia. […] Allo stesso tempo pone le condizioni per un annuncio del Vangelo che raggiunga veramente il cuore, in modo incisivo e fecondo».[13]
Una Chiesa attenta ai segni dei tempi
39. «Se per molti giovani Dio, la religione e la Chiesa appaiono parole vuote, essi sono sensibili alla figura di Gesù, quando viene presentata in modo attraente ed efficace».[14] Per questo bisogna che la Chiesa non sia troppo concentrata su sé stessa, ma che rifletta soprattutto Gesù Cristo. Questo comporta che riconosca con umiltà che alcune cose concrete devono cambiare, e a tale scopo ha anche bisogno di raccogliere la visione e persino le critiche dei giovani.
40. Al Sinodo si è riconosciuto che «un numero consistente di giovani, per le ragioni più diverse, non chiedono nulla alla Chiesa perché non la ritengono significativa per la loro esistenza. Alcuni, anzi, chiedono espressamente di essere lasciati in pace, poiché sentono la sua presenza come fastidiosa e perfino irritante. Tale richiesta spesso non nasce da un disprezzo acritico e impulsivo, ma affonda le radici anche in ragioni serie e rispettabili: gli scandali sessuali ed economici; l’impreparazione dei ministri ordinati che non sanno intercettare adeguatamente la sensibilità dei giovani; la scarsa cura nella preparazione dell’omelia e nella presentazione della Parola di Dio; il ruolo passivo assegnato ai giovani all’interno della comunità cristiana; la fatica della Chiesa di rendere ragione delle proprie posizioni dottrinali ed etiche di fronte alla società contemporanea».[15]
41. Anche se ci sono giovani che sono contenti quando vedono una Chiesa che si mostra umilmente sicura dei suoi doni e anche capace di esercitare una critica leale e fraterna, altri giovani chiedono una Chiesa che ascolti di più, che non stia continuamente a condannare il mondo. Non vogliono vedere una Chiesa silenziosa e timida, ma nemmeno sempre in guerra per due o tre temi che la ossessionano. Per essere credibile agli occhi dei giovani, a volte ha bisogno di recuperare l’umiltà e semplicemente ascoltare, riconoscere in ciò che altri dicono una luce che la può aiutare a scoprire meglio il Vangelo. Una Chiesa sulla difensiva, che dimentica l’umiltà, che smette di ascoltare, che non si lascia mettere in discussione, perde la giovinezza e si trasforma in un museo. Come potrà accogliere così i sogni dei giovani? Benché possieda la verità del Vangelo, questo non significa che l’abbia compresa pienamente; piuttosto, deve sempre crescere nella comprensione di questo tesoro inesauribile.[16]
42. Ad esempio, una Chiesa eccessivamente timorosa e strutturata può essere costantemente critica nei confronti di tutti i discorsi sulla difesa dei diritti delle donne ed evidenziare costantemente i rischi e i possibili errori di tali rivendicazioni. Viceversa, una Chiesa viva può reagire prestando attenzione alle legittime rivendicazioni delle donne che chiedono maggiore giustizia e uguaglianza. Può ricordare la storia e riconoscere una lunga trama di autoritarismo da parte degli uomini, di sottomissione, di varie forme di schiavitù, di abusi e di violenza maschilista. Con questo sguardo sarà capace di fare proprie queste rivendicazioni di diritti, e darà il suo contributo con convinzione per una maggiore reciprocità tra uomini e donne, pur non essendo d’accordo con tutto ciò che propongono alcuni gruppi femministi. In questa linea, il Sinodo ha voluto rinnovare l’impegno della Chiesa «contro ogni discriminazione e violenza su base sessuale».[17] Questa è la reazione di una Chiesa che si mantiene giovane e si lascia interrogare e stimolare dalla sensibilità dei giovani.
Maria, la ragazza di Nazaret
43. Nel cuore della Chiesa risplende Maria. Ella è il grande modello per una Chiesa giovane che vuole seguire Cristo con freschezza e docilità. Quando era molto giovane, ricevette l’annuncio dell’angelo e non rinunciò a fare domande (cfr Lc 1,34). Ma aveva un’anima disponibile e disse: «Ecco la serva del Signore» (Lc 1,38).
44. «Sempre impressiona la forza del “sì” di Maria, giovane. La forza di quell’“avvenga per me” che disse all’angelo. È stata una cosa diversa da un’accettazione passiva o rassegnata. È stato qualcosa di diverso da un “sì” come a dire: “Bene, proviamo a vedere che succede”. Maria non conosceva questa espressione: vediamo cosa succede. Era decisa, ha capito di cosa si trattava e ha detto “sì”, senza giri di parole. È stato qualcosa di più, qualcosa di diverso. È stato il “sì” di chi vuole coinvolgersi e rischiare, di chi vuole scommettere tutto, senza altra garanzia che la certezza di sapere di essere portatrice di una promessa. E domando a ognuno di voi: vi sentite portatori di una promessa? Quale promessa porto nel cuore, da portare avanti? Maria, indubbiamente, avrebbe avuto una missione difficile, ma le difficoltà non erano un motivo per dire “no”. Certo che avrebbe avuto complicazioni, ma non sarebbero state le stesse complicazioni che si verificano quando la viltà ci paralizza per il fatto che non abbiamo tutto chiaro o assicurato in anticipo. Maria non ha comprato un’assicurazione sulla vita! Maria si è messa in gioco, e per questo è forte, per questo è una influencer, è l’influencer di Dio! Il “sì” e il desiderio di servire sono stati più forti dei dubbi e delle difficoltà».[18]
45. Senza cedere a evasioni o miraggi, «Ella seppe accompagnare il dolore di suo Figlio, […] sostenerlo con lo sguardo e proteggerlo con il cuore. Dolore che soffrì, ma che non la piegò. È stata la donna forte del “sì”, che sostiene e accompagna, protegge e abbraccia. Ella è la grande custode della speranza. […] Da lei impariamo a dire “sì” alla pazienza testarda e alla creatività di quelli che non si perdono d’animo e ricominciano da capo».[19]
46. Maria era la ragazza con un’anima grande che esultava di gioia (cfr Lc 1,47), era la fanciulla con gli occhi illuminati dallo Spirito Santo che contemplava la vita con fede e custodiva tutto nel suo cuore (cfr Lc 2,19,51). Era quella inquieta, quella pronta a partire, che quando seppe che sua cugina aveva bisogno di lei non pensò ai propri progetti, ma si avviò «senza indugio» (Lc 1,39) verso la regione montuosa.
47. E quando c’è bisogno di proteggere il suo bambino, eccola andare con Giuseppe in un paese lontano (cfr Mt 2,13-14). Per questo rimase in mezzo ai discepoli riuniti in preghiera in attesa dello Spirito Santo (cfr At 1,14). Così, con la sua presenza, è nata una Chiesa giovane, con i suoi Apostoli in uscita per far nascere un mondo nuovo (cfr At 2,4-11).
48. Quella ragazza oggi è la Madre che veglia sui figli, su di noi suoi figli che camminiamo nella vita spesso stanchi, bisognosi, ma col desiderio che la luce della speranza non si spenga. Questo è ciò che vogliamo: che la luce della speranza non si spenga. La nostra Madre guarda questo popolo pellegrino, popolo di giovani che lei ama, che la cerca facendo silenzio nel proprio cuore nonostante che lungo il cammino ci sia tanto rumore, conversazioni e distrazioni. Ma davanti agli occhi della Madre c’è posto soltanto per il silenzio colmo di speranza. E così Maria illumina di nuovo la nostra giovinezza.
Giovani santi
49. Il cuore della Chiesa è pieno anche di giovani santi, che hanno dato la loro vita per Cristo, molti di loro fino al martirio. Sono stati preziosi riflessi di Cristo giovane che risplendono per stimolarci e farci uscire dalla sonnolenza. Il Sinodo ha sottolineato che «molti giovani santi hanno fatto risplendere i lineamenti dell’età giovanile in tutta la loro bellezza e sono stati nella loro epoca veri profeti di cambiamento; il loro esempio mostra di che cosa siano capaci i giovani quando si aprono all’incontro con Cristo».[20]
50. «Attraverso la santità dei giovani la Chiesa può rinnovare il suo ardore spirituale e il suo vigore apostolico. Il balsamo della santità generata dalla vita buona di tanti giovani può curare le ferite della Chiesa e del mondo, riportandoci a quella pienezza dell’amore a cui da sempre siamo stati chiamati: i giovani santi ci spingono a ritornare al nostro primo amore (cfr Ap 2,4)».[21] Ci sono santi che non hanno conosciuto la vita adulta e ci hanno lasciato la testimonianza di un altro modo di vivere la giovinezza. Ricordiamo almeno alcuni di loro, di diversi periodi storici, che hanno vissuto la santità ognuno a suo modo.
51. Nel III secolo, San Sebastiano era un giovane capitano della guardia pretoriana. Raccontano che parlava di Cristo dappertutto e cercava di convertire i suoi compagni, fino a quando gli ordinarono di rinunciare alla sua fede. Poiché non accettò, gli lanciarono addosso una pioggia di frecce, ma sopravvisse e continuò ad annunciare Cristo senza paura. Alla fine lo frustarono fino ad ucciderlo.
52. San Francesco d’Assisi, quando era molto giovane e pieno di sogni, sentì la chiamata di Gesù ad essere povero come Lui e a restaurare la Chiesa con la sua testimonianza. Rinunciò a tutto con gioia ed è il santo della fraternità universale, il fratello di tutti, che lodava il Signore per le sue creature. Morì nel 1226.
53. Santa Giovanna d’Arco nacque nel 1412. Era una giovane contadina che, nonostante la giovane età, combatté per difendere la Francia dagli invasori. Incompresa per il suo aspetto e per il suo modo di vivere la fede, morì sul rogo.
54. Il beato Andrew Phû Yên era un giovane vietnamita del XVII secolo. Era catechista e aiutava i missionari. Venne fatto prigioniero per la sua fede e, poiché non volle rinunciarvi, fu ucciso. Morì dicendo: “Gesù”.
55. Nello stesso secolo, Santa Kateri Tekakwitha, una giovane laica nativa del Nord America, fu perseguitata per la fede e nella sua fuga percorse a piedi più di trecento chilometri attraverso fitte foreste. Si consacrò a Dio e morì dicendo: “Gesù, ti amo!”.
56. San Domenico Savio offriva a Maria tutte le sue sofferenze. Quando San Giovanni Bosco gli insegnò che la santità comporta l’essere sempre gioiosi, aprì il suo cuore ad una gioia contagiosa. Cercava di stare vicino ai suoi compagni più emarginati e malati. Morì nel 1857 all’età di quattordici anni, dicendo: “Che meraviglia che sto vedendo!”.
57. Santa Teresa di Gesù Bambino nacque nel 1873. All’età di quindici anni, superando molte difficoltà, riuscì ad entrare in un convento carmelitano. Visse la piccola via della fiducia totale nell’amore del Signore proponendosi di alimentare con la sua preghiera il fuoco dell’amore che muove la Chiesa.
58. Il beato Ceferino Namuncurá era un giovane argentino, figlio di un importante capo delle popolazioni indigene. Divenne un seminarista salesiano, col forte desiderio di ritornare alla sua tribù per portare Gesù Cristo. Morì nel 1905.
59. Il beato Isidoro Bakanja era un laico del Congo che dava testimonianza della sua fede. Fu torturato a lungo per aver proposto il cristianesimo ad altri giovani. Morì perdonando il suo carnefice nel 1909.
60. Il beato Pier Giorgio Frassati, morto nel 1925, «era un giovane di una gioia trascinante, una gioia che superava anche tante difficoltà della sua vita».[22] Diceva di voler ripagare l’amore di Gesù che riceveva nella Comunione visitando e aiutando i poveri.
61. Il beato Marcel Callo era un giovane francese che morì nel 1945. In Austria venne imprigionato in un campo di concentramento dove confortava nella fede i suoi compagni di prigionia, in mezzo a duri lavori.
62. La giovane beata Chiara Badano, che morì nel 1990, «ha sperimentato come il dolore possa essere trasfigurato dall’amore […]. La chiave della sua pace e della sua gioia era la completa fiducia nel Signore e l’accettazione anche della malattia come misteriosa espressione della sua volontà per il bene suo e di tutti».[23]
63. Che costoro, insieme a tanti giovani che, spesso nel silenzio e nell’anonimato, hanno vissuto a fondo il Vangelo, intercedano per la Chiesa, perché sia piena di giovani gioiosi, coraggiosi e impegnati che donino al mondo nuove testimonianze di santità.
CAPITOLO TERZO
Voi siete l’adesso di Dio
64. Dopo aver preso visione della Parola di Dio, non possiamo limitarci a dire che i giovani sono il futuro del mondo: sono il presente, lo stanno arricchendo con il loro contributo. Un giovane non è più un bambino, si trova in un momento della vita in cui comincia ad assumersi diverse responsabilità, partecipando insieme agli adulti allo sviluppo della famiglia, della società, della Chiesa. Però i tempi cambiano, e ritorna la domanda: come sono i giovani oggi, cosa succede adesso ai giovani?
In positivo
65. Il Sinodo ha riconosciuto che i fedeli della Chiesa non sempre hanno l’atteggiamento di Gesù. Invece di disporci ad ascoltarli a fondo, «prevale talora la tendenza a fornire risposte preconfezionate e ricette pronte, senza lasciar emergere le domande giovanili nella loro novità e coglierne la provocazione».[24] D’altra parte, quando la Chiesa abbandona gli schemi rigidi e si apre ad un ascolto disponibile e attento dei giovani, questa empatia la arricchisce, perché «consente ai giovani di donare alla comunità il proprio apporto, aiutandola a cogliere sensibilità nuove e a porsi domande inedite».[25]
66. Oggi noi adulti corriamo il rischio di fare una lista di disastri, di difetti della gioventù del nostro tempo. Alcuni forse ci applaudiranno perché sembriamo esperti nell’individuare aspetti negativi e pericoli. Ma quale sarebbe il risultato di questo atteggiamento? Una distanza sempre maggiore, meno vicinanza, meno aiuto reciproco.
67. Lo sguardo attento di chi è stato chiamato ad essere padre, pastore e guida dei giovani consiste nell’individuare la piccola fiamma che continua ad ardere, la canna che sembra spezzarsi ma non si è ancora rotta (cfr Is 42,3). È la capacità di individuare percorsi dove altri vedono solo muri, è il saper riconoscere possibilità dove altri vedono solo pericoli. Così è lo sguardo di Dio Padre, capace di valorizzare e alimentare i germi di bene seminati nel cuore dei giovani. Il cuore di ogni giovane deve pertanto essere considerato “terra sacra”, portatore di semi di vita divina e davanti al quale dobbiamo “toglierci i sandali” per poterci avvicinare e approfondire il Mistero.
Molte gioventù
68. Potremmo cercare di descrivere le caratteristiche dei giovani di oggi, ma prima di tutto voglio raccogliere un’osservazione dei Padri sinodali: «La composizione stessa del Sinodo ha reso visibile la presenza e l’apporto delle diverse regioni del mondo, evidenziando la bellezza di essere Chiesa universale. Pur in un contesto di globalizzazione crescente, i Padri sinodali hanno chiesto di mettere in evidenza le molte differenze tra contesti e culture, anche all’interno di uno stesso Paese. Esiste una pluralità di mondi giovanili, tanto che in alcuni Paesi si tende a utilizzare il termine “gioventù” al plurale. Inoltre la fascia di età considerata dal presente Sinodo (16-29 anni) non rappresenta un insieme omogeneo, ma è composta di gruppi che vivono situazioni peculiari».[26]
69. Già dal punto di vista demografico, in alcuni Paesi ci sono molti giovani, mentre altri hanno un tasso di natalità molto basso. Tuttavia, «un’ulteriore differenza deriva dalla storia, che rende diversi i Paesi e i continenti di antica tradizione cristiana, la cui cultura è portatrice di una memoria da non disperdere, dai Paesi e continenti segnati invece da altre tradizioni religiose e in cui il cristianesimo è una presenza minoritaria e talvolta recente. In altri territori poi le comunità cristiane e i giovani che ne fanno parte sono oggetto di persecuzione».[27] Occorre inoltre distinguere quei giovani «che hanno accesso a una quantità crescente di opportunità offerte dalla globalizzazione, da quanti invece vivono ai margini della società o nel mondo rurale e patiscono gli effetti di forme di esclusione e scarto».[28]
70. Ci sono molte altre differenze che sarebbe complicato descrivere qui nei dettagli. Pertanto, non mi sembra opportuno soffermarmi ad offrire un’analisi esaustiva dei giovani nel mondo di oggi, di come vivono e di cosa stia succedendo loro. Tuttavia, poiché non posso evitare di osservare la realtà, segnalerò brevemente alcuni contributi che sono pervenuti prima del Sinodo e altri che ho potuto raccogliere durante il suo svolgimento.
Alcune cose che succedono ai giovani
71. La gioventù non è un oggetto che può essere analizzato in termini astratti. In realtà, “la gioventù” non esiste, esistono i giovani con le loro vite concrete. Nel mondo di oggi, pieno di progressi, tante di queste vite sono esposte alla sofferenza e alla manipolazione.
Giovani di un mondo in crisi
72. I Padri sinodali hanno evidenziato con dolore che «molti giovani vivono in contesti di guerra e subiscono la violenza in una innumerevole varietà di forme: rapimenti, estorsioni, criminalità organizzata, tratta di esseri umani, schiavitù e sfruttamento sessuale, stupri di guerra, ecc. Altri giovani, a causa della loro fede, faticano a trovare un posto nelle loro società e subiscono vari tipi di persecuzioni, fino alla morte. Numerosi sono i giovani che, per costrizione o mancanza di alternative, vivono perpetrando crimini e violenze: bambini soldato, bande armate e criminali, traffico di droga, terrorismo, ecc. Questa violenza spezza molte giovani vite. Abusi e dipendenze, così come violenza e devianza sono tra le ragioni che portano i giovani in carcere, con una particolare incidenza in alcuni gruppi etnici e sociali».[29]
73. Molti giovani sono ideologizzati, strumentalizzati e usati come carne da macello o come forza d’urto per distruggere, intimidire o ridicolizzare altri. E la cosa peggiore è che molti si trasformano in soggetti individualisti, nemici e diffidenti verso tutti, e diventano così facile preda di proposte disumanizzanti e dei piani distruttivi elaborati da gruppi politici o poteri economici.
74. Ancora «più numerosi nel mondo sono i giovani che patiscono forme di emarginazione ed esclusione sociale, per ragioni religiose, etniche o economiche. Ricordiamo la difficile situazione di adolescenti e giovani che restano incinte e la piaga dell’aborto, così come la diffusione dell’HIV, le diverse forme di dipendenza (droghe, azzardo, pornografia, ecc.) e la situazione dei bambini e ragazzi di strada, che mancano di casa, famiglia e risorse economiche».[30]E quando poi si tratta di donne, queste situazioni di emarginazione diventano doppiamente dolorose e difficili.
75. Non possiamo essere una Chiesa che non piange di fronte a questi drammi dei suoi figli giovani. Non dobbiamo mai farci l’abitudine, perché chi non sa piangere non è madre. Noi vogliamo piangere perché anche la società sia più madre, perché invece di uccidere impari a partorire, perché sia promessa di vita. Piangiamo quando ricordiamo quei giovani che sono morti a causa della miseria e della violenza e chiediamo alla società di imparare ad essere una madre solidale. Quel dolore non se ne va, ci accompagna ad ogni passo, perché la realtà non può essere nascosta. La cosa peggiore che possiamo fare è applicare la ricetta dello spirito mondano che consiste nell’anestetizzare i giovani con altre notizie, con altre distrazioni, con banalità.
76. Forse «quelli che facciamo una vita più o meno senza necessità non sappiamo piangere. Certe realtà della vita si vedono soltanto con gli occhi puliti dalle lacrime. Invito ciascuno di voi a domandarsi: io ho imparato a piangere? Quando vedo un bambino affamato, un bambino drogato per la strada, un bambino senza casa, un bambino abbandonato, un bambino abusato, un bambino usato come schiavo per la società? O il mio è il pianto capriccioso di chi piange perché vorrebbe avere qualcosa di più?».[31]Cerca di imparare a piangere per i giovani che stanno peggio di te. La misericordia e la compassione si esprimono anche piangendo. Se non ti viene, chiedi al Signore di concederti di versare lacrime per la sofferenza degli altri. Quando saprai piangere, soltanto allora sarai capace di fare qualcosa per gli altri con il cuore.
77. A volte il dolore di alcuni giovani è lacerante; è un dolore che non si può esprimere a parole; è un dolore che ci colpisce come uno schiaffo. Questi giovani possono solo dire a Dio che soffrono molto, che è troppo difficile per loro andare avanti, che non credono più in nessuno. In questo grido straziante, però, si fanno presenti le parole di Gesù: «Beati gli afflitti, perché saranno consolati» (Mt 5,4). Ci sono giovani che sono riusciti ad aprirsi un sentiero nella vita perché li ha raggiunti questa promessa divina. Possa sempre esserci una comunità cristiana vicino a un giovane che soffre, per far risuonare quelle parole con gesti, abbracci e aiuti concreti!
78. È vero che i potenti forniscono alcuni aiuti, ma spesso ad un costo elevato. In molti Paesi poveri, l’aiuto economico di alcuni Paesi più ricchi o di alcuni organismi internazionali è solitamente vincolato all’accettazione di proposte occidentali in materia di sessualità, matrimonio, vita o giustizia sociale. Questa colonizzazione ideologica danneggia in modo particolare i giovani. Nello stesso tempo, vediamo come una certa pubblicità insegna alle persone ad essere sempre insoddisfatte e contribuisce alla cultura dello scarto, in cui i giovani stessi finiscono per diventare un materiale “usa e getta”.
79. La cultura di oggi presenta un modello di persona strettamente associato all’immagine del giovane. Si sente bello chi appare giovane, chi effettua trattamenti per far scomparire le tracce del tempo. I corpi giovani sono utilizzati costantemente nella pubblicità, per vendere. Il modello di bellezza è un modello giovanile, ma stiamo attenti, perché questo non è un elogio rivolto ai giovani. Significa soltanto che gli adulti vogliono rubare la gioventù per sé stessi, non che rispettino, amino i giovani e se ne prendano cura.
80. Alcuni giovani «sentono le tradizioni familiari come opprimenti e ne fuggono sotto la spinta di una cultura globalizzata che a volte li lascia senza punti di riferimento. In altre parti del mondo invece tra giovani e adulti non vi è un vero e proprio conflitto generazionale, ma una reciproca estraneità. Talora gli adulti non cercano o non riescono a trasmettere i valori fondanti dell’esistenza oppure assumono stili giovanilistici, rovesciando il rapporto tra le generazioni. In questo modo la relazione tra giovani e adulti rischia di rimanere sul piano affettivo, senza toccare la dimensione educativa e culturale».[32] Come fa male questo ai giovani, benché alcuni non se ne rendano conto! I giovani stessi ci hanno fatto notare che questo ostacola enormemente la trasmissione della fede «in quei Paesi in cui non vi è libertà di espressione, dove ai giovani […] non è permesso partecipare alla vita della Chiesa».[33]
Desideri, ferite e ricerche
81. I giovani riconoscono che il corpo e la sessualità sono essenziali per la loro vita e per la crescita della loro identità. Tuttavia, in un mondo che enfatizza esclusivamente la sessualità, è difficile mantenere una buona relazione col proprio corpo e vivere serenamente le relazioni affettive. Per questa e per altre ragioni, la morale sessuale è spesso «causa di incomprensione e di allontanamento dalla Chiesa, in quanto è percepita come uno spazio di giudizio e di condanna». Nello stesso tempo, i giovani esprimono «un esplicito desiderio di confronto sulle questioni relative alla differenza tra identità maschile e femminile, alla reciprocità tra uomini e donne, all’omosessualità».[34]
82. Nel nostro tempo, «gli sviluppi della scienza e delle tecnologie biomediche incidono fortemente sulla percezione del corpo, inducendo l’idea che sia modificabile senza limite. La capacità di intervenire sul DNA, la possibilità di inserire elementi artificiali nell’organismo (cyborg) e lo sviluppo delle neuroscienze costituiscono una grande risorsa, ma sollevano allo stesso tempo interrogativi antropologici ed etici».[35] Possono farci dimenticare che la vita è un dono, che siamo esseri creati e limitati, che possiamo facilmente essere strumentalizzati da chi detiene il potere tecnologico.[36] «Inoltre in alcuni contesti giovanili si diffonde il fascino per comportamenti a rischio come strumento per esplorare se stessi, ricercare emozioni forti e ottenere riconoscimento. […] Tali fenomeni, a cui le nuove generazioni sono esposte, costituiscono un ostacolo per una serena maturazione».[37]
83. Nei giovani troviamo anche, impressi nell’anima, i colpi ricevuti, i fallimenti, i ricordi tristi. Molte volte «sono le ferite delle sconfitte della propria storia, dei desideri frustrati, delle discriminazioni e ingiustizie subite, del non essersi sentiti amati o riconosciuti». «Ci sono poi le ferite morali, il peso dei propri errori, i sensi di colpa per aver sbagliato».[38]Gesù si fa presente in queste croci dei giovani, per offrire loro la sua amicizia, il suo sollievo, la sua compagnia risanatrice, e la Chiesa vuole essere il suo strumento in questo percorso verso la guarigione interiore e la pace del cuore.
84. In alcuni giovani riconosciamo un desiderio di Dio, anche se non con tutti i contorni del Dio rivelato. In altri possiamo intravedere un sogno di fraternità, che non è poco. In molti ci può essere un reale desiderio di sviluppare le capacità di cui sono dotati per offrire qualcosa al mondo. In alcuni vediamo una particolare sensibilità artistica, o una ricerca di armonia con la natura. In altri ci può essere forse un grande bisogno di comunicazione. In molti di loro troveremo un profondo desiderio di una vita diversa. Sono autentici punti di partenza, energie interiori che attendono con apertura una parola di stimolo, di luce e di incoraggiamento.
85. Il Sinodo ha trattato in modo particolare tre temi di grande importanza, e su questi voglio accoglierne le conclusioni testualmente, anche se ci richiederanno ancora di proseguire con ulteriori analisi e di sviluppare una capacità di risposta più adeguata ed efficace.
L’ambiente digitale
86. «L’ambiente digitale caratterizza il mondo contemporaneo. Larghe fasce dell’umanità vi sono immerse in maniera ordinaria e continua. Non si tratta più soltanto di “usare” strumenti di comunicazione, ma di vivere in una cultura ampiamente digitalizzata che ha impatti profondissimi sulla nozione di tempo e di spazio, sulla percezione di sé, degli altri e del mondo, sul modo di comunicare, di apprendere, di informarsi, di entrare in relazione con gli altri. Un approccio alla realtà che tende a privilegiare l’immagine rispetto all’ascolto e alla lettura influenza il modo di imparare e lo sviluppo del senso critico».[39]
87. Internet e le reti sociali hanno creato un nuovo modo di comunicare e stabilire legami, e «sono una piazza in cui i giovani trascorrono molto tempo e si incontrano facilmente, anche se non tutti vi hanno ugualmente accesso, in particolare in alcune regioni del mondo. Essi costituiscono comunque una straordinaria opportunità di dialogo, incontro e scambio tra le persone, oltre che di accesso all’informazione e alla conoscenza. Inoltre, quello digitale è un contesto di partecipazione sociopolitica e di cittadinanza attiva, e può facilitare la circolazione di informazione indipendente capace di tutelare efficacemente le persone più vulnerabili palesando le violazioni dei loro diritti. In molti Paesi web e social network rappresentano ormai un luogo irrinunciabile per raggiungere e coinvolgere i giovani, anche in iniziative e attività pastorali».[40]
88. Tuttavia, per comprendere questo fenomeno nella sua totalità, occorre riconoscere che, come ogni realtà umana, esso è attraversato da limiti e carenze. Non è sano confondere la comunicazione con il semplice contatto virtuale. Infatti, «l’ambiente digitale è anche un territorio di solitudine, manipolazione, sfruttamento e violenza, fino al caso estremo del dark web. I media digitali possono esporre al rischio di dipendenza, di isolamento e di progressiva perdita di contatto con la realtà concreta, ostacolando lo sviluppo di relazioni interpersonali autentiche. Nuove forme di violenza si diffondono attraverso i social media, ad esempio il cyberbullismo; il web è anche un canale di diffusione della pornografia e di sfruttamento delle persone a scopo sessuale o tramite il gioco d’azzardo».[41]
89. Non andrebbe dimenticato che «operano nel mondo digitale giganteschi interessi economici, capaci di realizzare forme di controllo tanto sottili quanto invasive, creando meccanismi di manipolazione delle coscienze e del processo democratico. Il funzionamento di molte piattaforme finisce spesso per favorire l’incontro tra persone che la pensano allo stesso modo, ostacolando il confronto tra le differenze. Questi circuiti chiusi facilitano la diffusione di informazioni e notizie false, fomentando pregiudizi e odio. La proliferazione delle fake news è espressione di una cultura che ha smarrito il senso della verità e piega i fatti a interessi particolari. La reputazione delle persone è messa a repentaglio tramite processi sommari on line. Il fenomeno riguarda anche la Chiesa e i suoi pastori».[42]
90. In un documento preparato da 300 giovani di tutto il mondo prima del Sinodo, essi hanno segnalato che «le relazioni on line possono diventare disumane. Gli spazi digitali ci rendono ciechi alla fragilità dell’altro e ci impediscono l’introspezione. Problemi come la pornografia distorcono la percezione della sessualità umana da parte dei giovani. La tecnologia usata in questo modo crea una ingannevole realtà parallela che ignora la dignità umana».[43]L’immersione nel mondo virtuale ha favorito una sorta di “migrazione digitale”, vale a dire un distanziamento dalla famiglia, dai valori culturali e religiosi, che conduce molte persone verso un mondo di solitudine e di auto-invenzione, fino a sperimentare una mancanza di radici, benché rimangano fisicamente nello stesso luogo. La vita nuova e traboccante dei giovani, che preme e cerca di affermare la propria personalità, affronta oggi una nuova sfida: interagire con un mondo reale e virtuale in cui si addentrano da soli come in un continente sconosciuto. I giovani di oggi sono i primi a operare questa sintesi tra ciò che è personale, ciò che è specifico di una cultura e ciò che è globale. Questo però richiede che riescano a passare dal contatto virtuale a una comunicazione buona e sana.
I migranti come paradigma del nostro tempo
91. Come non ricordare i tanti giovani direttamente coinvolti nelle migrazioni? Queste «rappresentano a livello mondiale un fenomeno strutturale e non un’emergenza transitoria. Le migrazioni possono avvenire all’interno dello stesso Paese oppure tra Paesi diversi. La preoccupazione della Chiesa riguarda in particolare coloro che fuggono dalla guerra, dalla violenza, dalla persecuzione politica o religiosa, dai disastri naturali dovuti anche ai cambiamenti climatici e dalla povertà estrema: molti di loro sono giovani. In genere sono alla ricerca di opportunità per sé e per la propria famiglia. Sognano un futuro migliore e desiderano creare le condizioni perché si realizzi».[44]I migranti «ci ricordano la condizione originaria della fede, ovvero quella di essere “stranieri e pellegrini sulla terra” (Eb 11,13)».[45]
92. Altri migranti sono «attirati dalla cultura occidentale, nutrendo talvolta aspettative irrealistiche che li espongono a pesanti delusioni. Trafficanti senza scrupolo, spesso legati ai cartelli della droga e delle armi, sfruttano la debolezza dei migranti, che lungo il loro percorso troppo spesso incontrano la violenza, la tratta, l’abuso psicologico e anche fisico, e sofferenze indicibili. Va segnalata la particolare vulnerabilità dei migranti minori non accompagnati, e la situazione di coloro che sono costretti a passare molti anni nei campi profughi o che rimangono bloccati a lungo nei Paesi di transito, senza poter proseguire il corso di studi né esprimere i propri talenti. In alcuni Paesi di arrivo, i fenomeni migratori suscitano allarme e paure, spesso fomentate e sfruttate a fini politici. Si diffonde così una mentalità xenofoba, di chiusura e di ripiegamento su se stessi, a cui occorre reagire con decisione».[46]
93. «I giovani che migrano sperimentano la separazione dal proprio contesto di origine e spesso anche uno sradicamento culturale e religioso. La frattura riguarda anche le comunità di origine, che perdono gli elementi più vigorosi e intraprendenti, e le famiglie, in particolare quando migra uno o entrambi i genitori, lasciando i figli nel Paese di origine. La Chiesa ha un ruolo importante come riferimento per i giovani di queste famiglie spezzate. Ma quelle dei migranti sono anche storie di incontro tra persone e tra culture: per le comunità e le società in cui arrivano sono una opportunità di arricchimento e di sviluppo umano integrale di tutti. Le iniziative di accoglienza che fanno riferimento alla Chiesa hanno un ruolo importante da questo punto di vista, e possono rivitalizzare le comunità capaci di realizzarle».[47]
94. «Grazie alla diversa provenienza dei Padri, rispetto al tema dei migranti il Sinodo ha visto l’incontro di molte prospettive, in particolare tra Paesi di partenza e Paesi di arrivo. Inoltre è risuonato il grido di allarme di quelle Chiese i cui membri sono costretti a scappare dalla guerra e dalla persecuzione e che vedono in queste migrazioni forzate una minaccia per la loro stessa esistenza. Proprio il fatto di includere al suo interno tutte queste diverse prospettive mette la Chiesa in condizione di esercitare un ruolo profetico nei confronti della società sul tema delle migrazioni»[48]. Chiedo in particolare ai giovani di non cadere nelle reti di coloro che vogliono metterli contro altri giovani che arrivano nei loro Paesi, descrivendoli come soggetti pericolosi e come se non avessero la stessa inalienabile dignità di ogni essere umano.
Porre fine a ogni forma di abuso
95. Negli ultimi tempi ci è stato chiesto con forza di ascoltare il grido delle vittime dei vari tipi di abusi commessi da alcuni vescovi, sacerdoti, religiosi e laici. Questi peccati provocano nelle vittime «sofferenze che possono durare tutta la vita e a cui nessun pentimento può porre rimedio. Tale fenomeno è diffuso nella società, tocca anche la Chiesa e rappresenta un serio ostacolo alla sua missione».[49]
96. È vero che «la piaga degli abusi sessuali su minori è un fenomeno storicamente diffuso purtroppo in tutte le culture e le società», soprattutto all’interno delle famiglie stesse e in diverse istituzioni, la cui estensione è venuta in evidenza in particolare «grazie al cambiamento della sensibilità dell’opinione pubblica». Tuttavia, «l’universalità di tale piaga, mentre conferma la sua gravità nelle nostre società, non diminuisce la sua mostruosità all’interno della Chiesa» e «nella rabbia, giustificata, della gente, la Chiesa vede il riflesso dell’ira di Dio, tradito e schiaffeggiato».[50]
97. «Il Sinodo ribadisce il fermo impegno per l’adozione di rigorose misure di prevenzione che ne impediscano il ripetersi, a partire dalla selezione e dalla formazione di coloro a cui saranno affidati compiti di responsabilità ed educativi».[51]Allo stesso tempo, non deve più essere abbandonata la decisione di applicare «azioni e sanzioni così necessarie».[52] E tutto questo con la grazia di Cristo. Non si può più tornare indietro.
98. «Esistono diversi tipi di abuso: di potere, economici, di coscienza, sessuali. Si rende evidente il compito di sradicare le forme di esercizio dell’autorità su cui essi si innestano e di contrastare la mancanza di responsabilità e trasparenza con cui molti casi sono stati gestiti. Il desiderio di dominio, la mancanza di dialogo e di trasparenza, le forme di doppia vita, il vuoto spirituale, nonché le fragilità psicologiche sono il terreno su cui prospera la corruzione».[53] Il clericalismo è una tentazione permanente dei sacerdoti, che interpretano «il ministero ricevuto come un potere da esercitare piuttosto che come un servizio gratuito e generoso da offrire; e ciò conduce a ritenere di appartenere a un gruppo che possiede tutte le risposte e non ha più bisogno di ascoltare e di imparare nulla».[54]Indubbiamente, il clericalismo espone le persone consacrate al rischio di perdere il rispetto per il valore sacro e inalienabile di ogni persona e della sua libertà.
99. Insieme ai Padri sinodali, voglio esprimere con affetto e riconoscenza la mia «gratitudine verso coloro che hanno il coraggio di denunciare il male subìto: aiutano la Chiesa a prendere coscienza di quanto avvenuto e della necessità di reagire con decisione».[55] Tuttavia, merita una riconoscenza speciale anche «l’impegno sincero di innumerevoli laiche e laici, sacerdoti, consacrati, consacrate e vescovi che ogni giorno si spendono con onestà e dedizione al servizio dei giovani. La loro opera è una foresta che cresce senza fare rumore. Anche molti tra i giovani presenti al Sinodo hanno manifestato gratitudine per coloro da cui sono stati accompagnati e ribadito il grande bisogno di figure di riferimento».[56]
100. Grazie a Dio, i sacerdoti che si sono macchiati di questi orribili crimini non sono la maggioranza, che invece è costituita da chi porta avanti un ministero fedele e generoso. Ai giovani chiedo di lasciarsi stimolare da questa maggioranza. In ogni caso, se vedete un sacerdote a rischio, perché ha perso la gioia del suo ministero, perché cerca compensazioni affettive o ha imboccato la strada sbagliata, abbiate il coraggio di ricordargli il suo impegno verso Dio e verso il suo popolo, annunciategli voi stessi il Vangelo e incoraggiatelo a rimanere sulla strada giusta. Così facendo, offrirete un aiuto inestimabile su un aspetto fondamentale: la prevenzione che permette di evitare il ripetersi di queste atrocità. Questa nuvola nera diventa anche una sfida per i giovani che amano Gesù Cristo e la sua Chiesa, perché possono contribuire molto a guarire questa ferita se mettono in gioco la loro capacità di rinnovare, rivendicare, esigere coerenza e testimonianza, di tornare a sognare e a reinventare.
101. Questo non è l’unico peccato dei membri della Chiesa, la cui storia presenta molte ombre. I nostri peccati sono davanti agli occhi di tutti; si riflettono senza pietà nelle rughe del volto millenario della nostra Madre e Maestra. Perché essa cammina da duemila anni, condividendo «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini».[57]E cammina così com’è, senza ricorrere ad alcuna chirurgia estetica. Non ha paura di mostrare i peccati dei suoi membri, che talvolta alcuni di loro cercano di nascondere, davanti alla luce ardente della Parola del Vangelo che pulisce e purifica. E non cessa di ripetere ogni giorno, con vergogna: «Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; […] il mio peccato mi sta sempre dinanzi» (Sal 51,3.5). Ricordiamoci però che non si abbandona la Madre quando è ferita, al contrario, la si accompagna affinché tragga da sé tutta la sua forza e la sua capacità di cominciare sempre di nuovo.
102. Nel pieno di questa tragedia che, giustamente, ci ferisce l’anima, «il Signore Gesù, che mai abbandona la sua Chiesa, le offre la forza e gli strumenti per un nuovo cammino».[58] Così, questo momento oscuro, «con il prezioso aiuto dei giovani, può essere davvero un’opportunità per una riforma di portata epocale»,[59] per aprirsi a una nuova Pentecoste e iniziare una fase di purificazione e di cambiamento che conferisca alla Chiesa una rinnovata giovinezza. Ma i giovani potranno aiutare molto di più se di cuore si sentono parte del «santo e paziente Popolo fedele di Dio, sostenuto e vivificato dallo Spirito Santo», perché «sarà proprio questo santo Popolo di Dio a liberarci dalla piaga del clericalismo, che è il terreno fertile per tutti questi abomini».[60]
C’è una via d’uscita
103. In questo capitolo mi sono soffermato a guardare la realtà dei giovani nel mondo di oggi. Alcuni altri aspetti compariranno nei capitoli successivi. Come ho già detto, non pretendo di essere esaustivo con questa analisi. Esorto le comunità a realizzare con rispetto e serietà un esame della propria realtà giovanile più vicina, per poter discernere i percorsi pastorali più adeguati. Non voglio però concludere questo capitolo senza rivolgere alcune parole ad ognuno di voi.
104. Ti ricordo la buona notizia che ci è stata donata il mattino della Risurrezione: che in tutte le situazioni buie e dolorose di cui parliamo c’è una via d’uscita. Ad esempio, è vero che il mondo digitale può esporti al rischio di chiuderti in te stesso, dell’isolamento o del piacere vuoto. Ma non dimenticare che ci sono giovani che anche in questi ambiti sono creativi e a volte geniali. È il caso del giovane Venerabile Carlo Acutis.
105. Egli sapeva molto bene che questi meccanismi della comunicazione, della pubblicità e delle reti sociali possono essere utilizzati per farci diventare soggetti addormentati, dipendenti dal consumo e dalle novità che possiamo comprare, ossessionati dal tempo libero, chiusi nella negatività. Lui però ha saputo usare le nuove tecniche di comunicazione per trasmettere il Vangelo, per comunicare valori e bellezza.
106. Non è caduto nella trappola. Vedeva che molti giovani, pur sembrando diversi, in realtà finiscono per essere uguali agli altri, correndo dietro a ciò che i potenti impongono loro attraverso i meccanismi del consumo e dello stordimento. In tal modo, non lasciano sbocciare i doni che il Signore ha dato loro, non offrono a questo mondo quelle capacità così personali e uniche che Dio ha seminato in ognuno. Così, diceva Carlo, succede che “tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie”. Non lasciare che ti succeda questo.
107. Non lasciare che ti rubino la speranza e la gioia, che ti narcotizzino per usarti come schiavo dei loro interessi. Osa essere di più, perché il tuo essere è più importante di ogni altra cosa. Non hai bisogno di possedere o di apparire. Puoi arrivare ad essere ciò che Dio, il tuo Creatore, sa che tu sei, se riconosci che sei chiamato a molto. Invoca lo Spirito Santo e cammina con fiducia verso la grande meta: la santità. In questo modo non sarai una fotocopia, sarai pienamente te stesso.
108. Per questo hai bisogno di riconoscere una cosa fondamentale: essere giovani non significa solo cercare piaceri passeggeri e successi superficiali. Affinché la giovinezza realizzi la sua finalità nel percorso della tua vita, dev’essere un tempo di donazione generosa, di offerta sincera, di sacrifici che costano ma ci rendono fecondi. È come diceva un grande poeta:
«Se per recuperare ciò che ho recuperato
ho dovuto perdere prima ciò che ho perso,
se per ottenere ciò che ho ottenuto
ho dovuto sopportare ciò che ho sopportato,
se per essere adesso innamorato
ho dovuto essere ferito,
ritengo giusto aver sofferto ciò che ho sofferto,
ritengo giusto aver pianto ciò che ho pianto.
Perché dopotutto ho constatato
che non si gode bene del goduto
se non dopo averlo patito.
Perché dopotutto ho capito
che ciò che l’albero ha di fiorito
vive di ciò che ha di sotterrato».[61]
109. Se sei giovane di età, ma ti senti debole, stanco o deluso, chiedi a Gesù di rinnovarti. Con Lui non viene meno la speranza. Lo stesso puoi fare se ti senti immerso nei vizi, nelle cattive abitudini, nell’egoismo o nella comodità morbosa. Gesù, pieno di vita, vuole aiutarti perché valga la pena essere giovane. Così non priverai il mondo di quel contributo che solo tu puoi dare, essendo unico e irripetibile come sei.
110. Voglio anche ricordarti, però, che «è molto difficile lottare contro la propria concupiscenza e contro le insidie e tentazioni del demonio e del mondo egoista se siamo isolati. È tale il bombardamento che ci seduce che, se siamo troppo soli, facilmente perdiamo il senso della realtà, la chiarezza interiore, e soccombiamo».[62]Questo vale soprattutto per i giovani, perché insieme voi avete una forza ammirevole. Quando vi entusiasmate per una vita comunitaria, siete capaci di grandi sacrifici per gli altri e per la comunità. L’isolamento, al contrario, vi indebolisce e vi espone ai peggiori mali del nostro tempo.
CAPITOLO QUARTO
Il grande annuncio per tutti i giovani
111. Al di là di ogni circostanza, a tutti i giovani voglio annunciare ora la cosa più importante, la prima cosa, quella che non dovrebbe mai essere taciuta. Si tratta di un annuncio che include tre grandi verità che tutti abbiamo bisogno di ascoltare sempre, più volte.
Un Dio che è amore
112. Anzitutto voglio dire ad ognuno la prima verità: “Dio ti ama”. Se l’hai già sentito, non importa, voglio ricordartelo: Dio ti ama. Non dubitarne mai, qualunque cosa ti accada nella vita. In qualunque circostanza, sei infinitamente amato.
113. Forse l’esperienza di paternità che hai vissuto non è stata la migliore, il tuo padre terreno forse è stato lontano e assente o, al contrario, dominante e possessivo; o semplicemente non è stato il padre di cui avevi bisogno. Non lo so. Però quello che posso dirti con certezza è che puoi gettarti in tutta sicurezza nelle braccia del tuo Padre divino, di quel Dio che ti ha dato la vita e che te la dà in ogni momento. Egli ti sosterrà saldamente e, nello stesso tempo, sentirai che rispetta fino in fondo la tua libertà.
114. Nella sua Parola troviamo molte espressioni del suo amore. È come se stesse cercando diversi modi di manifestarlo per vedere se qualcuna di quelle parole può arrivare al tuo cuore.
Per esempio, a volte si presenta come quei genitori affettuosi che giocano con i loro figli: «Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia» (Os 11,4).
A volte appare colmo dell’amore di quelle madri che amano sinceramente i loro figli, con un amore viscerale che è incapace di dimenticare e di abbandonare: «Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai» (Is 49,15).
Si mostra persino come un innamorato che arriva al punto di tatuarsi la persona amata sul palmo della mano per poter avere il suo viso sempre vicino: «Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato» (Is 49,16).
Altre volte sottolinea la forza e la fermezza del suo amore, che non si lascia vincere: «Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace» (Is 54,10).
Oppure ci dice che siamo stati attesi da sempre, perché non siamo apparsi in questo mondo per caso. Prima ancora di esistere, eravamo un progetto del suo amore: «Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele» (Ger 31,3).
Oppure ci fa notare che Egli sa vedere la nostra bellezza, quella che nessun altro può riconoscere: «Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo» (Is 43,4).
O ci porta a scoprire che il suo amore non è triste, ma pura gioia che si rinnova quando ci lasciamo amare da Lui: «Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia» (Sof 3,17).
115. Per Lui tu sei realmente prezioso, non sei insignificante, sei importante per Lui, perché sei opera delle sue mani. Per questo ti dedica attenzione e ti ricorda con affetto. Devi avere fiducia nel «ricordo di Dio: la sua memoria non è un “disco rigido” che registra e archivia tutti i nostri dati, la sua memoria è un cuore tenero di compassione, che gioisce nel cancellare definitivamente ogni nostra traccia di male».[63]Non vuole tenere il conto dei tuoi errori e, in ogni caso, ti aiuterà ad imparare qualcosa anche dalle tue cadute. Perché ti ama. Cerca di rimanere un momento in silenzio lasciandoti amare da Lui. Cerca di mettere a tacere tutte le voci e le grida interiori e rimani un momento nel suo abbraccio d’amore.
116. È un amore «che non si impone e non schiaccia, un amore che non emargina e non mette a tacere e non tace, un amore che non umilia e non soggioga. È l’amore del Signore, amore quotidiano, discreto e rispettoso, amore di libertà e per la libertà, amore che guarisce ed eleva. È l’amore del Signore, che sa più di risalite che di cadute, di riconciliazione che di proibizione, di dare nuova opportunità che di condannare, di futuro che di passato».[64]
117. Quando ti chiede qualcosa o quando semplicemente permette quelle sfide che la vita ti presenta, si aspetta che tu gli faccia spazio per spingerti ad andare avanti, per spronarti, per farti maturare. Non gli dà fastidio che tu gli esprima i tuoi dubbi, quello che lo preoccupa è che non gli parli, che tu non ti apra con sincerità al dialogo con Lui. Racconta la Bibbia che Giacobbe lottò con Dio (cfr Gen 32,25-31), ma questo non lo allontanò dalla via del Signore. In realtà è Lui stesso che ci esorta: «Su, venite e discutiamo» (Is 1,18). Il suo amore è così reale, così vero, così concreto, che ci offre una relazione piena di dialogo sincero e fecondo. Infine, cerca l’abbraccio del tuo Padre celeste nel volto amorevole dei suoi coraggiosi testimoni sulla terra!
Cristo ti salva
118. La seconda verità è che Cristo, per amore, ha dato sé stesso fino alla fine per salvarti. Le sue braccia aperte sulla croce sono il segno più prezioso di un amico capace di arrivare fino all’estremo: «Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine» (Gv 13,1).
San Paolo affermava di vivere affidato a quell’amore che ha dato tutto: «Questa vita, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato sé stesso per me» (Gal 2,20).
119. Quel Cristo che ci ha salvato sulla croce dai nostri peccati, con lo stesso potere del suo totale dono di sé continua a salvarci e redimerci oggi. Guarda la sua Croce, aggrappati a Lui, lasciati salvare, perché «coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento».[65] E se pecchi e ti allontani, Egli di nuovo ti rialza con il potere della sua Croce. Non dimenticare mai che «Egli perdona settanta volte sette. Torna a caricarci sulle sue spalle una volta dopo l’altra. Nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore infinito e incrollabile. Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare, con una tenerezza che mai ci delude e che sempre può restituirci la gioia».[66]
120. Noi «siamo salvati da Gesù: perché ci ama e non può farne a meno. Possiamo fargli qualunque cosa, ma Lui ci ama, e ci salva. Perché solo quello che si ama può essere salvato. Solo quello che si abbraccia può essere trasformato. L’amore del Signore è più grande di tutte le nostre contraddizioni, di tutte le nostre fragilità e di tutte le nostre meschinità. Ma è precisamente attraverso le nostre contraddizioni, fragilità e meschinità che Lui vuole scrivere questa storia d’amore. Ha abbracciato il figlio prodigo, ha abbracciato Pietro dopo i suoi rinnegamenti e ci abbraccia sempre, sempre, sempre dopo le nostre cadute aiutandoci ad alzarci e a rimetterci in piedi. Perché la vera caduta – attenzione a questo – la vera caduta, quella che può rovinarci la vita, è rimanere a terra e non lasciarsi aiutare».[67]
121. Il suo perdono e la sua salvezza non sono qualcosa che abbiamo comprato o che dovremmo acquisire con le nostre opere o i nostri sforzi. Egli ci perdona e ci libera gratuitamente. Il suo donarsi sulla croce è qualcosa di così grande che noi non possiamo né dobbiamo pagarlo, dobbiamo soltanto accoglierlo con immensa gratitudine e con la gioia di essere amati così tanto prima di poterlo immaginare: «egli ci ha amati per primo» (1 Gv 4,19).
122. Giovani amati dal Signore, quanto valete voi se siete stati redenti dal sangue prezioso di Cristo! Cari giovani, voi «non avete prezzo! Non siete pezzi da vendere all’asta! Per favore, non lasciatevi comprare, non lasciatevi sedurre, non lasciatevi schiavizzare dalle colonizzazioni ideologiche che ci mettono strane idee in testa e alla fine diventiamo schiavi, dipendenti, falliti nella vita. Voi non avete prezzo: dovete sempre ripetervelo: non sono all’asta, non ho prezzo. Sono libero, sono libero! Innamoratevi di questa libertà, che è quella che offre Gesù».[68]
123. Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre nuovamente. E quando ti avvicini per confessare i tuoi peccati, credi fermamente nella sua misericordia che ti libera dalla colpa. Contempla il suo sangue versato con tanto affetto e lasciati purificare da esso. Così potrai rinascere sempre di nuovo.
Egli vive!
124. C’è però una terza verità, che è inseparabile dalla precedente: Egli vive! Occorre ricordarlo spesso, perché corriamo il rischio di prendere Gesù Cristo solo come un buon esempio del passato, come un ricordo, come qualcuno che ci ha salvato duemila anni fa. Questo non ci servirebbe a nulla, ci lascerebbe uguali a prima, non ci libererebbe. Colui che ci colma della sua grazia, Colui che ci libera, Colui che ci trasforma, Colui che ci guarisce e ci conforta è qualcuno che vive. È Cristo risorto, pieno di vitalità soprannaturale, rivestito di luce infinita. Per questo San Paolo affermava: «Se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede» (1 Cor 15,17).
125. Se Egli vive, allora davvero potrà essere presente nella tua vita, in ogni momento, per riempirlo di luce. Così non ci saranno mai più solitudine e abbandono. Anche se tutti se ne andassero, Egli sarà lì, come ha promesso: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). Egli riempie tutto con la sua presenza invisibile, e dovunque tu vada ti starà aspettando. Perché non solo è venuto, ma viene e continuerà a venire ogni giorno per invitarti a camminare verso un orizzonte sempre nuovo.
126. Contempla Gesù felice, traboccante di gioia. Gioisci con il tuo Amico che ha trionfato. Hanno ucciso il santo, il giusto, l’innocente, ma Egli ha vinto. Il male non ha l’ultima parola. Nemmeno nella tua vita il male avrà l’ultima parola, perché il tuo Amico che ti ama vuole trionfare in te. Il tuo Salvatore vive.
127. Se Egli vive, questo è una garanzia che il bene può farsi strada nella nostra vita, e che le nostre fatiche serviranno a qualcosa. Allora possiamo smettere di lamentarci e guardare avanti, perché con Lui si può sempre guardare avanti. Questa è la sicurezza che abbiamo. Gesù è l’eterno vivente. Aggrappati a Lui, vivremo e attraverseremo indenni tutte le forme di morte e di violenza che si nascondono lungo il cammino.
128. Qualsiasi altra soluzione risulterà debole e temporanea. Forse risulterà utile per un po’ di tempo, poi ci troveremo di nuovo indifesi, abbandonati, esposti alle intemperie. Con Lui, invece, il cuore è radicato in una sicurezza di fondo, che permane al di là di tutto. San Paolo dice di voler essere unito a Cristo per «conoscere lui, la potenza della sua risurrezione» (Fil 3,10). È il potere che si manifesterà molte volte anche nella tua esistenza, perché Egli è venuto per darti la vita, «e la vita in abbondanza» (Gv 10,10).
129. Se riesci ad apprezzare con il cuore la bellezza di questo annuncio e a lasciarti incontrare dal Signore; se ti lasci amare e salvare da Lui; se entri in amicizia con Lui e cominci a conversare con Cristo vivo sulle cose concrete della tua vita, questa sarà la grande esperienza, sarà l’esperienza fondamentale che sosterrà la tua vita cristiana. Questa è anche l’esperienza che potrai comunicare ad altri giovani. Perché «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva».[69]
Lo Spirito dà vita
130. In queste tre verità – Dio ti ama, Cristo è il tuo salvatore, Egli vive – compare Dio Padre e compare Gesù. Dove ci sono il Padre e Gesù, c’è anche lo Spirito Santo. È Lui che prepara e apre i cuori perché accolgano questo annuncio, è Lui che mantiene viva questa esperienza di salvezza, è Lui che ti aiuterà a crescere in questa gioia se lo lasci agire. Lo Spirito Santo riempie il cuore di Cristo risorto e da lì si riversa nella tua vita come una sorgente. E quando lo accogli, lo Spirito Santo ti fa entrare sempre più nel cuore di Cristo, affinché tu sia sempre più colmo del suo amore, della sua luce e della sua forza.
131. Invoca ogni giorno lo Spirito Santo perché rinnovi costantemente in te l’esperienza del grande annuncio. Perché no? Non perdi nulla ed Egli può cambiare la tua vita, può illuminarla e darle una rotta migliore. Non ti mutila, non ti toglie niente, anzi, ti aiuta a trovare ciò di cui hai bisogno nel modo migliore. Hai bisogno di amore? Non lo troverai nella sfrenatezza, usando gli altri, possedendoli o dominandoli. Lo troverai in un modo che ti renderà davvero felice. Cerchi intensità? Non la vivrai accumulando oggetti, spendendo soldi, correndo disperatamente dietro le cose di questo mondo. Arriverà in una maniera molto più bella e soddisfacente se ti lascerai guidare dallo Spirito Santo.
132. Cerchi passione? Come dice una bella poesia: innamorati! (o lasciati innamorare), perché «niente può essere più importante che incontrare Dio. Vale a dire, innamorarsi di Lui in una maniera definitiva e assoluta. Ciò di cui tu ti innamori cattura la tua immaginazione e finisce per lasciare la sua orma su tutto quanto. Sarà quello che decide che cosa ti farà alzare dal letto la mattina, cosa farai nei tuoi tramonti, come trascorrerai i tuoi fine settimana, quello che leggi, quello che sai, quello che ti spezza il cuore e quello che ti travolge di gioia e gratitudine. Innamorati! Rimani nell’amore! Tutto sarà diverso».[70] Questo amore di Dio, che prende con passione tutta la vita, è possibile grazie allo Spirito Santo, perché «l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5).
133. Egli è la sorgente della migliore gioventù. Perché chi confida nel Signore «è come un albero piantato lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende le radici; non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi» (Ger 17,8). Mentre «i giovani faticano e si stancano» (Is 40,30), coloro che ripongono la loro fiducia nel Signore «riacquistano forza,mettono ali come aquile,corrono senza affannarsi,camminano senza stancarsi» (Is 40,31).
CAPITOLO QUINTO
Percorsi di gioventù
134. Come si vive la giovinezza quando ci lasciamo illuminare e trasformare dal grande annuncio del Vangelo? È importante porsi questa domanda, perché la giovinezza, più che un vanto, è un dono di Dio: «Essere giovani è una grazia, una fortuna».[71] È un dono che possiamo sprecare inutilmente, oppure possiamo riceverlo con gratitudine e viverlo in pienezza.
135. Dio è l’autore della giovinezza e opera in ogni giovane. La giovinezza è un tempo benedetto per il giovane e una benedizione per la Chiesa e per il mondo. È una gioia, un canto di speranza e una beatitudine. Apprezzare la giovinezza significa vedere questo periodo della vita come un momento prezioso e non come una fase di passaggio in cui i giovani si sentono spinti verso l’età adulta.
Tempo di sogni e di scelte
136. Al tempo di Gesù l’uscita dall’infanzia era un passaggio della vita quanto mai atteso, molto celebrato e festeggiato. Perciò, quando Gesù restituì la vita a una «bambina» (Mc 5,39), le fece fare un passo in più, la fece crescere e diventare «fanciulla» (Mc 5,41). Quando le disse: «Fanciulla, alzati!» (talitá kum), al tempo stesso la rese più responsabile della sua vita, aprendole le porte della giovinezza.
137. «La giovinezza, fase dello sviluppo della personalità, è marcata da sogni che vanno prendendo corpo, da relazioni che acquistano sempre più consistenza ed equilibrio, da tentativi e sperimentazioni, da scelte che costruiscono gradualmente un progetto di vita. In questa stagione della vita i giovani sono chiamati a proiettarsi in avanti senza tagliare le radici, a costruire autonomia, ma non in solitudine».[72]
138. L’amore di Dio e il nostro rapporto con Cristo vivo non ci impediscono di sognare, non ci chiedono di restringere i nostri orizzonti. Al contrario, questo amore ci sprona, ci stimola, ci proietta verso una vita migliore e più bella. La parola “inquietudine” riassume molte delle aspirazioni dei cuori dei giovani. Come diceva san Paolo VI, «proprio nell’insoddisfazione che vi tormenta […] c’è un elemento di luce».[73] L’inquietudine insoddisfatta, insieme allo stupore per le novità che si presentano all’orizzonte, apre la strada all’audacia che li spinge a prendere la propria vita tra le mani e a diventare responsabili di una missione. Questa sana inquietudine, che si risveglia soprattutto nella giovinezza, rimane la caratteristica di ogni cuore che si mantiene giovane, disponibile, aperto. La vera pace interiore convive con questa insoddisfazione profonda. Sant’Agostino diceva: «Signore, ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te».[74]
139. Qualche tempo fa un amico mi ha chiesto che cosa vedo io quando penso a un giovane. La mia risposta è stata: «Vedo un ragazzo o una ragazza che cerca la propria strada, che vuole volare con i piedi, che si affaccia sul mondo e guarda l’orizzonte con occhi colmi di speranza, pieni di futuro e anche di illusioni. Il giovane va con due piedi come gli adulti, ma a differenza degli adulti, che li tengono paralleli, ne ha sempre uno davanti all’altro, pronto per partire, per scattare. Sempre lanciato in avanti. Parlare dei giovani significa parlare di promesse, e significa parlare di gioia. Hanno tanta forza i giovani, sono capaci di guardare con speranza. Un giovane è una promessa di vita che ha insito un certo grado di tenacia; ha abbastanza follia per potersi illudere e la sufficiente capacità per poter guarire dalla delusione che ne può derivare».[75]
140. Alcuni giovani forse rifiutano questa tappa della vita perché vorrebbero rimanere bambini, o desiderano «un prolungamento indefinito dell’adolescenza e il rimando delle decisioni; la paura del definitivo genera così una sorta di paralisi decisionale. La giovinezza però non può restare un tempo sospeso: essa è l’età delle scelte e proprio in questo consiste il suo fascino e il suo compito più grande. I giovani prendono decisioni in ambito professionale, sociale, politico, e altre più radicali che daranno alla loro esistenza una configurazione determinante».[76] Prendono decisioni anche per quanto riguarda l’amore, la scelta del partner o quella di avere i primi figli. Approfondiremo questi temi negli ultimi capitoli, dedicati alla vocazione personale e al suo discernimento.
141. Ma contro i sogni che ispirano le decisioni, sempre «c’è la minaccia del lamento, della rassegnazione. Questi li lasciamo a quelli che seguono la “dea lamentela”! […] è un inganno: ti fa prendere la strada sbagliata. Quando tutto sembra fermo e stagnante, quando i problemi personali ci inquietano, i disagi sociali non trovano le dovute risposte, non è buono darsi per vinti. La strada è Gesù: farlo salire sulla nostra “barca” e prendere il largo con Lui! Lui è il Signore! Lui cambia la prospettiva della vita. La fede in Gesù conduce a una speranza che va oltre, a una certezza fondata non soltanto sulle nostre qualità e abilità, ma sulla Parola di Dio, sull’invito che viene da Lui. Senza fare troppi calcoli umani e non preoccuparsi di verificare se la realtà che vi circonda coincide con le vostre sicurezze. Prendete il largo, uscite da voi stessi».[77]
142. Dobbiamo perseverare sulla strada dei sogni. Per questo, bisogna stare attenti a una tentazione che spesso ci fa brutti scherzi: l’ansia. Può diventare una grande nemica quando ci porta ad arrenderci perché scopriamo che i risultati non sono immediati. I sogni più belli si conquistano con speranza, pazienza e impegno, rinunciando alla fretta. Nello stesso tempo, non bisogna bloccarsi per insicurezza, non bisogna avere paura di rischiare e di commettere errori. Piuttosto dobbiamo avere paura di vivere paralizzati, come morti viventi, ridotti a soggetti che non vivono perché non vogliono rischiare, perché non portano avanti i loro impegni o hanno paura di sbagliare. Anche se sbagli, potrai sempre rialzare la testa e ricominciare, perché nessuno ha il diritto di rubarti la speranza.
143. Giovani, non rinunciate al meglio della vostra giovinezza, non osservate la vita dal balcone. Non confondete la felicità con un divano e non passate tutta la vostra vita davanti a uno schermo. Non riducetevi nemmeno al triste spettacolo di un veicolo abbandonato. Non siate auto parcheggiate, lasciate piuttosto sbocciare i sogni e prendete decisioni. Rischiate, anche se sbaglierete. Non sopravvivete con l’anima anestetizzata e non guardate il mondo come se foste turisti. Fatevi sentire! Scacciate le paure che vi paralizzano, per non diventare giovani mummificati. Vivete! Datevi al meglio della vita! Aprite le porte della gabbia e volate via! Per favore, non andate in pensione prima del tempo.
La voglia di vivere e di sperimentare
144. Questa proiezione verso il futuro che si sogna, non significa che i giovani siano completamente proiettati in avanti, perché allo stesso tempo c’è in loro un forte desiderio di vivere il presente, di sfruttare al massimo le possibilità che questa vita dona loro. Questo mondo è pieno di bellezza! Come possiamo disprezzare i doni di Dio?
145. Contrariamente a quanto molti pensano, il Signore non vuole indebolire questa voglia di vivere. Fa bene ricordare ciò che insegnava un sapiente dell’Antico Testamento: «Figlio, per quanto ti è possibile, trattati bene […]. Non privarti di un giorno felice» (Sir 14,11.14). Il vero Dio, quello che ti ama, ti vuole felice. Ecco perché nella Bibbia troviamo anche questo consiglio rivolto ai giovani: «Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. […] Caccia la malinconia dal tuo cuore» (Qo 11,9-10). Perché è Dio che «tutto ci dà con abbondanza perché possiamo goderne» (1 Tm 6,17).
146. Come potrà essere grato a Dio chi non è capace di godere dei suoi piccoli regali di ogni giorno, chi non sa soffermarsi davanti alle cose semplici e piacevoli che incontra ad ogni passo? Perché «nessuno è peggiore di chi danneggia se stesso» (Sir 14,6). Non si tratta di essere insaziabili, sempre ossessionati da piaceri senza fine. Al contrario, perché questo ti impedirà di vivere il presente. Si tratta di saper aprire gli occhi e soffermarti per vivere pienamente e con gratitudine ogni piccolo dono della vita.
147. È chiaro che la Parola di Dio ti invita a vivere il presente, non solo a preparare il domani: «Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena» (Mt 6,34). Questo però non significa lanciarsi in una dissolutezza irresponsabile che ci lascia vuoti e sempre insoddisfatti, bensì vivere pienamente il presente, usando le energie per cose buone, coltivando la fraternità, seguendo Gesù e apprezzando ogni piccola gioia della vita come un dono dell’amore di Dio.
148. A questo proposito, vorrei ricordare che il Cardinale Francesco Saverio Nguyên Van Thuân, quando fu imprigionato in un campo di concentramento, non volle che i suoi giorni consistessero soltanto nell’attendere e sperare un futuro. Scelse di «vivere il momento presente riempiendolo d’amore»; e il modo in cui lo realizzava era questo: «Afferro le occasioni che si presentano ogni giorno, per compiere azioni ordinarie in un modo straordinario».[78] Mentre lotti per realizzare i tuoi sogni, vivi pienamente l’oggi, donalo interamente e riempi d’amore ogni momento. Perché è vero che questo giorno della tua giovinezza può essere l’ultimo, e allora vale la pena di viverlo con tutto il desiderio e con tutta la profondità possibili.
149. Questo vale anche per i momenti difficili, che devono essere vissuti a fondo per riuscire a imparare il loro messaggio. Come insegnano i Vescovi svizzeri: «Egli è lì dove noi pensavamo che ci avesse abbandonato e che non ci fosse più alcuna possibilità di salvezza. È un paradosso, ma la sofferenza, le tenebre, sono diventate, per molti cristiani […] luoghi di incontro con Dio».[79] Inoltre, il desiderio di vivere e di fare esperienze nuove riguarda specialmente molti giovani in condizione di disabilità fisica, psichica e sensoriale. Essi, anche se non possono fare sempre le stesse esperienze dei coetanei, hanno risorse sorprendenti, inimmaginabili, che talvolta superano quelle comuni. Il Signore Gesù li ricolma di altri doni, che la comunità è chiamata a valorizzare, perché possano scoprire il suo progetto d’amore per ciascuno di loro.
In amicizia con Cristo
150. Per quanto tu possa vivere e fare esperienze, non arriverai al fondo della giovinezza, non conoscerai la vera pienezza dell’essere giovane, se non incontri ogni giorno il grande Amico, se non vivi in amicizia con Gesù.
151. L’amicizia è un regalo della vita e un dono di Dio. Attraverso gli amici, il Signore ci purifica e ci fa maturare. Allo stesso tempo, gli amici fedeli, che sono al nostro fianco nei momenti difficili, sono un riflesso dell’affetto del Signore, della sua consolazione e della sua presenza amorevole. Avere amici ci insegna ad aprirci, a capire, a prenderci cura degli altri, a uscire dalla nostra comodità e dall’isolamento, a condividere la vita. Ecco perché «per un amico fedele non c’è prezzo» (Sir 6,15).
152. L’amicizia non è una relazione fugace e passeggera, ma stabile, salda, fedele, che matura col passare del tempo. È un rapporto di affetto che ci fa sentire uniti, e nello stesso tempo è un amore generoso che ci porta a cercare il bene dell’amico. Anche se gli amici possono essere molto diversi tra loro, ci sono sempre alcune cose in comune che li portano a sentirsi vicini, c’è un’intimità che si condivide con sincerità e fiducia.
153. L’amicizia è così importante che Gesù stesso si presenta come amico: «Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici» (Gv 15,15). Per la grazia che Egli ci dona, siamo elevati in modo tale che siamo veramente suoi amici. Con lo stesso amore che Egli riversa in noi, possiamo amarlo, estendendo il suo amore agli altri, nella speranza che anch’essi troveranno il loro posto nella comunità di amicizia fondata da Gesù Cristo.[80] E sebbene Egli sia già pienamente felice da risorto, è possibile essere generosi con Lui, aiutandolo a costruire il suo Regno in questo mondo, essendo suoi strumenti per portare il suo messaggio, la sua luce e soprattutto il suo amore agli altri (cfr Gv 15,16). I discepoli hanno ascoltato la chiamata di Gesù all’amicizia con Lui. È stato un invito che non li ha costretti, ma si è proposto delicatamente alla loro libertà: «Venite e vedrete», disse loro, ed essi «andarono e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui» (Gv 1,39). Dopo quell’incontro, intimo e inaspettato, lasciarono tutto e andarono con Lui.
154. L’amicizia con Gesù è indissolubile. Egli non ci abbandona mai, anche se a volte sembra stare in silenzio. Quando abbiamo bisogno di Lui, si lascia trovare da noi (cfr Ger 29,14) e sta al nostro fianco dovunque andiamo (cfr Gs 1,9). Perché Egli non rompe mai un’alleanza. A noi chiede di non abbandonarlo: «Rimanete in me e io in voi» (Gv 15,4). Ma se ci allontaniamo, «Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso» (2 Tm 2,13).
155. Con l’amico parliamo, condividiamo le cose più segrete. Con Gesù pure conversiamo. La preghiera è una sfida e un’avventura. E che avventura! Ci permette di conoscerlo sempre meglio, di entrare nel suo profondo e di crescere in un’unione sempre più forte. La preghiera ci permette di raccontargli tutto ciò che ci accade e di stare fiduciosi tra le sue braccia, e nello stesso tempo ci regala momenti di preziosa intimità e affetto, nei quali Gesù riversa in noi la sua vita. Pregando «facciamo il suo gioco», gli facciamo spazio «perché Egli possa agire e possa entrare e possa vincere».[81]
156. Così è possibile arrivare a sperimentare un’unità costante con Lui, che supera tutto ciò che possiamo vivere con altre persone: «Non vivo più io, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20). Non privare la tua giovinezza di questa amicizia. Potrai sentirlo al tuo fianco non solo quando preghi. Riconoscerai che cammina con te in ogni momento. Cerca di scoprirlo e vivrai la bella esperienza di saperti sempre accompagnato. È quello che hanno vissuto i discepoli di Emmaus quando, mentre camminavano e conversavano disorientati, Gesù si fece presente e «camminava con loro» (Lc 24,15). Un santo diceva che «il cristianesimo non è un insieme di verità in cui occorre credere, di leggi da osservare, di divieti. Così risulta ripugnante. Il cristianesimo è una Persona che mi ha amato così tanto da reclamare il mio amore. Il cristianesimo è Cristo».[82]
157. Gesù può unire tutti i giovani della Chiesa in un unico sogno, «un sogno grande e un sogno capace di coinvolgere tutti. Il sogno per il quale Gesù ha dato la vita sulla croce e lo Spirito Santo si è riversato e ha marchiato a fuoco il giorno di Pentecoste nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, nel cuore di ciascuno, […] lo ha impresso nella speranza che trovi spazio per crescere e svilupparsi. Un sogno, un sogno chiamato Gesù, seminato dal Padre: Dio come Lui, come il Padre, inviato dal Padre con la fiducia che crescerà e vivrà in ogni cuore. Un sogno concreto, che è una Persona, che scorre nelle nostre vene, fa trasalire il cuore e lo fa sussultare».[83]
La crescita e la maturazione
158. Molti giovani si preoccupano del proprio corpo, cercando di sviluppare la forza fisica o l’aspetto. Altri si danno da fare per potenziare le loro capacità e conoscenze, e in questo modo si sentono più sicuri. Alcuni puntano più in alto, si sforzano di impegnarsi di più e cercano uno sviluppo spirituale. San Giovanni diceva: «Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti, e la Parola di Dio rimane in voi» (1 Gv 2,14). Cercare il Signore, custodire la sua Parola, cercare di rispondere ad essa con la propria vita, crescere nelle virtù, questo rende forti i cuori dei giovani. Per questo occorre mantenere la “connessione” con Gesù, essere “in linea” con Lui, perché non crescerai nella felicità e nella santità solo con le tue forze e la tua mente. Così come ti preoccupi di non perdere la connessione a Internet, assicurati che sia attiva la tua connessione con il Signore, e questo significa non interrompere il dialogo, ascoltarlo, raccontargli le tue cose, e quando non hai le idee chiare su cosa dovresti fare, domandagli: «Gesù, cosa faresti Tu al mio posto?».[84]
159. Spero che tu possa stimare così tanto te stesso, prenderti così sul serio, da cercare la tua crescita spirituale. Oltre all’entusiasmo tipico della giovinezza, c’è anche la bellezza di cercare «la giustizia, la fede, la carità, la pace» (2 Tm 2,22). Questo non significa perdere la spontaneità, la freschezza, l’entusiasmo, la tenerezza. Perché diventare adulti non significa abbandonare i migliori valori di questa fase della vita. Altrimenti, il Signore potrebbe rimproverarti un giorno: «Mi ricordo di te, dell’affetto della tua giovinezza, dell’amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto» (Ger 2,2).
160. D’altra parte, anche un adulto deve maturare senza perdere i valori della gioventù. Perché in realtà ogni fase della vita è una grazia permanente, contiene un valore che non deve passare. Una giovinezza vissuta bene rimane come esperienza interiore, e nella vita adulta viene assimilata, viene approfondita e continua a dare i suoi frutti. Se è tipico del giovane sentirsi attratto dall’infinito che si apre e che comincia,[85] un rischio della vita adulta, con le sue sicurezze e comodità, consiste nel trascurare sempre più questo orizzonte e perdere quel valore proprio degli anni della gioventù. Invece dovrebbe accadere il contrario: maturare, crescere e organizzare la propria vita senza perdere quell’attrazione, quell’apertura ampia, quel fascino per una realtà che è sempre qualcosa di più. In ogni momento della vita potremo rinnovare e accrescere la nostra giovinezza. Quando ho iniziato il mio ministero come Papa, il Signore ha allargato i miei orizzonti e mi ha dato una rinnovata giovinezza. La stessa cosa può accadere a una coppia sposata da molti anni, o a un monaco nel suo monastero. Ci sono cose che hanno bisogno di sedimentarsi negli anni, ma questa maturazione può convivere con un fuoco che si rinnova, con un cuore sempre giovane.
161. Crescere vuol dire conservare e alimentare le cose più preziose che ti regala la giovinezza, ma nello stesso tempo significa essere aperti a purificare ciò che non è buono e a ricevere nuovi doni da Dio che ti chiama a sviluppare ciò che vale. A volte, i complessi di inferiorità possono portarti a non voler vedere i tuoi difetti e le tue debolezze, e in questo modo puoi chiuderti alla crescita e alla maturazione. Lasciati piuttosto amare da Dio, che ti ama così come sei, ti apprezza e ti rispetta, ma ti offre anche sempre di più: più amicizia con Lui, più fervore nella preghiera, più sete della sua Parola, più desiderio di ricevere Cristo nell’Eucaristia, più voglia di vivere il suo Vangelo, più forza interiore, più pace e gioia spirituale.
162. Ti ricordo però che non sarai santo e realizzato copiando gli altri. E nemmeno imitare i santi significa copiare il loro modo di essere e di vivere la santità: «Ci sono testimonianze che sono utili per stimolarci e motivarci, ma non perché cerchiamo di copiarle, in quanto ciò potrebbe perfino allontanarci dalla via unica e specifica che il Signore ha in serbo per noi».[86] Tu devi scoprire chi sei e sviluppare il tuo modo personale di essere santo, indipendentemente da ciò che dicono e pensano gli altri. Diventare santo vuol dire diventare più pienamente te stesso, quello che Dio ha voluto sognare e creare, non una fotocopia. La tua vita dev’essere uno stimolo profetico, che sia d’ispirazione ad altri, che lasci un’impronta in questo mondo, quell’impronta unica che solo tu potrai lasciare. Invece, se copi, priverai questa terra, e anche il cielo, di ciò che nessun altro potrà offrire al tuo posto. Ricordo che San Giovanni della Croce, nel suo Cantico Spirituale, scriveva che ognuno doveva approfittare dei suoi consigli spirituali «a modo proprio»,[87] perché Dio stesso ha voluto manifestare la sua grazia «ad alcuni in un modo e ad altri in un altro».[88]
Percorsi di fraternità
163. La tua crescita spirituale si esprime soprattutto nell’amore fraterno, generoso, misericordioso. Lo diceva San Paolo: «Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi» (1 Ts 3,12). Che tu possa vivere sempre più quella “estasi” che consiste nell’uscire da te stesso per cercare il bene degli altri, fino a dare la vita.
164. Quando un incontro con Dio si chiama “estasi”, è perché ci tira fuori da noi stessi e ci eleva, catturati dall’amore e dalla bellezza di Dio. Ma possiamo anche essere fatti uscire da noi stessi per riconoscere la bellezza nascosta in ogni essere umano, la sua dignità, la sua grandezza come immagine di Dio e figlio del Padre. Lo Spirito Santo vuole spingerci ad uscire da noi stessi, ad abbracciare gli altri con l’amore e cercare il loro bene. Per questo è sempre meglio vivere la fede insieme ed esprimere il nostro amore in una vita comunitaria, condividendo con altri giovani il nostro affetto, il nostro tempo, la nostra fede e le nostre inquietudini. La Chiesa offre molti e diversi spazi per vivere la fede in comunità, perché insieme tutto è più facile.
165. Le ferite ricevute possono condurti alla tentazione dell’isolamento, a ripiegarti su te stesso, ad accumulare rancori, ma non smettere mai di ascoltare la chiamata di Dio al perdono. Come hanno insegnato bene i Vescovi del Ruanda, «la riconciliazione con l’altro chiede prima di tutto di scoprire in lui lo splendore dell’immagine di Dio. […] In quest’ottica, è vitale distinguere il peccatore dal suo peccato e dalla sua offesa, per arrivare all’autentica riconciliazione. Questo significa che odi il male che l’altro ti infligge, ma continui ad amarlo perché riconosci la sua debolezza e vedi l’immagine di Dio in lui».[89]
166. A volte tutta l’energia, i sogni e l’entusiasmo della giovinezza si affievoliscono per la tentazione di chiuderci in noi stessi, nei nostri problemi, nei sentimenti feriti, nelle lamentele e nelle comodità. Non lasciare che questo ti accada, perché diventerai vecchio dentro e prima del tempo. Ogni età ha la sua bellezza, e alla giovinezza non possono mancare l’utopia comunitaria, la capacità di sognare insieme, i grandi orizzonti che guardiamo insieme.
167. Dio ama la gioia dei giovani e li invita soprattutto a quell’allegria che si vive nella comunione fraterna, a quel godimento superiore di chi sa condividere, perché «c’è più gioia nel dare che nel ricevere» (At 20,35) e «Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7). L’amore fraterno moltiplica la nostra capacità di gioire, perché ci rende capaci di godere del bene degli altri: «Rallegratevi con quelli che sono nella gioia» (Rm 12,15). Che la spontaneità e l’impulso della tua giovinezza si trasformino sempre più nella spontaneità dell’amore fraterno, nella freschezza che ci fa reagire sempre con il perdono, con la generosità, con il desiderio di fare comunità. Un proverbio africano dice: «Se vuoi andare veloce, cammina da solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina con gli altri». Non lasciamoci rubare la fraternità.
Giovani impegnati
168. In effetti, di fronte ad una realtà così piena di violenza e di egoismo, i giovani possono a volte correre il rischio di chiudersi in piccoli gruppi, privandosi così delle sfide della vita in società, di un mondo vasto, stimolante e con tanti bisogni. Sentono di vivere l’amore fraterno, ma forse il loro gruppo è diventato un semplice prolungamento del loro io. Questo si aggrava se la vocazione del laico è concepita solo come un servizio all’interno della Chiesa (lettori, accoliti, catechisti,…), dimenticando che la vocazione laicale è prima di tutto la carità nella famiglia e la carità sociale o politica: è un impegno concreto a partire dalla fede per la costruzione di una società nuova, è vivere in mezzo al mondo e alla società per evangelizzarne le sue diverse istanze, per far crescere la pace, la convivenza, la giustizia, i diritti umani, la misericordia, e così estendere il Regno di Dio nel mondo.
169. Propongo ai giovani di andare oltre i gruppi di amici e costruire l’«amicizia sociale, cercare il bene comune. L’inimicizia sociale distrugge. E una famiglia si distrugge per l’inimicizia. Un paese si distrugge per l’inimicizia. Il mondo si distrugge per l’inimicizia. E l’inimicizia più grande è la guerra. Oggigiorno vediamo che il mondo si sta distruggendo per la guerra. Perché sono incapaci di sedersi e parlare. […] Siate capaci di creare l’amicizia sociale».[90] Non è facile, occorre sempre rinunciare a qualcosa, occorre negoziare, ma se lo facciamo pensando al bene di tutti potremo realizzare la magnifica esperienza di mettere da parte le differenze per lottare insieme per uno scopo comune. Se riusciamo a trovare dei punti di coincidenza in mezzo a tante divergenze, in questo impegno artigianale e a volte faticoso di gettare ponti, di costruire una pace che sia buona per tutti, questo è il miracolo della cultura dell’incontro che i giovani possono avere il coraggio di vivere con passione.
170. Il Sinodo ha riconosciuto che «anche se in forma differente rispetto alle generazioni passate, l’impegno sociale è un tratto specifico dei giovani d’oggi. A fianco di alcuni indifferenti, ve ne sono molti altri disponibili a impegnarsi in iniziative di volontariato, cittadinanza attiva e solidarietà sociale, da accompagnare e incoraggiare per far emergere i talenti, le competenze e la creatività dei giovani e incentivare l’assunzione di responsabilità da parte loro. L’impegno sociale e il contatto diretto con i poveri restano una occasione fondamentale di scoperta o approfondimento della fede e di discernimento della propria vocazione. […] È stata segnalata anche la disponibilità all’impegno in campo politico per la costruzione del bene comune».[91]
171. Oggi, grazie a Dio, i gruppi di giovani di parrocchie, scuole, movimenti o gruppi universitari hanno l’abitudine di andare a fare compagnia agli anziani e agli ammalati, o di visitare quartieri poveri, oppure vanno insieme ad aiutare gli indigenti nelle cosiddette “notti della carità”. Spesso riconoscono che in queste attività quello che ricevono è più di quello che danno, perché si impara e si matura molto quando si ha il coraggio di entrare in contatto con la sofferenza degli altri. Inoltre, nei poveri c’è una saggezza nascosta, ed essi, con parole semplici, possono aiutarci a scoprire valori che non vediamo.
172. Altri giovani partecipano a programmi sociali finalizzati a costruire case per chi è senza un tetto, o a bonificare aree contaminate, o a raccogliere aiuti per i più bisognosi. Sarebbe bene che questa energia comunitaria fosse applicata non solo ad azioni sporadiche ma in modo stabile, con obiettivi chiari e una buona organizzazione che aiuti a realizzare un’attività più continuativa ed efficiente. Gli universitari possono unirsi in modalità interdisciplinare per applicare le loro conoscenze alla risoluzione di problemi sociali, e in questo compito possono lavorare fianco a fianco con giovani di altre Chiese o di altre religioni.
173. Come nel miracolo di Gesù, i pani e i pesci dei giovani possono moltiplicarsi (cfr Gv 6,4-13). Come avviene nella parabola, i piccoli semi dei giovani diventano alberi e frutti da raccogliere (cfr Mt 13,23.31-32). Tutto questo a partire dalla sorgente viva dell’Eucaristia, in cui il nostro pane e il nostro vino sono trasfigurati per darci la Vita eterna. Ai giovani è affidato un compito immenso e difficile. Con la fede nel Risorto, potranno affrontarlo con creatività e speranza, ponendosi sempre nella posizione del servizio, come i servitori di quella festa nuziale, stupefatti collaboratori del primo segno di Gesù, che seguirono soltanto la consegna di sua Madre: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» (Gv 2,5). Misericordia, creatività e speranza fanno crescere la vita.
174. Voglio incoraggiarti ad assumere questo impegno, perché so che «il tuo cuore, cuore giovane, vuole costruire un mondo migliore. Seguo le notizie del mondo e vedo che tanti giovani in tante parti del mondo sono usciti per le strade per esprimere il desiderio di una civiltà più giusta e fraterna. I giovani nelle strade. Sono giovani che vogliono essere protagonisti del cambiamento. Per favore, non lasciate che altri siano protagonisti del cambiamento! Voi siete quelli che hanno il futuro! Attraverso di voi entra il futuro nel mondo. A voi chiedo anche di essere protagonisti di questo cambiamento. Continuate a superare l’apatia, offrendo una risposta cristiana alle inquietudini sociali e politiche, che si stanno presentando in varie parti del mondo. Vi chiedo di essere costruttori del mondo, di mettervi al lavoro per un mondo migliore. Cari giovani, per favore, non guardate la vita “dal balcone”, ponetevi dentro di essa. Gesù non è rimasto sul balcone, si è messo dentro; non guardate la vita “dal balcone”, entrate in essa come ha fatto Gesù».[92] Ma soprattutto, in un modo o nell’altro, lottate per il bene comune, siate servitori dei poveri, siate protagonisti della rivoluzione della carità e del servizio, capaci di resistere alle patologie dell’individualismo consumista e superficiale.
Missionari coraggiosi
175. Innamorati di Cristo, i giovani sono chiamati a testimoniare il Vangelo ovunque con la propria vita. Sant’Alberto Hurtado diceva che «essere apostoli non significa portare un distintivo all’occhiello della giacca; non significa parlare della verità, ma viverla, incarnarsi in essa, trasformarsi in Cristo. Essere apostolo non consiste nel portare una torcia in mano, nel possedere la luce, ma nell’essere la luce […]. Il Vangelo, […] più che una lezione è un esempio. Il messaggio trasformato in vita vissuta».[93]
176. Il valore della testimonianza non significa che la parola debba essere messa a tacere. Perché non parlare di Gesù, perché non raccontare agli altri che Lui ci dà la forza di vivere, che è bello conversare con Lui, che ci fa bene meditare le sue parole? Giovani, non lasciate che il mondo vi trascini a condividere solo le cose negative o superficiali. Siate capaci di andare controcorrente e sappiate condividere Gesù, comunicate la fede che Lui vi ha donato. Vi auguro di sentire nel cuore lo stesso impulso irresistibile che muoveva San Paolo quando affermava: «Guai a me se non annuncio il Vangelo!» (1 Cor 9,16).
177. «Dove ci invia Gesù? Non ci sono confini, non ci sono limiti: ci invia a tutti. Il Vangelo è per tutti e non per alcuni. Non è solo per quelli che ci sembrano più vicini, più ricettivi, più accoglienti. È per tutti. Non abbiate paura di andare e portare Cristo in ogni ambiente, fino alle periferie esistenziali, anche a chi sembra più lontano, più indifferente. Il Signore cerca tutti, vuole che tutti sentano il calore della sua misericordia e del suo amore».[94] E ci invita ad andare senza paura con l’annuncio missionario, dovunque ci troviamo e con chiunque siamo, nel quartiere, nello studio, nello sport, quando usciamo con gli amici, facendo volontariato o al lavoro, è sempre bene e opportuno condividere la gioia del Vangelo. Questo è il modo in cui il Signore si avvicina a tutti. E vuole voi, giovani, come suoi strumenti per irradiare luce e speranza, perché vuole contare sul vostro coraggio, sulla vostra freschezza e sul vostro entusiasmo.
178. Non ci si può aspettare che la missione sia facile e comoda. Alcuni giovani hanno dato la vita pur di non frenare il loro impulso missionario. I Vescovi della Corea si sono espressi così: «Speriamo di poter essere chicchi di grano e strumenti per la salvezza dell’umanità, seguendo l’esempio dei martiri. Anche se la nostra fede è piccola come un granello di senape, Dio la farà crescere e la utilizzerà come strumento per la sua opera di salvezza».[95] Amici, non aspettate fino a domani per collaborare alla trasformazione del mondo con la vostra energia, la vostra audacia e la vostra creatività. La vostra vita non è un “nel frattempo”. Voi siete l’adesso di Dio, che vi vuole fecondi.[96] Perché «è dando che si riceve»[97] e il modo migliore di preparare un buon futuro è vivere bene il presente con dedizione e generosità.
CAPITOLO SESTO
Giovani con radici
179. A volte ho visto alberi giovani, belli, che alzavano i loro rami verso il cielo tendendo sempre più in alto, e sembravano un canto di speranza. Successivamente, dopo una tempesta, li ho trovati caduti, senza vita. Poiché avevano poche radici, avevano disteso i loro rami senza mettere radici profonde nel terreno, e così hanno ceduto agli assalti della natura. Per questo mi fa male vedere che alcuni propongono ai giovani di costruire un futuro senza radici, come se il mondo iniziasse adesso. Perché «è impossibile che uno cresca se non ha radici forti che aiutino a stare bene in piedi e attaccato alla terra. È facile “volare via” quando non si ha dove attaccarsi, dove fissarsi».[98]
Che non ti strappino dalla terra
180. Tale questione non è secondaria, e mi sembra opportuno dedicarvi un breve capitolo. Comprenderla permette di distinguere la gioia della giovinezza da un falso culto di essa, che alcuni utilizzano per sedurre i giovani e usarli per i loro fini.
181. Pensate a questo: se una persona vi fa una proposta e vi dice di ignorare la storia, di non fare tesoro dell’esperienza degli anziani, di disprezzare tutto ciò che è passato e guardare solo al futuro che lui vi offre, non è forse questo un modo facile di attirarvi con la sua proposta per farvi fare solo quello che lui vi dice? Quella persona ha bisogno che siate vuoti, sradicati, diffidenti di tutto, perché possiate fidarvi solo delle sue promesse e sottomettervi ai suoi piani. È così che funzionano le ideologie di diversi colori, che distruggono (o de-costruiscono) tutto ciò che è diverso e in questo modo possono dominare senza opposizioni. A tale scopo hanno bisogno di giovani che disprezzino la storia, che rifiutino la ricchezza spirituale e umana che è stata tramandata attraverso le generazioni, che ignorino tutto ciò che li ha preceduti.
182. Allo stesso tempo, i manipolatori usano un’altra risorsa: un’adorazione della giovinezza, come se tutto ciò che non è giovane risultasse detestabile e caduco. Il corpo giovane diventa il simbolo di questo nuovo culto, quindi tutto ciò che ha a che fare con quel corpo è idolatrato e desiderato senza limiti, e ciò che non è giovane è guardato con disprezzo. Questa però è un’arma che finisce per degradare prima di tutto i giovani, svuotandoli di valori reali, usandoli per ottenere vantaggi personali, economici o politici.
183. Cari giovani, non permettete che usino la vostra giovinezza per favorire una vita superficiale, che confonde la bellezza con l’apparenza. Sappiate invece scoprire che c’è una bellezza nel lavoratore che torna a casa sporco e in disordine, ma con la gioia di aver guadagnato il pane per i suoi figli. C’è una bellezza straordinaria nella comunione della famiglia riunita intorno alla tavola e nel pane condiviso con generosità, anche se la mensa è molto povera. C’è una bellezza nella moglie spettinata e un po’ anziana che continua a prendersi cura del marito malato al di là delle proprie forze e della propria salute. Malgrado sia lontana la primavera del corteggiamento, c’è una bellezza nella fedeltà delle coppie che si amano nell’autunno della vita e in quei vecchietti che camminano tenendosi per mano. C’è una bellezza che va al di là dell’apparenza o dell’estetica di moda in ogni uomo e ogni donna che vivono con amore la loro vocazione personale, nel servizio disinteressato per la comunità, per la patria, nel lavoro generoso per la felicità della famiglia, impegnati nell’arduo lavoro anonimo e gratuito di ripristinare l’amicizia sociale. Scoprire, mostrare e mettere in risalto questa bellezza, che ricorda quella di Cristo sulla croce, significa mettere le basi della vera solidarietà sociale e della cultura dell’incontro.
184. Insieme alle strategie del falso culto della giovinezza e dell’apparenza, oggi si promuove una spiritualità senza Dio, un’affettività senza comunità e senza impegno verso chi soffre, una paura dei poveri visti come soggetti pericolosi, e una serie di offerte che pretendono di farvi credere in un futuro paradisiaco che sarà sempre rimandato più in là. Non voglio proporvi questo, e con tutto il mio affetto voglio mettervi in guardia dal lasciarvi dominare da questa ideologia che non vi renderà più giovani ma vi trasformerà in schiavi. Vi propongo un’altra strada, fatta di libertà, di entusiasmo, di creatività, di orizzonti nuovi, ma coltivando nello stesso tempo le radici che alimentano e sostengono.
185. In questa prospettiva, voglio sottolineare che «molti Padri sinodali provenienti da contesti non occidentali segnalano come nei loro Paesi la globalizzazione rechi con sé autentiche forme di colonizzazione culturale, che sradicano i giovani dalle appartenenze culturali e religiose da cui provengono. È necessario un impegno della Chiesa per accompagnarli in questo passaggio senza che smarriscano i tratti più preziosi della propria identità».[99]
186. Oggi assistiamo a una tendenza ad “omogeneizzare” i giovani, a dissolvere le differenze proprie del loro luogo di origine, a trasformarli in soggetti manipolabili fatti in serie. Così si produce una distruzione culturale, che è tanto grave quanto l’estinzione delle specie animali e vegetali.[100] Per questo, in un messaggio ai giovani indigeni riuniti a Panama, li ho esortati a «farsi carico delle radici, perché dalle radici viene la forza che vi farà crescere, fiorire e fruttificare».[101]
Il tuo rapporto con gli anziani
187. Al Sinodo è stato affermato che «i giovani sono proiettati verso il futuro e affrontano la vita con energia e dinamismo. Però […] talora tendono a dare poca attenzione alla memoria del passato da cui provengono, in particolare dei tanti doni loro trasmessi dai genitori, dai nonni, dal bagaglio culturale della società in cui vivono. Aiutare i giovani a scoprire la ricchezza viva del passato, facendone memoria e servendosene per le proprie scelte e possibilità, è un vero atto di amore nei loro confronti in vista della loro crescita e delle scelte che sono chiamati a compiere».[102]
188. La Parola di Dio raccomanda di non perdere il contatto con gli anziani, per poter raccogliere la loro esperienza: «Frequenta le riunioni degli anziani, e se qualcuno è saggio unisciti a lui. […] Se vedi una persona saggia, va’ di buon mattino da lei, i tuoi piedi logorino i gradini della sua porta» (Sir 6,34.36). In ogni caso, i lunghi anni che essi hanno vissuto e tutto ciò che è loro capitato nella vita devono portarci a guardarli con rispetto: «Alzati davanti a chi ha i capelli bianchi» (Lv 19,32), perché «vanto dei giovani è la loro forza, ornamento dei vecchi è la canizie» (Pr 20,29).
189. La Bibbia ci chiede: «Ascolta tuo padre che ti ha generato, non disprezzare tua madre quando è vecchia» (Pr 23,22). Il comandamento di onorare il padre e la madre «è il primo comandamento che è accompagnato da una promessa» (Ef 6,2; cfr Es 20,12; Dt 5,16; Lv 19,3), e la promessa è: «perché tu sia felice e goda di una lunga vita sulla terra» (Ef 6,3).
190. Questo non significa che tu debba essere d’accordo con tutto quello che dicono, né che tu debba approvare tutte le loro azioni. Un giovane dovrebbe avere sempre uno spirito critico. San Basilio Magno, riferendosi agli antichi autori greci, raccomandava ai giovani di stimarli, ma di accogliere solo ciò che di buono essi possono insegnare.[103] Si tratta semplicemente di essere aperti a raccogliere una sapienza che viene comunicata di generazione in generazione, che può convivere con alcune miserie umane, e che non ha motivo di scomparire davanti alle novità del consumo e del mercato.
191. Al mondo non è mai servita né servirà mai la rottura tra generazioni. Sono i canti di sirena di un futuro senza radici, senza radicamento. È la menzogna che vuol farti credere che solo ciò che è nuovo è buono e bello. L’esistenza delle relazioni intergenerazionali implica che nelle comunità si possieda una memoria collettiva, poiché ogni generazione riprende gli insegnamenti dei predecessori, lasciando così un’eredità ai successori. Questo costituisce dei quadri di riferimento per cementare saldamente una società nuova. Come dice l’adagio: “Se il giovane sapesse e il vecchio potesse, non vi sarebbe cosa che non si farebbe”.
Sogni e visioni
192. Nella profezia di Gioele troviamo un annuncio che ci permette di capire questo in un modo molto bello. Dice così: «Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni» (Gl 3,1; cfr At 2,17). Se i giovani e gli anziani si aprono allo Spirito Santo, insieme producono una combinazione meravigliosa. Gli anziani sognano e i giovani hanno visioni. In che modo le due cose si completano a vicenda?
193. Gli anziani hanno sogni intessuti di ricordi, delle immagini di tante cose vissute, segnati dall’esperienza e dagli anni. Se i giovani si radicano nei sogni degli anziani riescono a vedere il futuro, possono avere visioni che aprono loro l’orizzonte e mostrano loro nuovi cammini. Ma se gli anziani non sognano, i giovani non possono più vedere chiaramente l’orizzonte.
194. È bello trovare, tra le cose che i nostri genitori hanno conservato, qualche ricordo che ci permette di immaginare ciò che hanno sognato per noi i nostri nonni e le nostre nonne. Ogni essere umano, prima ancora di nascere, ha ricevuto dai suoi nonni, come regalo, la benedizione di un sogno pieno d’amore e di speranza: quello di una vita migliore. E se non l’avesse avuto da alcuno dei suoi nonni, sicuramente un bisnonno lo ha sognato e ha gioito per lui, contemplando nella culla i suoi figli e poi i suoi nipoti. Il sogno primordiale, il sogno creatore di Dio nostro Padre, precede e accompagna la vita di tutti i suoi figli. Fare memoria di questa benedizione, che si estende di generazione in generazione, è una preziosa eredità che dobbiamo saper mantenere viva per poterla trasmettere a nostra volta.
195. Per questo è bene lasciare che gli anziani facciano lunghe narrazioni, che a volte sembrano mitologiche, fantasiose – sono sogni di anziani – ma molte volte sono piene di preziosa esperienza, di simboli eloquenti, di messaggi nascosti. Queste narrazioni richiedono tempo, e che ci disponiamo gratuitamente ad ascoltare e interpretare con pazienza, perché non entrano in un messaggio delle reti sociali. Dobbiamo accettare che tutta la saggezza di cui abbiamo bisogno per la vita non può essere racchiusa entro i limiti imposti dalle attuali risorse della comunicazione.
196. Nel libro La saggezza del tempo[104] ho espresso alcuni desideri sotto forma di richieste. «Che cosa chiedo agli anziani, tra i quali annovero anche me stesso? Chiedo che siamo custodi della memoria. Noi nonni e nonne abbiamo bisogno di formare un coro. Immagino gli anziani come il coro permanente di un importante santuario spirituale, in cui le preghiere di supplica e i canti di lode sostengono l’intera comunità che lavora e lotta nel campo della vita».[105] È bello che «i giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini, lodino il nome del Signore» (Sal 148,12-13).
197. Che cosa possiamo dare ai giovani noi anziani? «Ai giovani di oggi che vivono la loro miscela di ambizioni eroiche e di insicurezze, possiamo ricordare che una vita senza amore è una vita sterile».[106] Cosa possiamo dire loro? «Ai giovani timorosi possiamo dire che l’ansia per il futuro può essere superata».[107] Cosa possiamo insegnare loro? «Ai giovani eccessivamente preoccupati di sé stessi possiamo insegnare che si sperimenta una gioia più grande nel dare che nel ricevere, e che l’amore non si dimostra solo con le parole, ma anche con le opere».[108]
Rischiare insieme
198. L’amore che si dà e che opera, tante volte sbaglia. Colui che agisce, che rischia, spesso commette errori. A questo proposito, può risultare interessante la testimonianza di Maria Gabriela Perin, orfana di padre dalla nascita, che riflette sul modo in cui questo ha influenzato la sua vita, in una relazione che non è durata ma che ha fatto di lei una madre e ora una nonna: «Quello che so è che Dio crea storie. Nel suo genio e nella sua misericordia, Egli prende i nostri trionfi e fallimenti e tesse bellissimi arazzi pieni di ironia. Il rovescio del tessuto può sembrare disordinato con i suoi fili aggrovigliati – gli avvenimenti della nostra vita – e forse è quel lato che non ci lascia in pace quando abbiamo dei dubbi. Tuttavia, il lato buono dell’arazzo mostra una storia magnifica, e questo è il lato che vede Dio».[109] Quando le persone anziane guardano con attenzione la vita, spesso capiscono istintivamente cosa c’è dietro i fili aggrovigliati e riconoscono ciò che Dio compie in modo creativo persino con i nostri errori.
199. Se camminiamo insieme, giovani e anziani, potremo essere ben radicati nel presente e, da questa posizione, frequentare il passato e il futuro: frequentare il passato, per imparare dalla storia e per guarire le ferite che a volte ci condizionano; frequentare il futuro, per alimentare l’entusiasmo, far germogliare i sogni, suscitare profezie, far fiorire le speranze. In questo modo, uniti, potremo imparare gli uni dagli altri, riscaldare i cuori, ispirare le nostre menti con la luce del Vangelo e dare nuova forza alle nostre mani.
200. Le radici non sono ancore che ci legano ad altre epoche e ci impediscono di incarnarci nel mondo attuale per far nascere qualcosa di nuovo. Sono, al contrario, un punto di radicamento che ci consente di crescere e di rispondere alle nuove sfide. Quindi, non serve neanche «che ci sediamo a ricordare con nostalgia i tempi passati; dobbiamo prenderci a cuore la nostra cultura con realismo e amore e riempirla di Vangelo. Siamo inviati oggi ad annunciare la Buona Novella di Gesù ai tempi nuovi. Dobbiamo amare il nostro tempo con le sue possibilità e i suoi rischi, con le sue gioie e i suoi dolori, con le sue ricchezze e i suoi limiti, con i suoi successi e i suoi errori».[110]
201. Nel Sinodo uno degli uditori, un giovane delle Isole Samoa, ha detto che la Chiesa è una canoa, in cui gli anziani aiutano a mantenere la rotta interpretando la posizione delle stelle e i giovani remano con forza immaginando ciò che li attende più in là. Non lasciamoci portare fuori strada né dai giovani che pensano che gli adulti siano un passato che non conta più, che è già superato, né dagli adulti che credono di sapere sempre come dovrebbero comportarsi i giovani. Piuttosto, saliamo tutti sulla stessa canoa e insieme cerchiamo un mondo migliore, sotto l’impulso sempre nuovo dello Spirito Santo.
CAPITOLO SETTIMO
La pastorale dei giovani
202. La pastorale giovanile, così come eravamo abituati a portarla avanti, ha subito l’assalto dei cambiamenti sociali e culturali. I giovani, nelle strutture consuete, spesso non trovano risposte alle loro inquietudini, alle loro esigenze, alle loro problematiche e alle loro ferite. La proliferazione e la crescita di associazioni e movimenti con caratteristiche prevalentemente giovanili possono essere interpretate come un’azione dello Spirito che apre nuove strade. È necessario, tuttavia, approfondire la loro partecipazione alla pastorale d’insieme della Chiesa, come pure una maggiore comunione tra loro entro un migliore coordinamento dell’azione. Anche se non è sempre facile accostare i giovani, stiamo crescendo su due aspetti: la consapevolezza che è l’intera comunità che li evangelizza e l’urgenza che i giovani siano più protagonisti nelle proposte pastorali.
Una pastorale sinodale
203. Voglio sottolineare che i giovani stessi sono attori della pastorale giovanile, accompagnati e guidati, ma liberi di trovare strade sempre nuove con creatività e audacia. Di conseguenza, sarebbe superfluo soffermarmi qui a proporre qualche sorta di manuale di pastorale giovanile o una guida pratica di pastorale. Si tratta piuttosto di fare ricorso all’astuzia, all’ingegno e alla conoscenza che i giovani stessi hanno della sensibilità, del linguaggio e delle problematiche degli altri giovani.
204. Essi ci mostrano la necessità di assumere nuovi stili e nuove strategie. Ad esempio, mentre gli adulti cercano di avere tutto programmato, con riunioni periodiche e orari fissi, oggi la maggior parte dei giovani si sente poco attratta da questi schemi pastorali. La pastorale giovanile ha bisogno di acquisire un’altra flessibilità e invitare i giovani ad avvenimenti che ogni tanto offrano loro un luogo dove non solo ricevano una formazione, ma che permetta loro anche di condividere la vita, festeggiare, cantare, ascoltare testimonianze concrete e sperimentare l’incontro comunitario con il Dio vivente.
205. D’altra parte, sarebbe molto auspicabile raccogliere ancora di più le buone pratiche: quelle metodologie, quei linguaggi, quelle motivazioni che sono risultati effettivamente attraenti per avvicinare i giovani a Cristo e alla Chiesa. Non importa di che colore siano, se “conservatori o progressisti”, se “di destra o di sinistra”. L’importante è raccogliere tutto ciò che ha dato buoni risultati e che sia efficace per comunicare la gioia del Vangelo.
206. La pastorale giovanile non può che essere sinodale, vale a dire capace di dar forma a un “camminare insieme” che implica una «valorizzazione dei carismi che lo Spirito dona secondo la vocazione e il ruolo di ciascuno dei membri [della Chiesa], attraverso un dinamismo di corresponsabilità. […] Animati da questo spirito, potremo procedere verso una Chiesa partecipativa e corresponsabile, capace di valorizzare la ricchezza della varietà di cui si compone, accogliendo con gratitudine anche l’apporto dei fedeli laici, tra cui giovani e donne, quello della vita consacrata femminile e maschile, e quello di gruppi, associazioni e movimenti. Nessuno deve essere messo o potersi mettere in disparte».[111]
207. In questo modo, imparando gli uni dagli altri, potremo riflettere meglio quel meraviglioso poliedro che dev’essere la Chiesa di Gesù Cristo. Essa può attrarre i giovani proprio perché non è un’unità monolitica, ma una rete di svariati doni che lo Spirito riversa incessantemente in essa, rendendola sempre nuova nonostante le sue miserie.
208. Al Sinodo sono emerse molte proposte concrete volte a rinnovare la pastorale giovanile e liberarla da schemi che non sono più efficaci perché non entrano in dialogo con la cultura attuale dei giovani. È chiaro che non mi sarebbe possibile raccoglierle tutte qui; alcune di esse si possono trovare nel Documento Finale del Sinodo.
Grandi linee d’azione
209. Vorrei solo sottolineare brevemente che la pastorale giovanile comporta due grandi linee d’azione. Una è la ricerca, l’invito, la chiamata che attiri nuovi giovani verso l’esperienza del Signore. L’altra è la crescita, lo sviluppo di un percorso di maturazione di chi ha già vissuto quell’esperienza.
210. Per quanto riguarda il primo punto, la ricerca, confido nella capacità dei giovani stessi, che sanno trovare le vie attraenti per invitare. Sanno organizzare festival, competizioni sportive, e sanno anche evangelizzare nelle reti sociali con messaggi, canzoni, video e altri interventi. Dobbiamo soltanto stimolare i giovani e dare loro libertà di azione perché si entusiasmino alla missione negli ambienti giovanili. Il primo annuncio può risvegliare una profonda esperienza di fede durante un “ritiro di impatto”, in una conversazione al bar, in un momento di pausa nella facoltà, o attraverso una delle insondabili vie di Dio. Ma la cosa più importante è che ogni giovane trovi il coraggio di seminare il primo annuncio in quella terra fertile che è il cuore di un altro giovane.
211. In questa ricerca va privilegiato il linguaggio della vicinanza, il linguaggio dell’amore disinteressato, relazionale ed esistenziale che tocca il cuore, raggiunge la vita, risveglia speranza e desideri. Bisogna avvicinarsi ai giovani con la grammatica dell’amore, non con il proselitismo. Il linguaggio che i giovani comprendono è quello di coloro che danno la vita, che sono lì a causa loro e per loro, e di coloro che, nonostante i propri limiti e le proprie debolezze, si sforzano di vivere la fede in modo coerente. Allo stesso tempo, dobbiamo ancora ricercare con maggiore sensibilità come incarnare il kerygma nel linguaggio dei giovani d’oggi.
212. Per quanto riguarda la crescita, vorrei dare un avvertimento importante. In alcuni luoghi accade che, dopo aver provocato nei giovani un’intensa esperienza di Dio, un incontro con Gesù che ha toccato il loro cuore, vengono loro proposti incontri di “formazione” nei quali si affrontano solo questioni dottrinali e morali: sui mali del mondo di oggi, sulla Chiesa, sulla dottrina sociale, sulla castità, sul matrimonio, sul controllo delle nascite e su altri temi. Il risultato è che molti giovani si annoiano, perdono il fuoco dell’incontro con Cristo e la gioia di seguirlo, molti abbandonano il cammino e altri diventano tristi e negativi. Plachiamo l’ansia di trasmettere una gran quantità di contenuti dottrinali e, soprattutto, cerchiamo di suscitare e radicare le grandi esperienze che sostengono la vita cristiana. Come diceva Romano Guardini: «Nell’esperienza di un grande amore […] tutto ciò che accade diventa un avvenimento nel suo ambito».[112]
213. Qualsiasi progetto formativo, qualsiasi percorso di crescita per i giovani, deve certamente includere una formazione dottrinale e morale. È altrettanto importante che sia centrato su due assi principali: uno è l’approfondimento del kerygma, l’esperienza fondante dell’incontro con Dio attraverso Cristo morto e risorto. L’altro è la crescita nell’amore fraterno, nella vita comunitaria, nel servizio.
214. Ho insistito molto su questo in Evangelii gaudium e penso che sia opportuno ricordarlo. Da un lato, sarebbe un grave errore pensare che nella pastorale giovanile «il kerygma venga abbandonato a favore di una formazione che si presupporrebbe essere più “solida”. Non c’è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente e di più saggio di tale annuncio. Tutta la formazione cristiana è prima di tutto l’approfondimento del kerygma che va facendosi carne sempre più e sempre meglio».[113] Pertanto, la pastorale giovanile dovrebbe sempre includere momenti che aiutino a rinnovare e ad approfondire l’esperienza personale dell’amore di Dio e di Gesù Cristo vivo. Lo farà attingendo a varie risorse: testimonianze, canti, momenti di adorazione, spazi di riflessione spirituale con la Sacra Scrittura, e anche con vari stimoli attraverso le reti sociali. Ma questa gioiosa esperienza di incontro con il Signore non deve mai essere sostituita da una sorta di “indottrinamento”.
215. D’altra parte, qualunque piano di pastorale giovanile deve chiaramente incorporare vari mezzi e risorse per aiutare i giovani a crescere nella fraternità, a vivere come fratelli, ad aiutarsi a vicenda, a fare comunità, a servire gli altri, ad essere vicini ai poveri. Se l’amore fraterno è il «comandamento nuovo» (Gv 13,34), se è la «pienezza della Legge» (Rm 13,10), se è ciò che meglio manifesta il nostro amore per Dio, allora deve occupare un posto rilevante in ogni piano di formazione e di crescita dei giovani.
Ambienti adeguati
216. In tutte le nostre istituzioni dobbiamo sviluppare e potenziare molto di più la nostra capacità di accoglienza cordiale, perché molti giovani che arrivano si trovano in una profonda situazione di orfanezza. E non mi riferisco a determinati conflitti familiari, ma ad un’esperienza che riguarda allo stesso modo bambini, giovani e adulti, madri, padri e figli. Per tanti orfani e orfane nostri contemporanei – forse per noi stessi – le comunità come la parrocchia e la scuola dovrebbero offrire percorsi di amore gratuito e promozione, di affermazione e crescita. Molti giovani oggi si sentono figli del fallimento, perché i sogni dei loro genitori e dei loro nonni sono bruciati sul rogo dell’ingiustizia, della violenza sociale, del “si salvi chi può”. Quanto sradicamento! Se i giovani sono cresciuti in un mondo di ceneri, non è facile per loro sostenere il fuoco di grandi desideri e progetti. Se sono cresciuti in un deserto vuoto di significato, come potranno aver voglia di sacrificarsi per seminare? L’esperienza di discontinuità, di sradicamento e la caduta delle certezze di base, favorita dall’odierna cultura mediatica, provocano quella sensazione di profonda orfanezza alla quale dobbiamo rispondere creando spazi fraterni e attraenti dove si viva con un senso.
217. Fare “casa” in definitiva «è fare famiglia; è imparare a sentirsi uniti agli altri al di là di vincoli utilitaristici o funzionali, uniti in modo da sentire la vita un po’ più umana. Creare casa è permettere che la profezia prenda corpo e renda le nostre ore e i nostri giorni meno inospitali, meno indifferenti e anonimi. È creare legami che si costruiscono con gesti semplici, quotidiani e che tutti possiamo compiere. Una casa, lo sappiamo tutti molto bene, ha bisogno della collaborazione di tutti. Nessuno può essere indifferente o estraneo, perché ognuno è una pietra necessaria alla sua costruzione. Questo implica il chiedere al Signore che ci dia la grazia di imparare ad aver pazienza, di imparare a perdonarci; imparare ogni giorno a ricominciare. E quante volte perdonare e ricominciare? Settanta volte sette, tutte quelle che sono necessarie. Creare relazioni forti esige la fiducia che si alimenta ogni giorno di pazienza e di perdono. E così si attua il miracolo di sperimentare che qui si nasce di nuovo; qui tutti nasciamo di nuovo perché sentiamo efficace la carezza di Dio che ci rende possibile sognare il mondo più umano e, perciò, più divino».[114]
218. In questo quadro, nelle nostre istituzioni dobbiamo offrire ai giovani luoghi appropriati, che essi possano gestire a loro piacimento e dove possano entrare e uscire liberamente, luoghi che li accolgano e dove possano recarsi spontaneamente e con fiducia per incontrare altri giovani sia nei momenti di sofferenza o di noia, sia quando desiderano festeggiare le loro gioie. Qualcosa del genere hanno realizzato alcuni oratori e altri centri giovanili, che in molti casi sono l’ambiente in cui i giovani vivono esperienze di amicizia e di innamoramento, dove si ritrovano, possono condividere musica, attività ricreative, sport, e anche la riflessione e la preghiera, con piccoli sussidi e diverse proposte. In questo modo si fa strada quell’indispensabile annuncio da persona a persona, che non può essere sostituito da nessuna risorsa o strategia pastorale.
219. «L’amicizia e il confronto, spesso anche in gruppi più o meno strutturati, offre l’opportunità di rafforzare competenze sociali e relazionali in un contesto in cui non si è valutati e giudicati. L’esperienza di gruppo costituisce anche una grande risorsa per la condivisione della fede e per l’aiuto reciproco nella testimonianza. I giovani sono capaci di guidare altri giovani e di vivere un vero apostolato in mezzo ai propri amici».[115]
220. Questo non significa che si isolino e perdano ogni contatto con le comunità parrocchiali, i movimenti e le altre istituzioni ecclesiali. Essi però si inseriranno meglio in comunità aperte, vive nella fede, desiderose di irradiare Gesù Cristo, gioiose, libere, fraterne e impegnate. Queste comunità possono essere i canali in cui loro sentono che è possibile coltivare relazioni preziose.
La pastorale delle istituzioni educative
221. La scuola è senza dubbio una piattaforma per avvicinarsi ai bambini e ai giovani. Essa è luogo privilegiato di promozione della persona, e per questo la comunità cristiana ha sempre avuto per essa grande attenzione, sia formando docenti e dirigenti, sia istituendo proprie scuole, di ogni genere e grado. In questo campo lo Spirito ha suscitato innumerevoli carismi e testimonianze di santità. Tuttavia, la scuola ha bisogno di una urgente autocritica, se si considerano i risultati della pastorale di molte istituzioni educative, una pastorale concentrata sull’istruzione religiosa che risulta spesso incapace di suscitare esperienze di fede durature. Inoltre, ci sono alcune scuole cattoliche che sembrano essere organizzate solo per conservare l’esistente. La fobia del cambiamento le rende incapaci di sopportare l’incertezza e le spinge a chiudersi di fronte ai pericoli, reali o immaginari, che ogni cambiamento porta con sé. La scuola trasformata in un “bunker” che protegge dagli errori “di fuori” è l’espressione caricaturale di questa tendenza. Questa immagine riflette in modo provocatorio ciò che sperimentano molti giovani al momento della loro uscita da alcuni istituti educativi: un’insormontabile discrepanza tra ciò che hanno loro insegnato e il mondo in cui si trovano a vivere. Anche le proposte religiose e morali che hanno ricevuto non li hanno preparati a confrontarle con un mondo che le ridicolizza, e non hanno imparato modi di pregare e di vivere la fede che possano essere facilmente sostenuti in mezzo al ritmo di questa società. In realtà, una delle gioie più grandi di un educatore consiste nel vedere un allievo che si costituisce come una persona forte, integrata, protagonista e capace di dare.
222. La scuola cattolica continua ad essere essenziale come spazio di evangelizzazione dei giovani. È importante tener conto di alcuni criteri ispiratori indicati nella Costituzione apostolica Veritatis gaudium in vista di un rinnovamento e rilancio delle scuole e delle università “in uscita” missionaria, quali: l’esperienza del kerygma, il dialogo a tutti i livelli, l’interdisciplinarietà e la transdisciplinarietà, la promozione della cultura dell’incontro, l’urgente necessità di “fare rete” e l’opzione per gli ultimi, per coloro che la società scarta e getta via.[116] E anche la capacità di integrare i saperi della testa, del cuore e delle mani.
223. D’altra parte, non possiamo separare la formazione spirituale dalla formazione culturale. La Chiesa ha sempre voluto sviluppare per i giovani spazi per la migliore cultura. Non deve rinunciarvi, perché i giovani ne hanno diritto. «Oggi specialmente, diritto alla cultura significa tutelare la sapienza, cioè un sapere umano e umanizzante. Troppo spesso si è condizionati da modelli di vita banali ed effimeri, che spingono a perseguire il successo a basso costo, screditando il sacrificio, inculcando l’idea che lo studio non serve se non dà subito qualcosa di concreto. No, lo studio serve a porsi domande, a non farsi anestetizzare dalla banalità, a cercare senso nella vita. È da rivendicare il diritto a non far prevalere le tante sirene che oggi distolgono da questa ricerca. Ulisse, per non cedere al canto delle sirene, che ammaliavano i marinai e li facevano sfracellare contro gli scogli, si legò all’albero della nave e turò gli orecchi dei compagni di viaggio. Invece Orfeo, per contrastare il canto delle sirene, fece qualcos’altro: intonò una melodia più bella, che incantò le sirene. Ecco il vostro grande compito: rispondere ai ritornelli paralizzanti del consumismo culturale con scelte dinamiche e forti, con la ricerca, la conoscenza e la condivisione».[117]
Diversi ambiti di sviluppo pastorale
224. Molti giovani sono capaci di imparare a gustare il silenzio e l’intimità con Dio. Sono aumentati anche i gruppi che si riuniscono per adorare il Santissimo Sacramento e per pregare con la Parola di Dio. Non bisogna sottovalutare i giovani come se fossero incapaci di aprirsi a proposte contemplative. Occorre solo trovare gli stili e le modalità appropriati per aiutarli a introdursi in questa esperienza di così alto valore. Per quanto riguarda gli ambiti del culto e della preghiera, «in diversi contesti i giovani cattolici chiedono proposte di preghiera e momenti sacramentali capaci di intercettare la loro vita quotidiana in una liturgia fresca, autentica e gioiosa».[118] È importante valorizzare i momenti più forti dell’anno liturgico, in particolare la Settimana Santa, la Pentecoste e il Natale. A loro piacciono molto anche altri incontri di festa, che spezzano la routine e aiutano a sperimentare la gioia della fede.
225. Un’opportunità privilegiata per la crescita e anche per l’apertura al dono divino della fede e della carità è il servizio: molti giovani si sentono attratti dalla possibilità di aiutare gli altri, specialmente i bambini e i poveri. Spesso questo servizio rappresenta il primo passo per scoprire o riscoprire la vita cristiana ed ecclesiale. Molti giovani si stancano dei nostri programmi di formazione dottrinale e anche spirituale, e a volte rivendicano la possibilità di essere più protagonisti in attività che facciano qualcosa per la gente.
226. Non possiamo dimenticare le espressioni artistiche, come il teatro, la pittura e altre. «Del tutto peculiare è l’importanza della musica, che rappresenta un vero e proprio ambiente in cui i giovani sono costantemente immersi, come pure una cultura e un linguaggio capaci di suscitare emozioni e di plasmare l’identità. Il linguaggio musicale rappresenta anche una risorsa pastorale, che interpella in particolare la liturgia e il suo rinnovamento».[119] Il canto può essere un grande stimolo per il percorso dei giovani. Diceva Sant’Agostino: «Canta, ma cammina; allevia con il canto il tuo lavoro, non amare la pigrizia: canta e cammina. […] Tu, se avanzi, cammini; però avanza nel bene, nella retta fede, nelle buone opere: canta e cammina».[120]
227. «Altrettanto significativo è il rilievo che tra i giovani assume la pratica sportiva, di cui la Chiesa non deve sottovalutare le potenzialità in chiave educativa e formativa, mantenendo una solida presenza al suo interno. Il mondo dello sport ha bisogno di essere aiutato a superare le ambiguità da cui è percorso, quali la mitizzazione dei campioni, l’asservimento a logiche commerciali e l’ideologia del successo a ogni costo».[121] Alla base dell’esperienza sportiva c’è «la gioia: la gioia di muoversi, la gioia di stare insieme, la gioia per la vita e per i doni che il Creatore ci fa ogni giorno».[122] D’altra parte, alcuni Padri della Chiesa hanno utilizzato l’esempio delle pratiche sportive per invitare i giovani a crescere in termini di forza e a padroneggiare la sonnolenza o la comodità. San Basilio Magno, rivolgendosi ai giovani, prendeva l’esempio dello sforzo richiesto dallo sport e così inculcava in loro la capacità di sacrificarsi per crescere nelle virtù: «Dopo essersi imposti mille e mille sacrifici per accrescere con tutti i mezzi la loro forza fisica, sudando nei faticosi esercizi della palestra, […] e, per farla breve, dopo aver fatto in modo che tutto il periodo che precede la grande prova non sia che una preparazione, […] danno fondo a tutte le loro risorse fisiche e psichiche, pur di guadagnare una corona […]. E noi che ci attendiamo, nell’altra vita, premi così straordinari che nessuna lingua può degnamente descrivere, pensiamo forse di poterli raggiungere passando la vita tra le mollezze e nell’inerzia?».[123]
228. In molti adolescenti e giovani suscita speciale attrazione il contatto con il creato e sono sensibili alla salvaguardia dell’ambiente, come nel caso degli scout e di altri gruppi che organizzano giornate in mezzo alla natura, campeggi, passeggiate, escursioni e campagne ambientaliste. Nello spirito di San Francesco d’Assisi, queste sono esperienze che possono tracciare un cammino per introdursi alla scuola della fraternità universale e alla preghiera contemplativa.
229. Queste e altre diverse possibilità che si aprono all’evangelizzazione dei giovani non devono farci dimenticare che, al di là dei cambiamenti della storia e della sensibilità dei giovani, ci sono doni di Dio che sono sempre attuali, che contengono una forza che trascende tutte le epoche e tutte le circostanze: la Parola del Signore sempre viva ed efficace, la presenza di Cristo nell’Eucaristia che ci nutre, il Sacramento del perdono che ci libera e ci fortifica. Possiamo anche menzionare l’inesauribile ricchezza spirituale che la Chiesa conserva nella testimonianza dei suoi santi e nell’insegnamento dei grandi maestri spirituali. Anche se dobbiamo rispettare le diverse fasi e a volte dobbiamo aspettare con pazienza il momento giusto, non possiamo non invitare i giovani a queste sorgenti di vita nuova, non abbiamo il diritto di privarli di tanto bene.
Una pastorale giovanile popolare
230. Oltre al consueto lavoro pastorale che realizzano le parrocchie e i movimenti, secondo determinati schemi, è molto importante dare spazio a una “pastorale giovanile popolare”, che ha un altro stile, altri tempi, un altro ritmo, un’altra metodologia. Consiste in una pastorale più ampia e flessibile che stimoli, nei diversi luoghi in cui si muovono concretamente i giovani, quelle guide naturali e quei carismi che lo Spirito Santo ha già seminato tra loro. Si tratta prima di tutto di non porre tanti ostacoli, norme, controlli e inquadramenti obbligatori a quei giovani credenti che sono leader naturali nei quartieri e nei diversi ambienti. Dobbiamo limitarci ad accompagnarli e stimolarli, confidando un po’ di più nella fantasia dello Spirito Santo che agisce come vuole.
231. Parliamo di leader realmente “popolari”, non elitari o chiusi in piccoli gruppi di eletti. Perché siano capaci di dar vita a una pastorale popolare nel mondo dei giovani, occorre che «imparino a percepire i sentimenti della gente, a farsi suoi portavoce e a lavorare per la sua promozione».[124] Quando parliamo di “popolo” non si deve intendere le strutture della società o della Chiesa, quanto piuttosto l’insieme di persone che non camminano come individui ma come il tessuto di una comunità di tutti e per tutti, che non può permettere che i più poveri e i più deboli rimangano indietro: «Il popolo vuole che tutti partecipino dei beni comuni e per questo accetta di adattarsi al passo degli ultimi per arrivare tutti insieme».[125] I leader popolari, quindi, sono coloro che hanno la capacità di coinvolgere tutti, includendo nel cammino giovanile i più poveri, deboli, limitati e feriti. Non provano disagio né sono spaventati dai giovani piagati e crocifissi.
232. In questa stessa linea, specialmente con i giovani che non sono cresciuti in famiglie o istituzioni cristiane, e sono in un cammino di lenta maturazione, dobbiamo stimolare il bene possibile.[126] Cristo ci ha avvertito di non pretendere che tutto sia solo grano (cfr Mt 13,24-30). A volte, per pretendere una pastorale giovanile asettica, pura, caratterizzata da idee astratte, lontana dal mondo e preservata da ogni macchia, riduciamo il Vangelo a una proposta insipida, incomprensibile, lontana, separata dalle culture giovanili e adatta solo ad un’élite giovanile cristiana che si sente diversa, ma che in realtà galleggia in un isolamento senza vita né fecondità. Così, insieme alla zizzania che rifiutiamo, sradichiamo o soffochiamo migliaia di germogli che cercano di crescere in mezzo ai limiti.
233. Invece di «soffocarli con un insieme di regole che danno del cristianesimo un’immagine riduttiva e moralistica, siamo chiamati a investire sulla loro audacia ed educarli ad assumersi le loro responsabilità, certi che anche l’errore, il fallimento e la crisi sono esperienze che possono rafforzare la loro umanità».[127]
234. Nel Sinodo si è esortato a costruire una pastorale giovanile capace di creare spazi inclusivi, dove ci sia posto per ogni tipo di giovani e dove si manifesti realmente che siamo una Chiesa con le porte aperte. E non è nemmeno necessario che uno accetti completamente tutti gli insegnamenti della Chiesa per poter partecipare ad alcuni dei nostri spazi dedicati ai giovani. Basta un atteggiamento aperto verso tutti quelli che hanno il desiderio e la disponibilità a lasciarsi incontrare dalla verità rivelata da Dio. Alcune proposte pastorali possono richiedere di aver già percorso un certo cammino di fede, ma abbiamo bisogno di una pastorale giovanile popolare che apra le porte e dia spazio a tutti e a ciascuno con i loro dubbi, traumi, problemi e la loro ricerca di identità, con i loro errori, storie, esperienze del peccato e tutte le loro difficoltà.
235. Deve esserci spazio anche per «tutti quelli che hanno altre visioni della vita, professano altre fedi o si dichiarano estranei all’orizzonte religioso. Tutti i giovani, nessuno escluso, sono nel cuore di Dio e quindi anche nel cuore della Chiesa. Riconosciamo però francamente che non sempre questa affermazione che risuona sulle nostre labbra trova reale espressione nella nostra azione pastorale: spesso restiamo chiusi nei nostri ambienti, dove la loro voce non arriva, o ci dedichiamo ad attività meno esigenti e più gratificanti, soffocando quella sana inquietudine pastorale che ci fa uscire dalle nostre presunte sicurezze. Eppure il Vangelo ci chiede di osare e vogliamo farlo senza presunzione e senza fare proselitismo, testimoniando l’amore del Signore e tendendo la mano a tutti i giovani del mondo».[128]
236. La pastorale giovanile, quando smette di essere elitaria e accetta di essere “popolare”, è un processo lento, rispettoso, paziente, fiducioso, instancabile, compassionevole. Nel Sinodo è stato proposto l’esempio dei discepoli di Emmaus (cfr Lc 24,13-35), che può essere anche modello di quanto avviene nella pastorale giovanile.
237. «Gesù cammina con i due discepoli che non hanno compreso il senso della sua vicenda e si stanno allontanando da Gerusalemme e dalla comunità. Per stare in loro compagnia, percorre la strada con loro. Li interroga e si mette in paziente ascolto della loro versione dei fatti per aiutarli a riconoscere quanto stanno vivendo. Poi, con affetto ed energia, annuncia loro la Parola, conducendoli a interpretare alla luce delle Scritture gli eventi che hanno vissuto. Accetta l’invito a fermarsi presso di loro al calar della sera: entra nella loro notte. Nell’ascolto il loro cuore si riscalda e la loro mente si illumina, nella frazione del pane i loro occhi si aprono. Sono loro stessi a scegliere di riprendere senza indugio il cammino in direzione opposta, per ritornare alla comunità, condividendo l’esperienza dell’incontro con il Risorto».[129]
238. Le diverse manifestazioni della pietà popolare, specialmente i pellegrinaggi, attirano giovani che non si inseriscono facilmente nelle strutture ecclesiali, e sono un’espressione concreta della fiducia in Dio. Queste forme di ricerca di Dio, presenti particolarmente nei giovani più poveri, ma anche negli altri settori della società, non devono essere disprezzate, ma incoraggiate e stimolate. Perché la pietà popolare «è un modo legittimo di vivere la fede»[130] ed è «espressione dell’azione missionaria spontanea del popolo di Dio».[131]
Sempre missionari
239. Voglio ricordare che non è necessario fare un lungo percorso perché i giovani diventino missionari. Anche i più deboli, limitati e feriti possono esserlo a modo loro, perché bisogna sempre permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità. Un giovane che va in pellegrinaggio per chiedere aiuto alla Madonna e invita un amico o un compagno ad accompagnarlo, con questo semplice gesto sta compiendo una preziosa azione missionaria. Insieme alla pastorale giovanile popolare è presente, inseparabilmente, una missione popolare, incontrollabile, che rompe tutti gli schemi ecclesiastici. Accompagniamola, incoraggiamola, ma non pretendiamo di regolarla troppo.
240. Se sappiamo ascoltare quello che ci sta dicendo lo Spirito, non possiamo ignorare che la pastorale giovanile dev’essere sempre una pastorale missionaria. I giovani si arricchiscono molto quando superano la timidezza e trovano il coraggio di andare a visitare le case, e in questo modo entrano in contatto con la vita delle persone, imparano a guardare al di là della propria famiglia e del proprio gruppo, cominciano a capire la vita in una prospettiva più ampia. Nello stesso tempo, la loro fede e il loro senso di appartenenza alla Chiesa si rafforzano. Le missioni giovanili, che di solito vengono organizzate durante i periodi di vacanza dopo un periodo di preparazione, possono suscitare un rinnovamento dell’esperienza di fede e anche seri approcci vocazionali.
241. I giovani, però, sono capaci di creare nuove forme di missione, negli ambiti più diversi. Per esempio, dal momento che si muovono così bene nelle reti sociali, bisogna coinvolgerli perché le riempiano di Dio, di fraternità, di impegno.
L’accompagnamento da parte degli adulti
242. I giovani hanno bisogno di essere rispettati nella loro libertà, ma hanno bisogno anche di essere accompagnati. La famiglia dovrebbe essere il primo spazio di accompagnamento. La pastorale giovanile propone un progetto di vita basato su Cristo: la costruzione di una casa, di una famiglia costruita sulla roccia (cfr Mt 7,24-25). Quella famiglia, quel progetto, per la maggior parte di loro si concretizzerà nel matrimonio e nella carità coniugale. Per questo è necessario che la pastorale giovanile e la pastorale familiare stiano in una continuità naturale, operando in modo coordinato e integrato per poter accompagnare adeguatamente il processo vocazionale.
243. La comunità svolge un ruolo molto importante nell’accompagnamento dei giovani, ed è la comunità intera che deve sentirsi responsabile di accoglierli, motivarli, incoraggiarli e stimolarli. Ciò implica che i giovani siano guardati con comprensione, stima e affetto, e che non li si giudichi continuamente o si esiga da loro una perfezione che non corrisponde alla loro età.
244. Nel Sinodo «molti hanno rilevato la carenza di persone esperte e dedicate all’accompagnamento. Credere al valore teologico e pastorale dell’ascolto implica un ripensamento per rinnovare le forme con cui ordinariamente il ministero presbiterale si esprime e una verifica delle sue priorità. Inoltre il Sinodo riconosce la necessità di preparare consacrati e laici, uomini e donne, che siano qualificati per l’accompagnamento dei giovani. Il carisma dell’ascolto che lo Spirito Santo fa sorgere nelle comunità potrebbe anche ricevere una forma di riconoscimento istituzionale per il servizio ecclesiale».[132]
245. Inoltre, bisogna accompagnare specialmente i giovani che si presentano come potenziali leader, in modo che possano formarsi e prepararsi. I giovani che si sono riuniti prima del Sinodo hanno chiesto che si sviluppino «nuovi programmi di leadership per la formazione e lo sviluppo continuo di giovani guide. Alcune giovani donne percepiscono una mancanza di figure di riferimento femminili all’interno della Chiesa, alla quale anch’esse desiderano donare i loro talenti intellettuali e professionali. Riteniamo inoltre che seminaristi e religiosi dovrebbero essere ancor più capaci di accompagnare i giovani che ricoprono tali ruoli di responsabilità».[133]
246. I giovani stessi ci hanno descritto quali sono le caratteristiche che sperano di trovare in chi li accompagna, e lo hanno espresso molto chiaramente: «Un simile accompagnatore dovrebbe possedere alcune qualità: essere un cristiano fedele impegnato nella Chiesa e nel mondo; essere in continua ricerca della santità; essere un confidente che non giudica; ascoltare attivamente i bisogni dei giovani e dare risposte adeguate; essere pieno d’amore e di consapevolezza di sé; riconoscere i propri limiti ed essere esperto delle gioie e dei dolori della vita spirituale. Una qualità di primaria importanza negli accompagnatori è il riconoscimento della propria umanità, ovvero che sono esseri umani e che quindi sbagliano: non persone perfette, ma peccatori perdonati. A volte gli accompagnatori vengono messi su un piedistallo, e la loro caduta può avere effetti devastanti sulla capacità dei giovani di continuare ad impegnarsi nella Chiesa. Gli accompagnatori non dovrebbero guidare i giovani come se questi fossero seguaci passivi, ma camminare al loro fianco, consentendo loro di essere partecipanti attivi del cammino. Dovrebbero rispettare la libertà che fa parte del processo di discernimento di un giovane, fornendo gli strumenti per compierlo al meglio. Un accompagnatore dovrebbe essere profondamente convinto della capacità di un giovane di prendere parte alla vita della Chiesa. Un accompagnatore dovrebbe coltivare i semi della fede nei giovani, senza aspettarsi di vedere immediatamente i frutti dell’opera dello Spirito Santo. Il ruolo di accompagnatore non è e non può essere riservato solo a sacerdoti e a persone consacrate, ma anche i laici dovrebbero essere messi in condizione di ricoprirlo. Tutti gli accompagnatori dovrebbero ricevere una solida formazione di base e impegnarsi nella formazione permanente».[134]
247. Senza dubbio le istituzioni educative della Chiesa sono un ambiente comunitario di accompagnamento che permette di orientare molti giovani, soprattutto quando «cercano di accogliere tutti i giovani, indipendentemente dalle loro scelte religiose, provenienza culturale e situazione personale, familiare o sociale. In questo modo la Chiesa dà un apporto fondamentale all’educazione integrale dei giovani nelle più diverse parti del mondo».[135] Ridurrebbero indebitamente la loro funzione se stabilissero criteri rigidi per l’ammissione degli studenti o per la loro permanenza, perché priverebbero molti giovani di un accompagnamento che li aiuterebbe ad arricchire la loro vita.
CAPITOLO OTTAVO
La vocazione
248. La parola “vocazione” può essere intesa in senso ampio, come chiamata di Dio. Comprende la chiamata alla vita, la chiamata all’amicizia con Lui, la chiamata alla santità, e così via. Questo ha un grande valore, perché colloca tutta la nostra vita di fronte a quel Dio che ci ama e ci permette di capire che nulla è frutto di un caos senza senso, ma al contrario tutto può essere inserito in un cammino di risposta al Signore, che ha un progetto stupendo per noi.
249. Nell’Esortazione Gaudete et exsultate ho voluto soffermarmi sulla vocazione di tutti a crescere per la gloria di Dio, e mi sono proposto di «far risuonare ancora una volta la chiamata alla santità, cercando di incarnarla nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità».[136] Il Concilio Vaticano II ci ha aiutato a rinnovare la consapevolezza di questa chiamata rivolta ad ognuno: «Tutti i fedeli d’ogni stato e condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, a una santità, la cui perfezione è quella stessa del Padre celeste».[137]
La chiamata all’amicizia con Lui
250. La cosa fondamentale è discernere e scoprire che ciò che vuole Gesù da ogni giovane è prima di tutto la sua amicizia. Questo è il discernimento fondamentale. Nel dialogo del Signore risorto con il suo amico Simon Pietro, la grande domanda era: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» (Gv 21,16). In altre parole: mi vuoi come amico? La missione che Pietro riceve di prendersi cura delle sue pecore e degli agnelli sarà sempre in relazione a questo amore gratuito, a questo amore di amicizia.
251. E, se fosse necessario un esempio nel senso contrario, ricordiamo l’incontro-scontro tra il Signore e il giovane ricco, che ci dice chiaramente come ciò che quel giovane non aveva colto era lo sguardo amorevole del Signore (cfr Mc 10,21). Se ne andò rattristato, dopo aver seguito una buona ispirazione, perché non era riuscito a staccarsi dalle molte cose che possedeva (cfr Mt 19,22). Perse l’occasione di quella che sicuramente avrebbe potuto essere una grande amicizia. E noi rimaniamo senza sapere che cosa avrebbe potuto essere per noi, che cosa avrebbe potuto fare per l’umanità quel giovane unico che Gesù aveva guardato con amore e al quale aveva teso la mano.
252. Perché «la vita che Gesù ci dona è una storia d’amore, una storia di vita che desidera mescolarsi con la nostra e mettere radici nella terra di ognuno. Quella vita non è una salvezza appesa “nella nuvola” in attesa di venire scaricata, né una nuova “applicazione” da scoprire o un esercizio mentale frutto di tecniche di crescita personale. Neppure la vita che Dio ci offre è un tutorial con cui apprendere l’ultima novità. La salvezza che Dio ci dona è un invito a far parte di una storia d’amore che si intreccia con le nostre storie; che vive e vuole nascere tra noi perché possiamo dare frutto lì dove siamo, come siamo e con chi siamo. Lì viene il Signore a piantare e a piantarsi».[138]
Il tuo essere per gli altri
253. Vorrei ora soffermarmi sulla vocazione intesa nel senso specifico della chiamata al servizio missionario verso gli altri. Siamo chiamati dal Signore a partecipare alla sua opera creatrice, offrendo il nostro contributo al bene comune sulla base delle capacità che abbiamo ricevuto.
254. Questa vocazione missionaria riguarda il nostro servizio agli altri. Perché la nostra vita sulla terra raggiunge la sua pienezza quando si trasforma in offerta. Ricordo che «la missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento che mi posso togliere, non è un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo».[139] Di conseguenza, dobbiamo pensare che ogni pastorale è vocazionale, ogni formazione è vocazionale e ogni spiritualità è vocazionale.
255. La tua vocazione non consiste solo nelle attività che devi fare, anche se si esprime in esse. È qualcosa di più, è un percorso che orienterà molti sforzi e molte azioni verso una direzione di servizio. Per questo, nel discernimento di una vocazione è importante vedere se uno riconosce in se stesso le capacità necessarie per quel servizio specifico alla società.
256. Questo dà un valore molto grande a tali compiti, perché essi smettono di essere una somma di azioni che si compiono per guadagnare denaro, per essere occupati o per compiacere gli altri. Tutto questo costituisce una vocazione perché siamo chiamati, c’è qualcosa di più di una mera scelta pragmatica da parte nostra. In definitiva, si tratta di riconoscere per che cosa sono fatto, per che cosa passo da questa terra, qual è il piano del Signore per la mia vita. Egli non mi indicherà tutti i luoghi, i tempi e i dettagli, che io sceglierò con prudenza, ma certamente ci sarà un orientamento della mia vita che Egli deve indicarmi perché è il mio Creatore, il mio vasaio, e io ho bisogno di ascoltare la sua voce per lasciarmi plasmare e portare da Lui. Allora sarò ciò che devo essere e sarò anche fedele alla mia realtà personale.
257. Per realizzare la propria vocazione è necessario sviluppare, far germogliare e coltivare tutto ciò che si è. Non si tratta di inventarsi, di creare sé stessi dal nulla, ma di scoprirsi alla luce di Dio e far fiorire il proprio essere: «Nel disegno di Dio, ogni uomo è chiamato a uno sviluppo, perché ogni vita è vocazione».[140] La tua vocazione ti orienta a tirare fuori il meglio di te stesso per la gloria di Dio e per il bene degli altri. Non si tratta solo di fare delle cose, ma di farle con un significato, con un orientamento. A questo proposito, Sant’Alberto Hurtado diceva ai giovani che devono prendere molto sul serio la rotta: «In una nave, il pilota negligente viene licenziato in tronco, perché quello che ha in mano è troppo sacro. E nella vita, noi stiamo attenti alla nostra rotta? Qual è la tua rotta? Se fosse necessario soffermarsi un po’ di più su questa idea, chiedo a ciascuno di voi di attribuirle la massima importanza, perché riuscire in questo equivale semplicemente ad avere successo; fallire in questo equivale semplicemente a fallire».[141]
258. Questo “essere per gli altri” nella vita di ogni giovane è normalmente collegato a due questioni fondamentali: la formazione di una nuova famiglia e il lavoro. I diversi sondaggi effettuati tra i giovani confermano ancora una volta che questi sono i due grandi temi per cui nutrono desideri e preoccupazioni. Entrambi devono essere oggetto di uno speciale discernimento. Soffermiamoci brevemente su di essi.
L’amore e la famiglia
259. I giovani sentono fortemente la chiamata all’amore e sognano di incontrare la persona giusta con cui formare una famiglia e costruire una vita insieme. Senza dubbio è una vocazione che Dio stesso propone attraverso i sentimenti, i desideri, i sogni. Su questo tema mi sono soffermato a lungo nell’Esortazione Amoris laetitia e invito tutti i giovani a leggere in particolare i capitoli 4 e 5.
260. Mi piace pensare che «due cristiani che si sposano hanno riconosciuto nella loro storia di amore la chiamata del Signore, la vocazione a formare di due, maschio e femmina, una sola carne, una sola vita. E il Sacramento del matrimonio avvolge questo amore con la grazia di Dio, lo radica in Dio stesso. Con questo dono, con la certezza di questa chiamata, si può partire sicuri, non si ha paura di nulla, si può affrontare tutto, insieme!».[142]
261. In questo contesto, ricordo che Dio ci ha creati sessuati. Egli stesso «ha creato la sessualità, che è un regalo meraviglioso per le sue creature».[143] All’interno della vocazione al matrimonio, dobbiamo riconoscere ed essere grati per il fatto che «la sessualità, il sesso, è un dono di Dio. Niente tabù. È un dono di Dio, un dono che il Signore ci dà. Ha due scopi: amarsi e generare vita. È una passione, è l’amore appassionato. Il vero amore è appassionato. L’amore fra un uomo e una donna, quando è appassionato, ti porta a dare la vita per sempre. Sempre. E a darla con il corpo e l’anima».[144]
262. Il Sinodo ha sottolineato che «la famiglia continua a rappresentare il principale punto di riferimento per i giovani. I figli apprezzano l’amore e la cura da parte dei genitori, hanno a cuore i legami familiari e sperano di riuscire a formare a loro volta una famiglia. Indubbiamente l’aumento di separazioni, divorzi, seconde unioni e famiglie monoparentali può causare nei giovani grandi sofferenze e crisi d’identità. Talora devono farsi carico di responsabilità che non sono proporzionate alla loro età e li costringono a divenire adulti prima del tempo. I nonni offrono spesso un contributo decisivo nell’affetto e nell’educazione religiosa: con la loro saggezza sono un anello decisivo nel rapporto tra le generazioni».[145]
263. Queste difficoltà incontrate nella famiglia di origine portano certamente molti giovani a chiedersi se vale la pena formare una nuova famiglia, essere fedeli, essere generosi. Voglio dirvi di sì, che vale la pena scommettere sulla famiglia e che in essa troverete gli stimoli migliori per maturare e le gioie più belle da condividere. Non lasciate che vi rubino la possibilità di amare sul serio. Non fatevi ingannare da coloro che propongono una vita di sregolatezza individualistica che finisce per portare all’isolamento e alla peggiore solitudine.
264. Oggi regna una cultura del provvisorio che è un’illusione. Credere che nulla può essere definitivo è un inganno e una menzogna. Molte volte «c’è chi dice che oggi il matrimonio è “fuori moda”. […] Nella cultura del provvisorio, del relativo, molti predicano che l’importante è “godere” il momento, che non vale la pena di impegnarsi per tutta la vita, di fare scelte definitive. […] Io, invece, vi chiedo di essere rivoluzionari, vi chiedo di andare controcorrente; sì, in questo vi chiedo di ribellarvi a questa cultura del provvisorio, che, in fondo, crede che voi non siate in grado di assumervi responsabilità, crede che voi non siate capaci di amare veramente».[146] Io invece ho fiducia in voi, per questo vi incoraggio a scegliere il matrimonio.
265. Al matrimonio bisogna prepararsi, e questo richiede di educare sé stessi, di sviluppare le migliori virtù, specialmente l’amore, la pazienza, la capacità di dialogo e di servizio. Implica anche educare la propria sessualità, in modo che sia sempre meno uno strumento per usare gli altri e sempre più una capacità di donarsi pienamente a una persona in modo esclusivo e generoso.
266. I Vescovi della Colombia ci hanno insegnato che «Cristo sa che gli sposi non sono perfetti e che hanno bisogno di superare la loro debolezza e incostanza perché il loro amore possa crescere e durare nel tempo. Per questo, concede ai coniugi la sua grazia che è, allo stesso tempo, luce e forza che permette loro di realizzare il loro progetto di vita matrimoniale in conformità con il piano di Dio».[147]
267. Per coloro che non sono chiamati al matrimonio o alla vita consacrata, occorre ricordare sempre che la prima e più importante vocazione è la vocazione battesimale. Le persone non sposate, anche non per scelta, possono diventare in modo particolare testimoni di tale vocazione nel loro cammino di crescita personale.
Il lavoro
268. I Vescovi degli Stati Uniti d’America hanno rilevato con chiarezza che la gioventù, una volta raggiunta la maggior età, «segna spesso l’ingresso di una persona nel mondo del lavoro. “Cosa fai per vivere?” è un argomento costante di conversazione, perché il lavoro è una parte molto importante della loro vita. Per i giovani adulti, questa esperienza è molto fluida perché passano da un lavoro all’altro e anche da una carriera all’altra. Il lavoro può definire l’uso del tempo e può determinare cosa possono fare o acquistare. Può anche determinare la qualità e la quantità del tempo libero. Il lavoro definisce e influenza l’identità e il concetto di sé di un giovane adulto ed è un luogo fondamentale dove si sviluppano le amicizie e altre relazioni, perché di solito non si lavora da soli. I giovani, uomini e donne, parlano del lavoro come adempimento di una funzione e come qualcosa che fornisce un significato. Permette ai giovani adulti di soddisfare le loro necessità pratiche, nonché – cosa ancora più importante – di cercare il senso e la realizzazione dei loro sogni e delle loro visioni. Anche se il lavoro potrebbe non aiutarli a realizzare i loro sogni, è importante per i giovani-adulti coltivare una visione, imparare a lavorare in un modo veramente personale e soddisfacente per la loro vita, e continuare a discernere la chiamata di Dio».[148]
269. Invito i giovani a non aspettarsi di vivere senza lavorare, dipendendo dall’aiuto degli altri. Questo non va bene, perché «il lavoro è una necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di realizzazione personale. In questo senso, aiutare i poveri con il denaro dev’essere sempre un rimedio provvisorio per fare fronte a delle emergenze».[149] Ne consegue che «la spiritualità cristiana, insieme con lo stupore contemplativo per le creature che troviamo in san Francesco d’Assisi, ha sviluppato anche una ricca e sana comprensione del lavoro, come possiamo riscontrare, per esempio, nella vita del beato Charles de Foucauld e dei suoi discepoli».[150]
270. Il Sinodo ha sottolineato che il mondo del lavoro è un ambito in cui i giovani «sperimentano forme di esclusione ed emarginazione. La prima e più grave è la disoccupazione giovanile, che in alcuni Paesi raggiunge livelli esorbitanti. Oltre a renderli poveri, la mancanza di lavoro recide nei giovani la capacità di sognare e di sperare e li priva della possibilità di dare un contributo allo sviluppo della società. In molti Paesi questa situazione dipende dal fatto che alcune fasce di popolazione giovanile sono sprovviste di adeguate capacità professionali, anche a causa dei deficit del sistema educativo e formativo. Spesso la precarietà occupazionale che affligge i giovani risponde agli interessi economici che sfruttano il lavoro».[151]
271. È una questione molto delicata che la politica deve considerare come una problematica prioritaria, in particolare oggi che la velocità degli sviluppi tecnologici, insieme all’ossessione per la riduzione del costo del lavoro, può portare rapidamente a sostituire innumerevoli posti di lavoro con macchinari. Si tratta di una questione fondamentale della società, perché il lavoro per un giovane non è semplicemente un’attività finalizzata a produrre un reddito. È un’espressione della dignità umana, è un cammino di maturazione e di inserimento sociale, è uno stimolo costante a crescere in termini di responsabilità e di creatività, è una protezione contro la tendenza all’individualismo e alla comodità, ed è anche dar gloria a Dio attraverso lo sviluppo delle proprie capacità.
272. Non sempre un giovane ha la possibilità di decidere a che cosa dedicare i suoi sforzi, per quali compiti spendere le sue energie e la sua capacità di innovazione. Perché, al di là dei propri desideri e molto al di là delle proprie capacità e del discernimento che una persona può maturare, ci sono i duri limiti della realtà. È vero che non puoi vivere senza lavorare e che a volte dovrai accettare quello che trovi, ma non rinunciare mai ai tuoi sogni, non seppellire mai definitivamente una vocazione, non darti mai per vinto. Continua sempre a cercare, come minimo, modalità parziali o imperfette di vivere ciò che nel tuo discernimento riconosci come un’autentica vocazione.
273. Quando uno scopre che Dio lo chiama a qualcosa, che è fatto per questo – può essere l’infermieristica, la falegnameria, la comunicazione, l’ingegneria, l’insegnamento, l’arte o qualsiasi altro lavoro – allora sarà capace di far sbocciare le sue migliori capacità di sacrificio, generosità e dedizione. Sapere che non si fanno le cose tanto per farle, ma con un significato, come risposta a una chiamata che risuona nel più profondo del proprio essere per dare qualcosa agli altri, fa sì che queste attività offrano al proprio cuore un’esperienza speciale di pienezza. Questo è ciò che diceva l’antico libro biblico del Qoèlet: «Mi sono accorto che nulla c’è di meglio per l’uomo che godere delle sue opere» (3,22).
Vocazioni a una consacrazione speciale
274. Se partiamo dalla convinzione che lo Spirito continua a suscitare vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa, possiamo “gettare di nuovo le reti” nel nome del Signore, con piena fiducia. Possiamo – e dobbiamo – avere il coraggio di dire ad ogni giovane di interrogarsi sulla possibilità di seguire questa strada.
275. Alcune volte ho fatto questa proposta a dei giovani, che mi hanno risposto quasi in tono beffardo dicendo: «No, veramente io non vado in quella direzione». Tuttavia, anni dopo alcuni di loro erano in Seminario. Il Signore non può venir meno alla sua promessa di non lasciare la Chiesa priva dei pastori, senza i quali non potrebbe vivere né svolgere la sua missione. E se alcuni sacerdoti non danno una buona testimonianza, non per questo il Signore smetterà di chiamare. Al contrario, Egli raddoppia la posta, perché non cessa di prendersi cura della sua amata Chiesa.
276. Nel discernimento di una vocazione non si deve escludere la possibilità di consacrarsi a Dio nel sacerdozio, nella vita religiosa o in altre forme di consacrazione. Perché escluderlo? Abbi la certezza che, se riconosci una chiamata di Dio e la segui, ciò sarà la cosa che darà pienezza alla tua vita.
277. Gesù cammina in mezzo a noi come faceva in Galilea. Passa per le nostre strade, si ferma e ci guarda negli occhi, senza fretta. La sua chiamata è attraente, è affascinante. Oggi, però, l’ansia e la velocità di tanti stimoli che ci bombardano fanno sì che non ci sia spazio per quel silenzio interiore in cui si percepisce lo sguardo di Gesù e si ascolta la sua chiamata. Nel frattempo, riceverai molte proposte ben confezionate, che si presentano belle e intense, ma con il tempo ti lasceranno svuotato, stanco e solo. Non lasciare che questo ti accada, perché il turbine di questo mondo ti trascina in una corsa senza senso, senza orientamento, senza obiettivi chiari, e così molti tuoi sforzi andranno sprecati. Cerca piuttosto quegli spazi di calma e di silenzio che ti permettano di riflettere, di pregare, di guardare meglio il mondo che ti circonda, e a quel punto, insieme a Gesù, potrai riconoscere quale è la tua vocazione in questa terra.
CAPITOLO NONO
Il discernimento
278. Sul discernimento in generale, mi sono già soffermato nell’Esortazione apostolica Gaudete et exsultate. Permettetemi di riprendere alcune di quelle riflessioni applicandole al discernimento della propria vocazione nel mondo.
279. Ricordo che tutti, ma «specialmente i giovani, sono esposti a uno zapping costante. È possibile navigare su due o tre schermi simultaneamente e interagire nello stesso tempo in diversi scenari virtuali. Senza la sapienza del discernimento possiamo trasformarci facilmente in burattini alla mercé delle tendenze del momento».[152] E «questo risulta particolarmente importante quando compare una novità nella propria vita, e dunque bisogna discernere se sia il vino nuovo che viene da Dio o una novità ingannatrice dello spirito del mondo o dello spirito del diavolo».[153]
280. Questo discernimento, «anche se include la ragione e la prudenza, le supera, perché si tratta di intravedere il mistero del progetto unico e irripetibile che Dio ha per ciascuno. […] È in gioco il senso della mia vita davanti al Padre che mi conosce e mi ama, quello vero, per il quale io possa dare la mia esistenza, e che nessuno conosce meglio di Lui».[154]
281. È in questo quadro che si colloca la formazione della coscienza, che permette che il discernimento cresca in termini di profondità e di fedeltà a Dio: «Formare la coscienza è il cammino di tutta la vita in cui si impara a nutrire gli stessi sentimenti di Gesù Cristo assumendo i criteri delle sue scelte e le intenzioni del suo agire (cfr Fil 2,5)».[155]
282. Questa formazione implica il lasciarsi trasformare da Cristo e allo stesso tempo «una pratica abituale del bene, verificata nell’esame della coscienza: un esercizio in cui non si tratta solo di identificare i peccati, ma anche di riconoscere l’opera di Dio nella propria esperienza quotidiana, nelle vicende della storia e delle culture in cui si è inseriti, nella testimonianza di tanti altri uomini e donne che ci hanno preceduto o ci accompagnano con la loro saggezza. Tutto ciò aiuta a crescere nella virtù della prudenza, articolando l’orientamento globale dell’esistenza con le scelte concrete, nella serena consapevolezza dei propri doni e dei propri limiti».[156]
Come discernere la tua vocazione
283. Un’espressione del discernimento è l’impegno per riconoscere la propria vocazione. È un compito che richiede spazi di solitudine e di silenzio, perché si tratta di una decisione molto personale che nessun altro può prendere al nostro posto: «Anche se il Signore ci parla in modi assai diversi durante il nostro lavoro, attraverso gli altri e in ogni momento, non è possibile prescindere dal silenzio della preghiera prolungata per percepire meglio quel linguaggio, per interpretare il significato reale delle ispirazioni che pensiamo di aver ricevuto, per calmare le ansie e ricomporre l’insieme della propria esistenza alla luce di Dio».[157]
284. Questo silenzio non è una forma di isolamento, perché «occorre ricordare che il discernimento orante richiede di partire da una disposizione ad ascoltare: il Signore, gli altri, la realtà stessa che sempre ci interpella in nuovi modi. Solamente chi è disposto ad ascoltare ha la libertà di rinunciare al proprio punto di vista parziale e insufficiente. […] Così è realmente disponibile ad accogliere una chiamata che rompe le sue sicurezze ma che lo porta a una vita migliore, perché non basta che tutto vada bene, che tutto sia tranquillo. Può essere che Dio ci stia offrendo qualcosa di più, e nella nostra pigra distrazione non lo riconosciamo».[158]
285. Quando si tratta di discernere la propria vocazione, è necessario porsi varie domande. Non si deve iniziare chiedendosi dove si potrebbe guadagnare di più, o dove si potrebbe ottenere più fama e prestigio sociale, ma non si dovrebbe nemmeno cominciare chiedendosi quali compiti ci darebbero più piacere. Per non sbagliarsi, occorre cambiare prospettiva e chiedersi: io conosco me stesso, al di là delle apparenze e delle mie sensazioni? So che cosa dà gioia al mio cuore e che cosa lo intristisce? Quali sono i miei punti di forza e i miei punti deboli? Seguono immediatamente altre domande: come posso servire meglio ed essere più utile al mondo e alla Chiesa? Qual è il mio posto su questa terra? Cosa potrei offrire io alla società? Ne seguono altre molto realistiche: ho le capacità necessarie per prestare quel servizio? Oppure, potrei acquisirle e svilupparle?
286. Queste domande devono essere poste non tanto in relazione a sé stessi e alle proprie inclinazioni, ma piuttosto in relazione agli altri, nei loro confronti, in modo tale che il discernimento imposti la propria vita in riferimento agli altri. Per questo voglio ricordare qual è la grande domanda: «Tante volte, nella vita, perdiamo tempo a domandarci: “Ma chi sono io?”. Tu puoi domandarti chi sei tu e fare tutta una vita cercando chi sei tu. Ma domandati: “Per chi sono io?”».[159] Tu sei per Dio, senza dubbio. Ma Lui ha voluto che tu sia anche per gli altri, e ha posto in te molte qualità, inclinazioni, doni e carismi che non sono per te, ma per gli altri.
La chiamata dell’Amico
287. Per discernere la propria vocazione, bisogna riconoscere che essa è la chiamata di un amico: Gesù. Agli amici, quando si fa un regalo, si regala il meglio. E questo non è necessariamente la cosa più costosa o difficile da procurare, ma quella che sappiamo darà gioia all’altro. Un amico ha una percezione così chiara di questo, che può visualizzare nella sua immaginazione il sorriso dell’amico mentre apre il suo regalo. Questo discernimento di amicizia è quello che propongo ai giovani come modello se vogliono capire qual è la volontà di Dio per la loro vita.
288. Voglio che sappiate che quando il Signore pensa ad ognuno, a quello che vorrebbe regalargli, pensa a lui come un suo amico personale. E se ha deciso di regalarti una grazia, un carisma che ti farà vivere la tua vita in pienezza e ti trasformerà in una persona utile per gli altri, in qualcuno che lasci un’impronta nella storia, sarà sicuramente qualcosa che ti renderà felice nel più intimo e ti entusiasmerà più di ogni altra cosa in questo mondo. Non perché quello che sta per darti sia un carisma straordinario o raro, ma perché sarà giusto su misura per te, su misura di tutta la tua vita.
289. Il regalo della vocazione sarà senza dubbio un regalo esigente. I regali di Dio sono interattivi e per goderli bisogna mettersi molto in gioco, bisogna rischiare. Tuttavia, non sarà l’esigenza di un dovere imposto da un altro dall’esterno, ma qualcosa che ti stimolerà a crescere e a fare delle scelte perché questo regalo maturi e diventi un dono per gli altri. Quando il Signore suscita una vocazione, pensa non solo a quello che sei, ma a tutto ciò che, insieme a Lui e agli altri, potrai diventare.
290. La potenza della vita e la forza della propria personalità si alimentano a vicenda all’interno di ogni giovane e lo spingono ad andare oltre ogni limite. L’inesperienza permette che questo scorra, anche se ben presto si trasforma in esperienza, tante volte dolorosa. È importante mettere in contatto questo desiderio dell’«infinito di quando non si è ancora provato a iniziare»[160] con l’amicizia incondizionata che Gesù ci offre. Prima di ogni legge e di ogni dovere, quello che Gesù ci propone di scegliere è un seguire, come quello degli amici che si seguono, si cercano e si trovano per pura amicizia. Tutto il resto viene dopo, e persino i fallimenti della vita potranno essere un’inestimabile esperienza di questa amicizia che non si rompe mai.
Ascolto e accompagnamento
291. Ci sono sacerdoti, religiosi, religiose, laici, professionisti e anche giovani qualificati che possono accompagnare i giovani nel loro discernimento vocazionale. Quando ci capita di aiutare un altro a discernere la strada della sua vita, la prima cosa è ascoltare. Questo ascolto presuppone tre sensibilità o attenzioni distinte e complementari.
292. La prima sensibilità o attenzione è alla persona. Si tratta di ascoltare l’altro che ci sta dando sé stesso nelle sue parole. Il segno di questo ascolto è il tempo che dedico all’altro. Non è una questione di quantità, ma che l’altro senta che il mio tempo è suo: il tempo di cui ha bisogno per esprimermi ciò che vuole. Deve sentire che lo ascolto incondizionatamente, senza offendermi, senza scandalizzarmi, senza irritarmi, senza stancarmi. Questo ascolto è quello che il Signore esercita quando si mette a camminare accanto ai discepoli di Emmaus e li accompagna per un bel pezzo lungo una strada che andava in direzione opposta a quella giusta (cfr Lc 24,13-35). Quando Gesù fa come se dovesse proseguire perché quei due sono arrivati a casa, allora capiscono che aveva donato loro il suo tempo, e a quel punto gli regalano il proprio, offrendogli ospitalità. Questo ascolto attento e disinteressato indica il valore che l’altra persona ha per noi, al di là delle sue idee e delle sue scelte di vita.
293. La seconda sensibilità o attenzione consiste nel discernere. Si tratta di cogliere il punto giusto in cui si discerne la grazia dalla tentazione. Perché a volte le cose che attraversano la nostra immaginazione sono solo tentazioni che ci allontanano dalla nostra vera strada. Qui devo domandarmi che cosa mi sta dicendo esattamente quella persona, che cosa mi vuole dire, che cosa desidera che io capisca di ciò che le sta succedendo. Sono domande che aiutano a capire come si agganciano fra loro gli argomenti che muovono l’altro e a sentire il peso e il ritmo dei suoi affetti influenzati da questa logica. Questo ascolto è volto a discernere le parole salvifiche dello Spirito buono, che ci propone la verità del Signore, ma anche le trappole dello spirito cattivo, i suoi inganni e le sue seduzioni. Bisogna avere il coraggio, l’affetto e la delicatezza necessari per aiutare l’altro a riconoscere la verità e gli inganni o i pretesti.
294. La terza sensibilità o attenzione consiste nell’ascoltare gli impulsi che l’altro sperimenta “in avanti”. È l’ascolto profondo di “dove vuole andare veramente l’altro”. Al di là di ciò che sente e pensa nel presente e di ciò che ha fatto nel passato, l’attenzione è rivolta a ciò che vorrebbe essere. A volte questo richiede che la persona non guardi tanto ciò che le piace, i suoi desideri superficiali, ma ciò che è più gradito al Signore, il suo progetto per la propria vita che si esprime in un’inclinazione del cuore, al di là della scorza dei gusti e dei sentimenti. Questo ascolto è attenzione all’intenzione ultima, che è quella che alla fine decide la vita, perché esiste Qualcuno come Gesù che comprende e apprezza questa intenzione ultima del cuore. Per questo Egli è sempre pronto ad aiutare ognuno a riconoscerla, e per questo gli basta che qualcuno gli dica: «Signore, salvami! Abbi misericordia di me!».
295. Solo allora il discernimento diventa uno strumento di impegno forte per seguire meglio il Signore.[161] In questo modo, il desiderio di riconoscere la propria vocazione acquista un’intensità suprema, una qualità differente e un livello superiore, che risponde molto meglio alla dignità della propria vita. Perché, in ultima analisi, un buon discernimento è un cammino di libertà che porta alla luce quella realtà unica di ogni persona, quella realtà che è così sua, così personale, che solo Dio la conosce. Gli altri non possono né comprendere pienamente né prevedere dall’esterno come si svilupperà.
296. Perciò, quando uno ascolta l’altro in questo modo, a un certo punto deve scomparire per lasciare che segua la strada che ha scoperto. Scomparire come scompare il Signore dalla vista dei suoi discepoli, lasciandoli soli con l’ardore del cuore, che si trasforma in impulso irresistibile a mettersi in cammino (cfr Lc 24,31-33). Al loro ritorno nella comunità, i discepoli di Emmaus riceveranno la conferma che il Signore è veramente risorto (cfr Lc 24,34).
297. Poiché «il tempo è superiore allo spazio»,[162] dobbiamo suscitare e accompagnare processi, non imporre percorsi. E si tratta di processi di persone che sono sempre uniche e libere. Per questo è difficile costruire ricettari, anche quando tutti i segni sono positivi, perché «si tratta di sottoporre gli stessi fattori positivi ad attento discernimento, perché non si isolino l’uno dall’altro e non vengano in contrasto tra loro, assolutizzandosi e combattendosi a vicenda. Altrettanto si dica dei fattori negativi: non sono da respingere in blocco e senza distinzioni, perché in ciascuno di essi può nascondersi un qualche valore, che attende di essere liberato e ricondotto alla sua verità piena».[163]
298. Ma per accompagnare gli altri in questo cammino, è necessario anzitutto che tu sia ben esercitato a percorrerlo in prima persona. Maria lo ha fatto, affrontando le proprie domande e le proprie difficoltà quando era molto giovane. Possa ella rinnovare la tua giovinezza con la forza della sua preghiera e accompagnarti sempre con la sua presenza di Madre.
* * *
E per concludere… un desiderio
299. Cari giovani, sarò felice nel vedervi correre più velocemente di chi è lento e timoroso. Correte «attratti da quel Volto tanto amato, che adoriamo nella santa Eucaristia e riconosciamo nella carne del fratello sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga in questa corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo bisogno! E quando arriverete dove noi non siamo ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci».[164]
Loreto, presso il Santuario della Santa Casa, 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione del Signore, dell’anno 2019, settimo del pontificato
FRANCESCO
[1] La stessa parola greca che significa “nuovo” viene usata per esprimere “giovane”.
[2] Confessioni, X, 27: PL 32, 795.
[3] Sant’Ireneo, Contro le eresie, II, 22, 4: PG 7, 784.
[4] Documento Finale della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 60. D’ora in poi questo documento verrà citato con la sigla DF. Lo si può trovare in http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20181027_doc-final-instrumentum-xvassemblea-giovani_it.html
[5] Catechismo della Chiesa Cattolica, 515.
[6] Ibid., 517.
[7] Catechesi (27 giugno 1990), 2-3: Insegnamenti 13, 1 (1990), 1680-1681.
[8] Esort. ap. postsin. Amoris laetitia (19 marzo 2016), 182: AAS 108 (2016), 384.
[9] DF 63.
[10] Messaggio all’umanità: Ai giovani (8 dicembre 1965): AAS 58 (1966), 18.
[11] Ibid.
[12] DF 1
[13] Ibid, 8.
[14] Ibid., 50.
[15] Ibid., 53.
[16] Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum, 8.
[17] DF 150.
[18] Discorso nella Veglia con i giovani alla XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù a Panama (26 gennaio 2019): L’Osservatore Romano, 28-29 gennaio 2019, 6.
[19] Preghiera al termine della Via Crucis della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù a Panama (25 gennaio 2019): L’Osservatore Romano, 27 gennaio 2019, 12.
[20] DF 65.
[21] Ibid., 167.
[22] S. Giovanni Paolo II, Discorso ai giovani a Torino (13 aprile 1980), 4: Insegnamenti 3, 1 (1980), 905.
[23] Benedetto XVI, Messaggio per la XXVII Giornata Mondiale della Gioventù (15 marzo 2012): AAS 104 (2012), 359.
[24] DF 8.
[25] Ibid.
[26] Ibid., 10.
[27] Ibid., 11.
[28] Ibid., 12.
[29] Ibid., 41.
[30] Ibid., 42.
[31] Discorso ai giovani a Manila (18 gennaio 2015): L’Osservatore Romano, 19-20 gennaio 2015, 7.
[32] DF 34.
[33] Documento della Riunione pre-sinodale in preparazione alla XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (24 marzo 2018), I, 1.
[34] DF 39.
[35] Ibid., 37.
[36] Cfr Lett. enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 106: AAS 107 (2015), 889-890.
[37] DF 37.
[38] Ibid., 67.
[39] Ibid., 21.
[40] Ibid., 22.
[41] Ibid., 23.
[42] Ibid., 24.
[43] Documento della Riunione pre-sinodale in preparazione alla XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (24 marzo 2018), I, 4.
[44] DF 25.
[45] Ibid.
[46] Ibid., 26.
[47] Ibid., 27.
[48] Ibid., 28.
[49] Ibid., 29.
[50] Discorso al termine dell’Incontro su “La protezione dei minori nella Chiesa” (24 febbraio 2019): L’Osservatore Romano, 25-26 febbraio 2019, 10.
[51] DF 29.
[52] Lettera al Popolo di Dio (20 agosto 2018), 2: L’Osservatore Romano, 20-21 agosto 2018, 7.
[53] DF 30.
[54] Discorso alla I Congregazione generale della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (3 ottobre 2018): L’Osservatore Romano, 5 ottobre 2018, 8.
[55] DF 31.
[56] Ibid.
[57] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 1.
[58] DF 31.
[59] Ibid., 31.
[60] Discorso al termine dell’Incontro su “La protezione dei minori nella Chiesa” (24 febbraio 2019): L’Osservatore Romano, 25-26 febbraio 2019, 11.
[61] Francisco Luis Bernárdez, “Soneto”, in Cielo de tierra, Buenos Aires, 1937.
[62] Esort. ap. Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), 140.
[63] Omelia nella Messa della XXXI Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia (31 luglio 2016): AAS 108 (2016), 923.
[64] Discorso nella cerimonia di apertura della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù a Panama (24 gennaio 2019): L’Osservatore Romano, 26 gennaio 2019, 12.
[65] Esort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 1: AAS 105 (2013), 1019.
[66] Ibid., 3: 1020.
[67] Discorso nella Veglia della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù a Panama (26 gennaio 2019): L’Osservatore Romano, 28-29 gennaio 2019, 6.
[68] Discorso nell’incontro con i giovani durante il Sinodo (6 ottobre 2018): L’Osservatore Romano, 8-9 ottobre 2018, 7.
[69] Benedetto XVI, Lett. enc. Deus caritas est (25 dicembre 2005), 1: AAS 98 (2006), 217.
[70] Pedro Arrupe, Enamórate.
[71] S. Paolo VI, Discorso per la beatificazione di Nunzio Sulprizio (1 dicembre 1963): AAS 56 (1964), 28.
[72] DF 65.
[73] Omelia nella Messa con i giovani a Sydney (2 dicembre 1970): AAS 63 (1971), 64.
[74] Confessioni, I, 1, 1: PL 32, 661.
[75] Dio è giovane. Una conversazione con Thomas Leoncini, Milano 2018, 16.
[76] DF 68.
[77] Discorso ai giovani a Cagliari (22 settembre 2013): AAS 105 (2013), 904-905.
[78] Cinque pani e due pesci. Dalla sofferenza del carcere una gioiosa testimonianza di fede, Milano 2014, 20.
[79] Conferenza Episcopale Svizzera, Prendre le temps: pour toi, pour moi, pour nous, 2 febbraio 2018.
[80] Cfr San Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae II-II, q. 23, art. 1.
[81] Discorso ai volontari della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù a Panama (27 gennaio 2019): L’Osservatore Romano, 28-29 gennaio 2019, 11.
[82] S. Oscar A. Romero, Omelia (6 novembre 1977): Su pensamiento, I-II, San Salvador 2000, 312.
[83] Discorso alla cerimonia di apertura della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù a Panama (24 gennaio 2019): L’Osservatore Romano, 26 gennaio 2019, 12.
[84] Cfr Incontro con i giovani nel Santuario Nazionale di Maipú, Santiago del Cile (17 gennaio 2018): L’Osservatore Romano, 19 gennaio 2018, 7.
[85] Cfr Romano Guardini, Le età della vita: Opera omnia IV/ 1, Brescia 2015, 209.
[86] Esort. ap. Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), 11.
[87] Cantico Spirituale B, Prologo, 2.
[88] Ibid., XIV-XV, 2.
[89] Conferenza Episcopale del Ruanda, Lettera dei Vescovi cattolici ai fedeli durante l’anno speciale della riconciliazione in Ruanda, Kigali (18 gennaio 2018), 17.
[90] Saluto ai giovani del Centro Culturale Padre Félix Varela all’Avana (20 settembre 2015): L’Osservatore Romano, 21-22 settembre 2015, 6.
[91] DF 46.
[92] Discorso nella Veglia della XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro (27 luglio 2013): AAS 105 (2013), 663.
[93] Ustedes son la luz del mundo, Discurso en el Cerro San Cristóbal, Chile, 1940: https://www.padrealbertohurtado.cl/escritos-2/.
[94] Omelia nella Messa della XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro (28 luglio 2013): AAS 105 (2013), 665.
[95] Conferenza Episcopale Cattolica di Corea, Lettera pastorale in occasione del 150° anniversario del martirio durante la persecuzione Byeong-in (30 marzo 2016).
[96] Cfr Omelia nella Messa per la XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù a Panama (27 gennaio 2019): L’Osservatore Romano, 28-29 gennaio 2019, 12.
[97] Preghiera “Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace”, ispirata a S. Francesco d’Assisi.
[98] Discorso nella Veglia della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù a Panama (26 gennaio 2019): L’Osservatore Romano, 28-29 gennaio 2019, 6.
[99] DF 14.
[100] Cfr Lett. enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 145: AAS 107 (2015), 906.
[101] Video-messaggio per l’Incontro mondiale dei giovani indigeni a Panama (17-21 gennaio 2019): L’Osservatore Romano, 19 gennaio 2019, 8.
[102] DF 35.
[103] Cfr Lettera ai giovani, I, 2: PG 31, 565.
[104] Cfr La saggezza del tempo. In dialogo con Papa Francesco sulle grandi questioni della vita. A cura di Antonio Spadaro, Venezia 2018.
[105] Ibid, 12.
[106] Ibid, 13.
[107] Ibid.
[108] Ibid.
[109] Ibid., 162-163.
[110] Eduardo Pironio, Messaggio ai giovani argentini nell’incontro nazionale giovanile a Cordoba (12-15 settembre 1985), 2.
[111] DF 123.
[112] L’essenza del cristianesimo, Brescia 1984, 12.
[113] N. 165: AAS 105 (2013), 1089.
[114] Discorso nella visita alla Casa del Buon Samaritano a Panama, (27 gennaio 2019): L’Osservatore Romano, 28-29 gennaio 2019, 10.
[115] DF 36.
[116] Cfr Cost. ap. Veritatis gaudium (8 dicembre 2017), 4: AAS 110 (2018), 7-8.
[117] Discorso nell’incontro con gli studenti e il mondo accademico in Piazza San Domenico a Bologna (1 ottobre 2017): AAS 109 (2017), 1115.
[118] DF 51.
[119] Ibid. 47.
[120] Sermo 256, 3: PL 38, 1193.
[121] DF 47.
[122] Discorso a una delegazione di “Special Olympics International” (16 febbraio 2017): L’Osservatore Romano, 17 febbraio 2017, 8.
[123] Lettera ai giovani, VIII, 11-12: PG 31, 580.
[124] Conferenza Episcopale Argentina, Declaración de San Miguel, Buenos Aires, 1969, X, 1.
[125] Rafael Tello, La nueva evangelización, Tomo II (Anexos I y II), Buenos Aires, 2013, 111.
[126] Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 44-45: AAS 105 (2013), 1038-1039.
[127] DF 70.
[128] Ibid., 117.
[129] Ibid., 4.
[130] Esort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 124: AAS 105 (2013), 1072.
[131] Ibid., 122: 1071.
[132] DF 9.
[133] Documento della Riunione pre-sinodale in preparazione alla XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (24 marzo 2018), 12.
[134] Ibid., 10.
[135] DF 15.
[136] N. 2.
[137] Cost. dogm. Lumen gentium, 11.
[138] Discorso nella Veglia con i giovani alla XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù a Panama (26 gennaio 2019): L’Osservatore Romano, 28-29 gennaio 2019, 6.
[139] Esort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 273: AAS 105 (2013), 1130.
[140] S. Paolo VI, Lett. enc. Populorum progressio (26 marzo 1967), 15: AAS 59 (1967), 265.
[141] Meditación de Semana Santa para jóvenes, scritta a bordo di una nave da carico, di ritorno dagli Stati Uniti, 1946: https://www.padrealbertohurtado.cl/escritos-2/.
[142] Incontro con i giovani dell’Umbria ad Assisi (4 ottobre 2013): AAS 105 (2013), 921.
[143] Esort. ap. postsin. Amoris laetitia (19 marzo 2016), 150: AAS 108 (2016), 369.
[144] Udienza ai giovani della diocesi di Grenoble-Vienne, Francia (17 settembre 2018): L’Osservatore Romano, 19 settembre 2018, 8.
[145] DF 32.
[146] Incontro con i volontari della XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro (28 luglio 2013): Insegnamenti, 1, 2 (2013), 125.
[147] Conferenza Episcopale della Colombia, Mensaje Cristiano sobre el matrimonio (14 maggio 1981).
[148] Conferenza episcopale degli stati uniti, Sons and Daughters of Light: A Pastoral Plan for Ministry with Young Adults, 12 novembre 1996, I, 3.
[149] Lett. enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 128: AAS 107 (2015), 898.
[150] Ibid., 125: 897.
[151] DF 40.
[152] Esort. ap. Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), 167.
[153] Ibid., 168.
[154] Ibid., 170.
[155] DF 108.
[156] Ibid.
[157] Esort. ap. Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), 171.
[158] Ibid., 172.
[159] Discorso nella Veglia di preghiera in preparazione alla XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, Basilica di S. Maria Maggiore, (8 aprile 2017): AAS 109 (2017), 447.
[160] Romano Guardini, Le età della vita: Opera omnia IV/ 1, Brescia 2015, 209.
[161] Cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), 169.
[162] Esort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 222: AAS 105 (2013), 1111.
[163] S. Giovanni Paolo II, Esort. ap. postsin. Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), 10: AAS 84 (1992), 672.
[164] Incontro e preghiera con i giovani italiani al Circo Massimo a Roma (11 agosto 2018): L’Osservatore Romano, 13-14 agosto 2018, 6.




















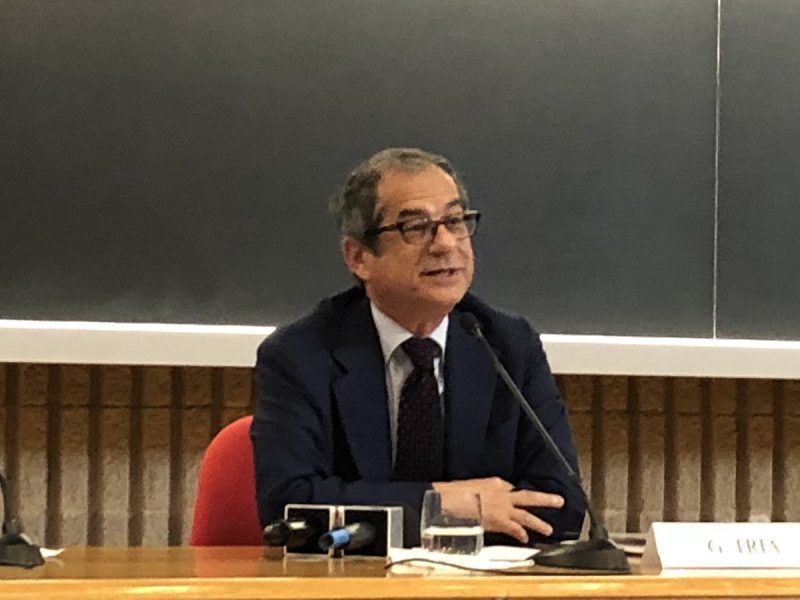
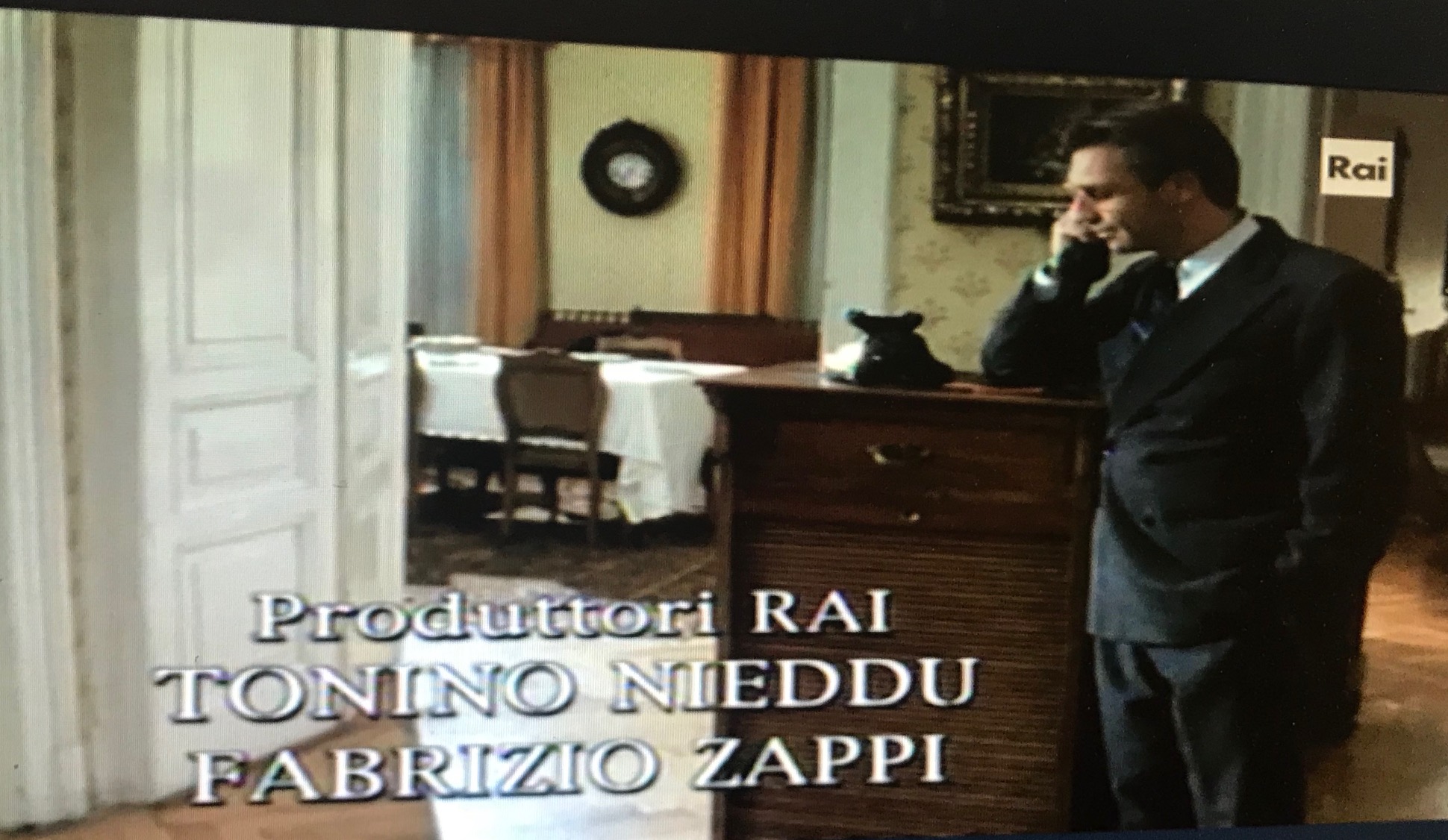


 In un miscuglio di sacro e profano, di cristianesimo e paganesimo, di ordine ed eccentricità, di simmetria e varietà. Ecco allora nel rarefatto interno i dodici medaglioni con la raffigurazione degli apostoli, ecco il bassorilievo con la Vergine (Sancta Maria de Aventinae fu eretta nel 936 dal monaco benedettino Oddone di Cluny nel luogo dove venne rinvenuta un’icona della Madonna); ecco in sequenza al centro del soffitto il “bricolage” tipicamente piranesiano che affianca San Giovanni Battista recante l’Agnus Dei, una croce greca sorretta da putti entro una cornice triangolare simbolo della Trinità ma anche segno massonico, la tunica indossata dai Cavalieri di Malta, la tiara papale e le chiavi incrociate. Ma ecco anche rimandi al mondo etrusco e all’Egitto, con le piccole sfingi che affiancano torri al culmine delle quattro lesene della facciata esterna; ecco i serpenti (il colle Aventino era chiamato Mons Serpentarius), e le palme e gli allori e i trofei romani e le aquile bicipiti, gli scudi, la nave a vela, i labari: accenni alla antica Roma e insieme alle vittorie per mare dei Cavalieri di Malta sui musulmani. Così riaffiora tutta la storia di questo luogo e del tempio, uno dei più ammirati della cristianità. Alberico II nel X secolo donò il terreno dove sorgono Villa e Chiesa a Odone di Cluny, che fondò qui un monastero fortificato (resistono i merli della muratura perimetrale, presidio che osserva dall’alto il biondo fiume). Il complesso passò poi all’Ordine dei Templari, i monaci combattenti a difesa di Gerusalemme e dei pellegrini là diretti. Ma, al loro scioglimento nel 1312, subentrò l’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme detti Ospedalieri – l’attuale Ordine di Malta – che nel 1566 stabilì il Priorato a Roma: e se nel giardino una scritta rammenta i Templari, nella Villa il Gran Maestro riceve capi di Stato, di Governo, Ambasciatori accreditati presso il Sovrano Ordine, mentre la chiesa resta luogo di culto ed è illuminata fastosamente nella notte del 24 giugno, il giorno dedicato al patrono San Giovanni Battista.
In un miscuglio di sacro e profano, di cristianesimo e paganesimo, di ordine ed eccentricità, di simmetria e varietà. Ecco allora nel rarefatto interno i dodici medaglioni con la raffigurazione degli apostoli, ecco il bassorilievo con la Vergine (Sancta Maria de Aventinae fu eretta nel 936 dal monaco benedettino Oddone di Cluny nel luogo dove venne rinvenuta un’icona della Madonna); ecco in sequenza al centro del soffitto il “bricolage” tipicamente piranesiano che affianca San Giovanni Battista recante l’Agnus Dei, una croce greca sorretta da putti entro una cornice triangolare simbolo della Trinità ma anche segno massonico, la tunica indossata dai Cavalieri di Malta, la tiara papale e le chiavi incrociate. Ma ecco anche rimandi al mondo etrusco e all’Egitto, con le piccole sfingi che affiancano torri al culmine delle quattro lesene della facciata esterna; ecco i serpenti (il colle Aventino era chiamato Mons Serpentarius), e le palme e gli allori e i trofei romani e le aquile bicipiti, gli scudi, la nave a vela, i labari: accenni alla antica Roma e insieme alle vittorie per mare dei Cavalieri di Malta sui musulmani. Così riaffiora tutta la storia di questo luogo e del tempio, uno dei più ammirati della cristianità. Alberico II nel X secolo donò il terreno dove sorgono Villa e Chiesa a Odone di Cluny, che fondò qui un monastero fortificato (resistono i merli della muratura perimetrale, presidio che osserva dall’alto il biondo fiume). Il complesso passò poi all’Ordine dei Templari, i monaci combattenti a difesa di Gerusalemme e dei pellegrini là diretti. Ma, al loro scioglimento nel 1312, subentrò l’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme detti Ospedalieri – l’attuale Ordine di Malta – che nel 1566 stabilì il Priorato a Roma: e se nel giardino una scritta rammenta i Templari, nella Villa il Gran Maestro riceve capi di Stato, di Governo, Ambasciatori accreditati presso il Sovrano Ordine, mentre la chiesa resta luogo di culto ed è illuminata fastosamente nella notte del 24 giugno, il giorno dedicato al patrono San Giovanni Battista. Fu un altro Giovanni Battista, il veneziano cardinal Rezzonico, Gran Priore dell’Ordine e nipote di papa Clemente XIII, a commissionare al Piranesi il rinnovamento della chiesa, della villa magistrale, dei giardini e della piazza antistante, enigmatica e affascinante nei piccoli obelischi. L’artista – «dal 1740 vive a Roma, ha formazione di vedutista canalettiano ma preferisce l’incisione alla pittura, è architetto ma costruisce una sola chiesa piccola e stupenda» scrisse Giulio Carlo Argan – concentra appunto in Santa Maria del Priorato l’estro visionario usando il linguaggio del barocco e del neoclassico («come il Palladio per le sue ville, poste tra acqua e cielo, egli pose la chiesa tra terra e cielo, sganciata dunque dalla Storia, in una atemporalità che è per questo quintessenza della modernità» ha osservato alla presentazione del restauro Francesco Moschini, architetto ai vertici dell’Accademia di San Luca). La contaminazione ideologica e di stili non piacque a molti dei contemporanei del Piranesi: un’opera prodotta dalla «testa di un matto, che non à nessun fondamento», si disse criticando le immagini ricorrenti all’interno e sulla facciata, i serpenti, i crani (simbolo di vanità, morte, vanagloria), le torce a testa in giù (anch’esse segno di morte nella cultura antica, così come per gli adepti del culto di Mitra). A tutto ciò pare pensare il Piranesi raffigurato in statua da Giuseppe Angelini sulla propria urna funeraria: ha la toga di antico romano, poggia il mento su una mano, reca sotto il braccio un cartiglio con la pianta del tempio di Poseidon a Paestum: perché fu durante il viaggio di ritorno dal mitico luogo che egli morì dopo aver contratto la malaria.
Fu un altro Giovanni Battista, il veneziano cardinal Rezzonico, Gran Priore dell’Ordine e nipote di papa Clemente XIII, a commissionare al Piranesi il rinnovamento della chiesa, della villa magistrale, dei giardini e della piazza antistante, enigmatica e affascinante nei piccoli obelischi. L’artista – «dal 1740 vive a Roma, ha formazione di vedutista canalettiano ma preferisce l’incisione alla pittura, è architetto ma costruisce una sola chiesa piccola e stupenda» scrisse Giulio Carlo Argan – concentra appunto in Santa Maria del Priorato l’estro visionario usando il linguaggio del barocco e del neoclassico («come il Palladio per le sue ville, poste tra acqua e cielo, egli pose la chiesa tra terra e cielo, sganciata dunque dalla Storia, in una atemporalità che è per questo quintessenza della modernità» ha osservato alla presentazione del restauro Francesco Moschini, architetto ai vertici dell’Accademia di San Luca). La contaminazione ideologica e di stili non piacque a molti dei contemporanei del Piranesi: un’opera prodotta dalla «testa di un matto, che non à nessun fondamento», si disse criticando le immagini ricorrenti all’interno e sulla facciata, i serpenti, i crani (simbolo di vanità, morte, vanagloria), le torce a testa in giù (anch’esse segno di morte nella cultura antica, così come per gli adepti del culto di Mitra). A tutto ciò pare pensare il Piranesi raffigurato in statua da Giuseppe Angelini sulla propria urna funeraria: ha la toga di antico romano, poggia il mento su una mano, reca sotto il braccio un cartiglio con la pianta del tempio di Poseidon a Paestum: perché fu durante il viaggio di ritorno dal mitico luogo che egli morì dopo aver contratto la malaria.